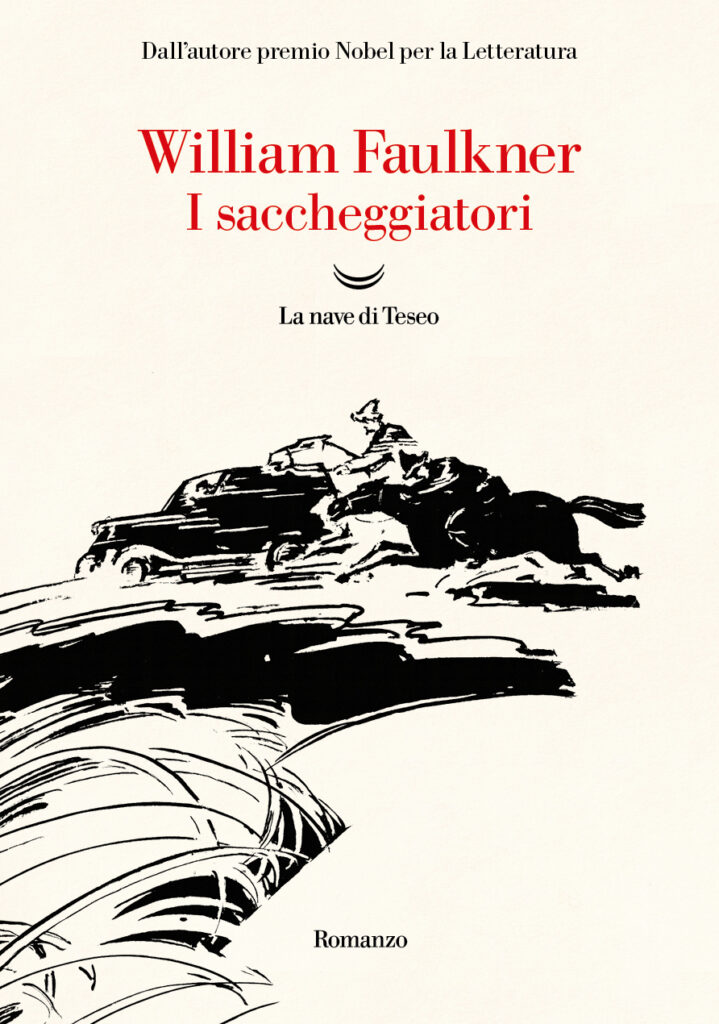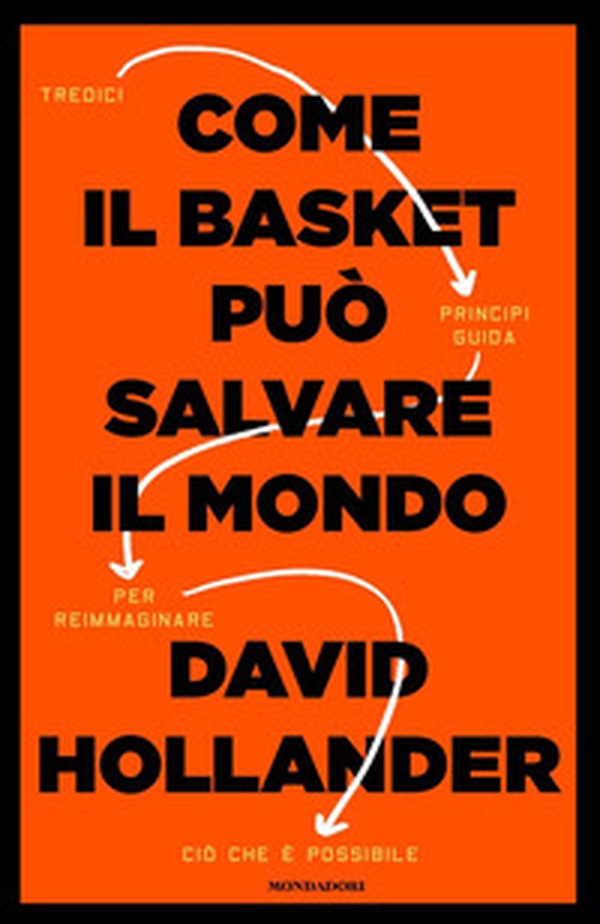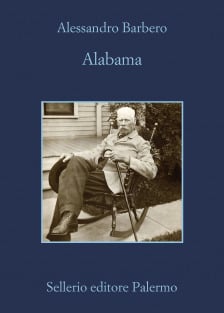
In una sorta di lungo monologo, interrotto solo dalle necessarie cadenze dei pasti e del riposo notturno, un anziano reduce della Guerra Civile americana racconta uno spezzone della sua esperienza bellica. È stimolato da una giovane studentessa universitaria. Lo ha trovato dopo una lunga ricerca: vuole sapere, dalla viva voce di un testimone diretto, se è vero, o meno, che, durante una certa battaglia, l’esercito sudista si è reso colpevole di un orrendo crimine di guerra nei confronti di un ampio gruppo di persone di colore. Di quei negri, cioè, che hanno osato prendere le armi contro i propri padroni. Non è un’intervista facile. Da un lato, infatti, il vecchio Dick Stanton si perde in aneddoti e storie di vario genere, e fatica ad arrivare al punto, che alla fine si rivela comunque in tutta la sua durezza. Dall’altro, poi, l’intervistatrice, che pure proviene dal sud, si sente a disagio, perché capisce di avere radici intrise nella stessa cultura. A leggere i commenti che alcuni lettori hanno lasciato sulle principali piattaforme di vendita online, si resta un po’ spiazzati. Non sono pochi – anche tra coloro che si dichiarano affezionati fans del Barbero storico e saggista – a esprimere una qualche delusione. I motivi della critica, per lo più, sono questi: la trattazione dell’eccidio teoricamente posto al centro della trama arriva troppo tardi; il resoconto in prima persona è prolisso, perché affidato al flusso di coscienza dell’ex soldato; i grandi temi sottesi alla dinamica dello schiavismo e del conflitto socio-economico vengono disciolti nei ricordi rapsodici della voce narrante; etc.
Ciò premesso, occorre affermare, invece, che Alabama è un testo assai riuscito. Chi, in Italia, volesse studiare la guerra di secessione in modo approfondito non potrebbe che prendersi l’ormai classico (ma equilibrato e assai completo) libro di Luraghi. Chi, viceversa, volesse immergersi in una prova letteraria sottilmente allusiva, ma non meno efficace – se si vuole anche a mera preparazione suggestiva di un successivo lavoro di scavo – dovrebbe sicuramente affidarsi a questo romanzo di Barbero. Che rievoca molto bene un contesto, una memoria, un’abitudine, un tessuto di credenze e di pratiche, facendolo, peraltro, con un andamento faulkneriano, in tutto e per tutto adatto al soggetto. Peraltro l’Autore non è mai indulgente, non segue – in altri termini – le posizioni (discusse, quanto argomentate) di Shelby Foote: in proposito, la lunga attesa dell’episodio centrale, disseminata da digressioni disorientanti, non è altro che un espediente per enfatizzare una climax, un crescente trascorrere all’evento per il tramite dello stratificarsi, via via più evidente e conseguente, suoi presupposti morali e materiali. Ma l’aspetto che più convince è il progredire del turbamento ambiguo della studentessa, con un’intenzione (propria dello scrittore) che vuole indirettamente spiegare anche a noi lettori, contemporanei, e come tali apparentemente lontani da quegli scenari, la genesi incrementale e apprenditiva dei sentimenti e delle azioni collettivi più oscuri e violenti. In definitiva, anche quando si cimenta con il genere del romanzo, Barbero non smette di raffigurare in modo convincente e performativo interi spaccati del passato. Dimostrando, in tal modo, che il suo segreto è una fortissima, e invidiabile, capacità di immedesimazione.