
Giacomo è un dottorando dell’Università Statale di Milano, affidato alla guida dell’autorevole Prof. Briola. Nel bel mezzo del lockdown per Covid-19, il rapporto tra il giovane giurista e lo studioso ormai in pensione si intensifica, pur nel contesto delle rispettive solitudini, interrotte dai numerosi collegamenti online che scandiscono le giornate. Giacomo deve calibrare e finalizzare la sua ricerca e Briola sente che quello scelto dal giovane studioso può essere un campo di indagine assai interessante. La tesi di Giacomo, infatti, si propone di verificare sia quanto la giurisprudenza precedente all’epoca delle grandi codificazioni costituisse patrimonio comune dei giudici europei, sia quanto essa abbia proiettato la sua influenza sulle interpretazioni successive. Sarà necessario rimettersi sulle tracce delle riflessioni avviate da Gino Gorla, uno dei più importanti e stimati comparatisti. Sicché Briola aiuta il ragazzo a procurarsi un po’ di volumi, facendoglieli spedire direttamente dalla sede dell’UNIDROIT, a Roma, dove è collocato anche un apposito fondo, contenente libri e documenti donati dallo stesso Gorla. È in quel voluminoso pacco che Giacomo fa una scoperta potenzialmente sensazionale. Vi rinviene, infatti, appunti autografi e inediti del famoso comparatista, con una lista sostanziosa, e ragionata, di casi giurisprudenziali tratti dalle decisioni di corti sparse per tutta l’Europa e operanti nel corso dell’Ottocento. La chance come il rischio di valorizzare espressamente un filone di ricerca così originale, ma minoritario, sono evidenti. Che cosa farà Giacomo? Sarà in grado il Prof. Briola di dargli il consiglio migliore? La conclusione non è per nulla scontata e a molti, anzi, potrà sembrare – senza alcuna contraddizione – tanto lucida e realistica quanto triste e spiazzante.
Questo è un romanzo atipico. Lo è, in primo luogo, per la tensione narrativa, che si carica nel susseguirsi di moltissime pagine, all’apparenza lente e sovrabbondanti, per poi sciogliersi in modo rapido, quasi contratto, nell’epilogo. Qualcosa evidentemente deve scatenarsi, come in una classica relazione tra potenza e atto, con un effetto che materialmente può dirsi drammatico e amaro. Ma l’atipicità si misura anche sul piano dell’oggetto: Obiter dicta – che per i giuristi è espressione tecnica e nota, e vale a identificare gli insegnamenti o i principi che sono occasionalmente espressi nelle sentenze, pur senza costituire la base delle relative decisioni – è un singolare esperimento di fiction accademica. Non, semplicemente, nel senso di un racconto ad ambientazione universitaria. Qui il tema è la ricerca stessa, con il suo disorientante apprendistato e con la strutturale incertezza esistenziale che avvince i suoi adepti, specie all’inizio del loro percorso. Anche se va aggiunto che la peculiarità è ulteriore: anzitutto, le vicende sono una scusa per divulgare qua e là, a mo’ di pensierose digressioni, frammenti ragionati di cultura giuridica; nello stesso tempo, poi, Annunziata non rinuncia al brivido dell’invenzione, mettendo in gioco ritrovamenti mai avvenuti o congetture tuttora non interamente dimostrate. Dunque si può dire molto, del diritto, anche per mezzo di un’opera di fantasia. Al di là di ciò c’è da segnalare un altro profilo, che contribuisce a spiegare l’andamento imperscrutabile di buona parte della narrazione. È l’isolamento dell’accademico, il suo usuale confinamento, che nel libro va ovviamente oltre il proscenio delle restrizioni legate alla pandemia. E di cui l’Autore riesce a mettere efficacemente in luce il peculiare, costante dis-equilibrio, tra vertigine del percorso scientifico personale e istanze di conformità e normalizzazione. D’altra parte – come il lettore potrà verificare – in Obiter dicta, come nel tragitto di ogni studioso, la vita è sempre la posta in gioco.
Recensione (di T. dalla Massara)



 Dopo la monumentale prova de
Dopo la monumentale prova de 
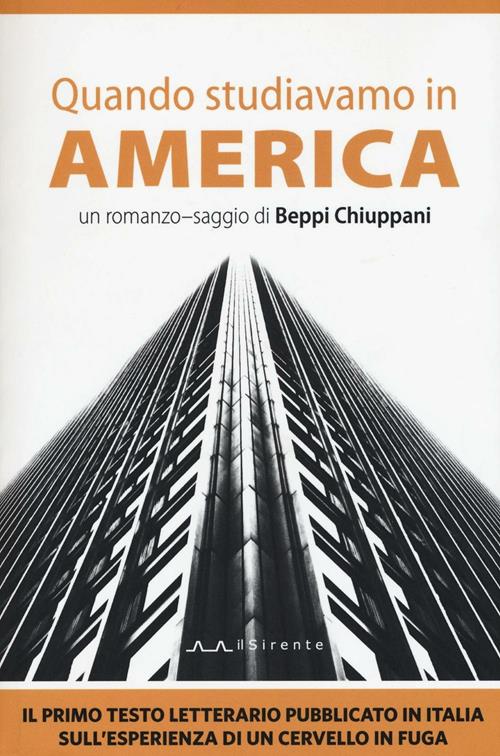 Marco ha studiato Lettere a Padova e poi, sfiduciato dalle prospettive che avrebbe potuto coltivare nell’accademia italiana, ha scelto di conseguire un PhD a Chicago. La sua storia viene ricostruita e raccontata da un amico, un altro italiano che si trovava negli Stati Uniti nello stesso periodo e per la stessa ragione, e che ora lavora a Milano. In principio Marco è rapito dal modello universitario americano, così lontano dal declino intellettuale e morale del suo Paese, e così capace di dare il meglio a chi voglia formarsi e perfezionarsi nello studio e nella ricerca. Anzi, a Marco pare addirittura che, oggi, tutte le sorti dell’umanesimo non possano che essere giocate in quel sistema, a suo giudizio l’unico contesto idoneo a riprodurre, nell’organizzazione degli spazi fisici del sapere come nella definizione e nell’applicazione delle regole della comunità scientifica, quell’ideale di serietà, rigore e approfondimento che può assicurare anche alla società civile la conquista di una vera libertà. Tutto milita, dunque, affinché la corsa di Marco verso il dottorato sia coronata dal successo, in un itinerario di crescita che presto lo vede affiancato alla bella e brava Sajani, una brillante collega americana di origine asiatica. Ci sono, però, nel cuore di Marco, dei problemi irrisolti, che risvegliano il suo senso critico e lo portano a mettere in dubbio l’adeguatezza, se non la validità stessa, della carriera universitaria d’Oltreoceano. Durante una visita ad un museo, al cospetto di alcuni capolavori del Rinascimento, Marco, all’improvviso, quasi fosse colpito da una sindrome di Stendhal, comincia a maturare una serie di riflessioni che lo conducono a lasciare Sajani e a distaccarsi, passo dopo passo, dall’orizzonte umano e formativo che aveva ritenuto irrinunciabile. La sua vita, infatti, è destinata a compiersi altrove, tra i colli della Pedemontana veneta, sulle tracce del sorriso della mai dimenticata Chiara e sulla strada di un fare letteratura più autentico e anticonformista, perché immerso nella realtà della terra d’origine.
Marco ha studiato Lettere a Padova e poi, sfiduciato dalle prospettive che avrebbe potuto coltivare nell’accademia italiana, ha scelto di conseguire un PhD a Chicago. La sua storia viene ricostruita e raccontata da un amico, un altro italiano che si trovava negli Stati Uniti nello stesso periodo e per la stessa ragione, e che ora lavora a Milano. In principio Marco è rapito dal modello universitario americano, così lontano dal declino intellettuale e morale del suo Paese, e così capace di dare il meglio a chi voglia formarsi e perfezionarsi nello studio e nella ricerca. Anzi, a Marco pare addirittura che, oggi, tutte le sorti dell’umanesimo non possano che essere giocate in quel sistema, a suo giudizio l’unico contesto idoneo a riprodurre, nell’organizzazione degli spazi fisici del sapere come nella definizione e nell’applicazione delle regole della comunità scientifica, quell’ideale di serietà, rigore e approfondimento che può assicurare anche alla società civile la conquista di una vera libertà. Tutto milita, dunque, affinché la corsa di Marco verso il dottorato sia coronata dal successo, in un itinerario di crescita che presto lo vede affiancato alla bella e brava Sajani, una brillante collega americana di origine asiatica. Ci sono, però, nel cuore di Marco, dei problemi irrisolti, che risvegliano il suo senso critico e lo portano a mettere in dubbio l’adeguatezza, se non la validità stessa, della carriera universitaria d’Oltreoceano. Durante una visita ad un museo, al cospetto di alcuni capolavori del Rinascimento, Marco, all’improvviso, quasi fosse colpito da una sindrome di Stendhal, comincia a maturare una serie di riflessioni che lo conducono a lasciare Sajani e a distaccarsi, passo dopo passo, dall’orizzonte umano e formativo che aveva ritenuto irrinunciabile. La sua vita, infatti, è destinata a compiersi altrove, tra i colli della Pedemontana veneta, sulle tracce del sorriso della mai dimenticata Chiara e sulla strada di un fare letteratura più autentico e anticonformista, perché immerso nella realtà della terra d’origine.

