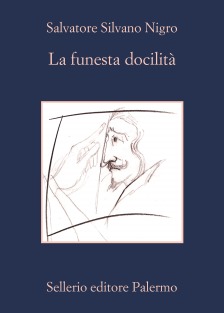Sulla storia narrata in questo libro – la resistibile ascesa politica del Mussolini fascista, dal debutto sansepolcrista, nel 1919, alla fase definitiva del delitto Matteotti, nel 1924 – ci sarebbe da dire troppo, o forse troppo poco. Troppo, innanzitutto, visto che per apprezzarla fino in fondo occorrerebbe restituire in dettaglio i fatti e le suggestioni che attraversano niente meno che 827 pagine. Forse è semplicemente un libro da non commentare. Peraltro, come ha precisato il suo Autore, si tratta di un romanzo documentario, costruito direttamente con le parole dei protagonisti, e soprattutto del protagonista, con tutte le progressive metamorfosi che lo hanno caratterizzato: dall’essere il prototipo dello sbandato al diventare – riuscitissimo “uomo del dopo” – il più cinico e callido dominatore della scena politica italiana. D’altra parte, ciò che è narrato in M. non è frutto di fantasia. È una verità, questa, difficile da accettare. Metabolizzarla richiederebbe davvero un certo spazio, forse addirittura maggiore di quello che di per sé già occupa il ponderoso tomo. Allo stesso tempo, però, il racconto alluvionale fa emergere una realtà tanto vorticosa e prepotente da angosciare e quasi annichilire il lettore. Si rischia, dunque, di dire troppo poco. Anzi, si rischia un istintivo silenzio: quello cui si è di solito indotti quando ci si sente persuasi da un’apparente autoevidenza, in questo caso veicolata dalla forza del mix di eventi pressoché quotidiani, piccoli e grandi, di cui il volume rende analitica e drammatica testimonianza. Si tratterebbe, tuttavia, di un silenzio colpevole e (a pensarci bene) un po’ ignorante, perché la stupefazione che lo anima sarebbe quella di chi ritenesse di acquisire, finalmente, con un medium prevalentemente emotivo, una verità o una conoscenza razionalmente non attingibile. Eppure le cose non stanno così: sul piano storiografico, M. non aggiunge niente al consolidato e diffuso patrimonio di informazioni e conoscenze sul fascismo e sul suo Duce. Perché leggerlo?
Il fatto è che basterebbe riprendere le chiare e illuminanti (e poche…) pagine di un classico saggio di Giovanni De Luna (Benito Mussolini. Soggettività e pratica di una dittatura, Milano, 1978, 62-77) per assimilare con pari efficacia la lezione che Scurati avalla con così tanto apparato. Non è certo ignoto che la spregiudicatezza di M. – come il suo peculiare rapporto con la violenza e con i gerarchi più determinati – ha ricevuto assist decisivi da un contesto politico e istituzionale particolarmente frammentato, fragile, confuso e opportunista; né costituisce una scoperta l’ambiguo e ammiccante contegno di tanti (e illustri…) moderati, oltre che del re; né (ancora) può veramente sorprendere la constatazione sulla sostanziale e radicale vuotezza di un’ideologia che non è mai stata veramente tale, perché costruitasi per via di fortuite e occasionali addizioni progressive, che potevano esserci o meno, a seconda del vantaggio, anche soltanto retorico, che al momento parevano garantire. Circa la marcia su Roma, poi, nulla è meglio della caustica e incalzante ricostruzione di Lussu; e anche sulla fine di Matteotti non si svelano profili inediti. Eppure, proprio a quest’ultimo riguardo, proprio considerando, cioè, le modalità con cui Scurati si approccia, gradualmente, alla figura del deputato socialista – sulla cui intima, umana, debolezza il racconto si sofferma più volte – si può cogliere l’unico spunto che offre un senso, e un’utilità, al fotoromanzo del regime e del dittatore nascenti: virtù positive, si badi, che niente hanno a che fare con la possibilità di evocare, oggi, episodi o passaggi più o meno educativi – e più o memo calzanti… – sulla fisiologia disarmante di uno scivolamento socio-politico. È il contrasto con il campo di Matteotti a rendere plasticamente evidente la durezza e l’inevitabilità del campo di Mussolini, dominato, sempre e sin dal principio, dal vitalismo animale e irrefrenabile, e talvolta pavido delle sue stesse potenziali conseguenze, che alimenta tipicamente ogni sete di potere. Non poteva che vincere, questa orribile forza, specie a fronte di chi, senza avvertirne l’urgenza, non ne aveva capito l’essenza e non è stato in grado di fronteggiarla e di domarla.
Recensioni (di Roberto Antolini; di Ambrogio Arienti; di Mario Barenghi; di Davide Brullo; di Ivan Carozzi; di Antonio D’Orrico; di Ernesto Galli della Loggia; di Daniele Giglioli; di Lorenzo Pavolini)