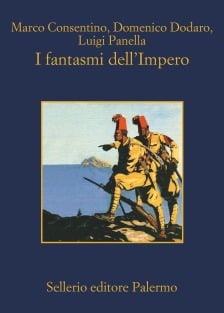Francesco “Cesco” Magetti è un militare della Repubblica di Salò. Fa parte della guardia nazionale repubblicana ferroviaria, di stanza ad Asti. Il suo superiore gli ordina di trovare una carta ferroviaria del Messico. Nel pieno del freddo e malinconico clima di disfacimento totale del febbraio 1944 la consegna suona in modo surreale. Dove mai si potrà trovare una mappa del genere? E Cesco, poi, ha anche un terribile mal di denti. Ad ogni modo la ricerca comincia, a partire dalla biblioteca comunale. Dove Cesco incontra l’enigmatica Tilde, viene a sapere che esiste una Historia poética y pintoresca de los ferrocarriles en México e che questo fantomatico libro è in prestito. Da qui in avanti si avvia l’inseguimento di Cesco, la cui storia si accavalla con quella, al fine, tragica di Tilde; con quella, quasi fantastica, di Lito Zanon e del suo amico Mec, costruttori giramondo di reti ferroviarie; con quella di Ettore e Nicolao, strani frequentatori di un altrettanto misterioso night clandestino; con quella di un cartografo samoano trapiantato in Piemonte; con quella degli amici di Cesco, che si sono fatti disertori e partigiani; con quella della burocratica e surreale catena di comando che dal Führer è arrivata fino ad Asti, per disporre la caccia alla mappa ferroviaria; con quella di Steno, che si era promesso a Tilde e che si dà alla macchia; con quella di Gustavo Baez, l’autore del volume tanto agognato; con quella della povera Giustina, giovanissima prostituta, barbaramente condotta alla morte; con quella di don Tiberio, disperato parroco di Roccabianca… L’elenco, con i relativi intrecci, potrebbe continuare. Vi farebbe capolino anche Jorge Luis Borges. Fatto sta che nel vortice dell’Odissea in cui Cesco si ritrova immerso qualcosa scatta all’improvviso, conducendo il protagonista al drammatico, eppure liberatorio, epilogo.
Molto si è detto, e scritto, su questo romanzo (libro-mondo, romanzo totale…), tanto che, sia con il classico passaparola, sia per le molteplici segnalazioni online, è entrato anche nella dozzina dello Strega. È un dato che può sorprendere, perché si tratta di un libro-fiume: oltre 800 pagine, per di più articolate in capitoli dalla lunghezza irregolare, ciascuno dedicato a uno spezzone delle tante vicende che ne irrorano la trama. Non è un romanzo facile, quindi. E non è nemmeno il prodotto di un grande editore, suscettibile di essere spinto nelle case delle persone per la sola forza del marketing e delle reti distributive. Si aggiunga che nelle analisi dei lettori più forti Griffi viene variamente paragonato a Pynchon o a Bolaño: Autori mitici, capaci di conferire nel raffronto l’aura del capolavoro, ma non certo annoverabili tra quelli di più agevole frequentazione. Occorre pazienza e disciplina, virtù oggi rare. Infine c’è un altro fattore potenzialmente esiziale: il libro, spogliato del suo grande apparato narrativo e dell’effetto matrioska ingenerato dalle tante digressioni, racconta una vicenda oltremodo schematica. Un ragazzo trascinato per forza d’inerzia tra le fila della parte sbagliata si imbarca in un’avventura surreale e, proprio in quella corrente, pur commettendo un delitto (spoiler), fa giustizia, anche di se stesso. Il tutto in un itinerario che potrebbe banalmente dirsi di formazione. Insomma, il plot può non avvincere e a tratti le pagine (molte) possono farsi noiose. Qual è, dunque, il segreto del successo?
Sicuramente gioca un qualche ruolo l’apparenza di libro un po’ underground, scelto da un nome cool (Giulio Mozzi) per la sua collana di nicchia. Anche la veste editoriale può avere le sue ragioni. Ferrovie del Messico, per indubbie motivazioni economiche, è un oggetto leggero, con un’impaginazione distesa, che dà l’illusione di sciogliere le complessità linguistiche e di percorrere il suo periodare ubriacante con una sorprendente velocità. Sicché navigare in questo romanzo, all’atto pratico, è meno complesso di quello che può apparire. Come se i modi del confezionamento cartaceo invogliassero a relativizzarne l’interna prospettiva, sofisticata e iperletteraria, rendendola, al contempo, godibile e meglio afferrabile. Qui si nasconde, già dal punto di vista meccanico, la chiave di volta del volume, ossia la commistione inestricabile tra tristezza e ironia, tra pesantezza assoluta e volatilità, tra orrori e speranze. C’è del Chaplin e dello Charlot, sotto la copertina. Perché a rigore è vero che il libro di Griffi, per argomenti e personaggi, se fosse paragonabile a qualcosa di precedente, andrebbe addirittura comparato a Horcynus Orca di D’Arrigo: opera potente e immaginifica, anch’essa viaggio iniziatico e durissimo, perché sovrastato dall’onnipotenza naturale di un destino cupo e avvolgente. Eppure, diversamente da quella prova, Ferrovie del Messico – anche in virtù dell’evidente e insistito flirt con le suggestioni della migliore tradizione sudamericana – è evasione e farmaco, prova tangibile che di fantasia e invenzione artistica si può dolorosamente guarire. Dunque affaticarsi in una lettura ipnotizzante può, alla fine, piacere? Diremmo di si, specie se comprendessimo che, in questo nostro tempo gelatinoso e giustificante, in cui tutto – ma proprio tutto – può accadere e diventare pure normale, Cesco Magetti è effettivamente uno di noi.
Recensioni (di P. Bianchi; di G. Cortassa; di S. Ditaranto; di A. Galetta; di F.M. Spinelli; di G. Tinelli; di C. Vescovi; di G. Vignanello)