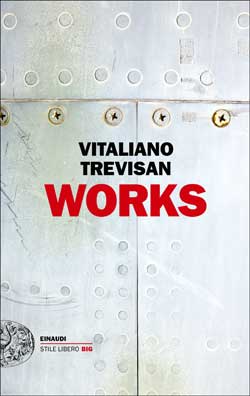La finzione è uno degli strumenti più importanti e interessanti per il mestiere del giurista: si presuppone come esistente (o come non esistente) qualcosa che non esiste (o che esiste), per far discendere in un certo caso determinati effetti, quelli che il diritto, in un determinato modo, già riconosce in altri casi. La culla della fictio è il diritto romano, nel quale essa nasce, in primo luogo, come fictio legis, a partire da quella introdotta con la legge Cornelia dell’81 a.C., che, per riconoscere effetti al testamento del civis romanus morto in prigionia (e la cui cattività, secondo le regole generali, lo aveva privato della capacità), consentiva di considerare il prigionierio come già morto nel momento in cui era caduto nelle mani dei nemici. La fictio in seguito si ripropone in molte ipotesi, sempre per l’intervento del legislatore. Ma si trasforma anche in fictio iuris, diventa, cioè, tecnica dell’interpretazione giuridica, come sarebbe accaduto – almeno per l’Autore – in occasione della formulazione del noto insegnamento per cui conceptus pro iam nato habetur. In questo breve saggio, Thomas rievoca tanti esempi di finzione così come maturati nell’esperienza giuridica romana, cercando di evidenziarne la logica e mettendo in luce – questa la sua tesi – la diversità con cui i giuristi medievali hanno trattato l’utilizzo di questo particolare meccanismo: mentre il diritto romano, infatti, non avrebbe patito, nel ricorso alla fictio, il limite della presupposizione di una verità superiore, il diritto comune avrebbe introdotto, mercé l’influenza del cristianesimo, alcune distinzioni, volte se del caso a sbarrare la strada ad un certo tipo di finzioni (e precisamente a quelle finalizzate a “varcare” la frontiera fra corporeo e incorporeo ovvero a bypassare le regole “naturali” sulla riproduzione dei corpi).
La finzione è uno degli strumenti più importanti e interessanti per il mestiere del giurista: si presuppone come esistente (o come non esistente) qualcosa che non esiste (o che esiste), per far discendere in un certo caso determinati effetti, quelli che il diritto, in un determinato modo, già riconosce in altri casi. La culla della fictio è il diritto romano, nel quale essa nasce, in primo luogo, come fictio legis, a partire da quella introdotta con la legge Cornelia dell’81 a.C., che, per riconoscere effetti al testamento del civis romanus morto in prigionia (e la cui cattività, secondo le regole generali, lo aveva privato della capacità), consentiva di considerare il prigionierio come già morto nel momento in cui era caduto nelle mani dei nemici. La fictio in seguito si ripropone in molte ipotesi, sempre per l’intervento del legislatore. Ma si trasforma anche in fictio iuris, diventa, cioè, tecnica dell’interpretazione giuridica, come sarebbe accaduto – almeno per l’Autore – in occasione della formulazione del noto insegnamento per cui conceptus pro iam nato habetur. In questo breve saggio, Thomas rievoca tanti esempi di finzione così come maturati nell’esperienza giuridica romana, cercando di evidenziarne la logica e mettendo in luce – questa la sua tesi – la diversità con cui i giuristi medievali hanno trattato l’utilizzo di questo particolare meccanismo: mentre il diritto romano, infatti, non avrebbe patito, nel ricorso alla fictio, il limite della presupposizione di una verità superiore, il diritto comune avrebbe introdotto, mercé l’influenza del cristianesimo, alcune distinzioni, volte se del caso a sbarrare la strada ad un certo tipo di finzioni (e precisamente a quelle finalizzate a “varcare” la frontiera fra corporeo e incorporeo ovvero a bypassare le regole “naturali” sulla riproduzione dei corpi).
Il ragionamento di Thomas può dirsi condivisibile, e rilevante, quanto a quattro specifici profili: la ricostruzione dell’originalità delle dinamiche messe in gioco dall’operazione finzionale; la confutazione dell’idea diffusa che questa operazione sia indissolubilmente, e prevalentemente, legata al carattere conservatore di un ordinamento giuridico (che in tal modo, tramite le finzioni, evolverebbe senza mai porre in discussione la sua struttura); la rappresentazione dell’autonomia del giuridico quale risultato di un processo istituzionale coscientemente fondato sull’opposizione rispetto al reale; la bella descrizione dell’approccio romano allo spazio del sacro, come frutto, esso stesso, della produzione giuridica e, quindi, come limite insuscettibile di costituire una preclusione immutabile e ontologica alla trasformazione delle regole. Ciò che lascia un po’ dubbiosi, invece, è la parte del lavoro dedicata ai “limiti medievali” della finzione, e ciò per due ragioni: la prima è che lo stesso Thomas, in conclusione, relativizza in buona parte la portata del dispositivo limitante di origine divina (così come frequentemente invocato dai giuristi di diritto comune), sottolineando quanto nel diritto dell’età intermedia esso, lungi dall’eliminare il metodo finzionale, ne avrebbe razionalizzato il ricorso soltanto in parte; la seconda è che, quanto meno al giurista poco esperto di diritto romano e di diritto comune, lo studio della fictio pare non potersi troncare alle soglie della modernità, se non altro perché questa si è costruita e si è imposta anche per mezzo di una ulteriore e potente strategia finzionale, quella del famoso (e trasversale) etiamsi daremus Deum non esse di Ugo Grozio. E senza le scoperte della razionalità medievale questa ulteriore progressione sarebbe stata difficilmente pensabile. Viene quasi da chiedersi, al riguardo, se la fictio, da delicato artificio proprio del fenomeno giuridico, non si possa configurare quale uno dei massimi esempi di quanto i modi di costituzione dell’autonomia del giuridico stesso si siano resi, nella storia, effettivi veicoli di mutamenti epistemologici particolarmente profondi. È nella prospettiva di questo interrogativo che una simile lettura si dimostra molto proficua.