Locus desperatus, di Michele Mari, e Reliquie, di Daniele Gorret, stanno doverosamente assieme. Sono letture brevi. Si direbbero due cosette, che peraltro, e non a caso, parlano proprio di cosette. Anche se le une come le altre non lo sono per nulla, esigono concentrazione e aprono, invece, lo sguardo e la mente a dimensioni assai più ampie e profonde, e per ciò solo imperdibili.

La prima lettura è un lungo racconto, che si rivela à la Mari nel modo più autentico. Vale a dire che è iper-letterario, stilisticamente e linguisticamente complesso, pieno di riferimenti e citazioni, alcune esplicite e altre più nascoste. E vi aleggiano i demoni di Hoffmann, Meyrink, Kafka, Lovecraft. Il protagonista, che narra la vicenda, si accorge un giorno che sulla porta di casa è tracciata una croce. Nell’interrogarsi sul senso dell’evento, scopre che il suo appartamento è così contrassegnato in vista di un prossimo “subentro” e che tutte le sue adorate cose – piccoli e grandi pezzi da collezione o d’affezione, raccolti e custoditi nell’arco di una vita intera – passeranno a qualcuno che lo sostituirà. Potrebbe trattarsi dello strano Asfragisto, che del resto si palesa all’improvviso, al tavolino di un bar sciatto e mal frequentato, dove, però, tanti altri presentano profili ugualmente sospetti: uno spiccio barista, uno spilungone che sembra saperla lunga, l’ex umanista Procopio, la nuova e volgare barista. Nel frattempo, il nostro eroe cerca di difendere le sue cose, apprestando varie strategie, purtroppo perdenti, e trovando aiuto e compassione nel mostruoso Sileno; ma venendo anche a conoscenza che la sua sorte appare ormai definita, anche perché tragicamente già capitata ad altri sventurati, tra cui alcuni ex compagni di scuola. L’angoscia spinge il predestinato a resistere fino in fondo e a fare delle cose stesse il reagente di un rito quasi diabolico, con cui intrappolare e debellare l’oscuro nemico. Quale significato può avere una simile storia? È essa stessa un locus desperatus, un passo che nemmeno i filologi riescono a decifrare? Oppure – come si trova nel testo – il locus desperatus è proprio suo stesso abitante, fattosi indecifrabile al mondo che ha sempre percepito come ostile, cercando rifugio, ma trovando prigione, soltanto nel chiuso delle sue cose?
Nelle poesie di Gorret (non nuove a questi schermi) le cose sono trattate in modo meno ambiguo; anzi, esplicitamente positivo. Ma – come spiega l’Autore nel densissimo prologo che apre il volumetto – ciò accade quando hanno la natura e la forza della Reliquia. Va detto che tutto può esserlo, tutto ciò “che ha forma, peso e storia”. Basta guardare ai titoli di ogni componimento: ad esempio, Reliquia è un vecchio quaderno di scuola; un uccellino morto; la foglia conservata tra le pagine di un libro; uno specchio; la lettera di una persona cara; una cartolina; un sasso; una lapide rimossa e custodita; una tovaglia riposta in un cassetto… persino un pensiero. E in una cosa si può riconoscere la Reliquia anche quando è ancora in potenza. Il suo essere, infatti, ha una presenza angelica, cui solo “i degni” si possono accostare. Occorre crederci, dunque. Perché la cosa-Reliquia “deve far tremare”, altrimenti, “ridotta ad anticaglia, è cosa da buttare”. Il rapporto con le Reliquie, in definitiva, è una preghiera, che passa per un rito: di riscoperta, osservazione, contemplazione, concentrazione, memoria. È semplice e ineffabile allo stesso tempo. È vettore di storie, ricordi, immagini, insegnamenti, struggimenti e nostalgie. È risorsa perché ha un’anima che le è propria e che, tuttavia, anima quella di chi la sa intercettare. Durante la lettura vengono in mente molte suggestioni. Che la via possa essere quella più semplice, è lezione che si ritrova già nei Primi poemetti di Pascoli. Alla domanda, poi, se esista una via domestica alla riscoperta del sacro, Gorret, con il suo panpsichismo mansueto e affettuoso, offrirebbe una risposta affermativa. Una risposta che è teorizzata nel prologo già citato, una pillola teologica a tutti gli effetti, e che all’apparenza parrebbe funzionare anche per il personaggio inventato da Mari. Con la differenza essenziale, tuttavia, che in Locus desperatus l’angelico è colto nel suo terribile “doppio” luciferino.
Alcune recensioni (a Mari: 1, 2, 3, 4, 5, 6; a Gorret: 1, 2, 3)






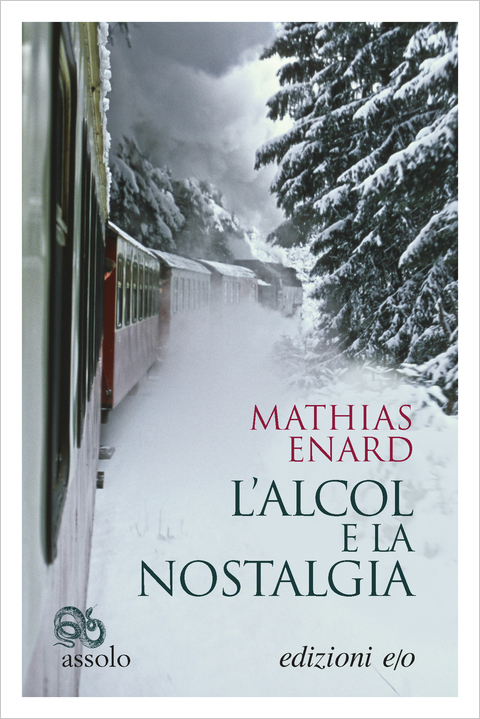

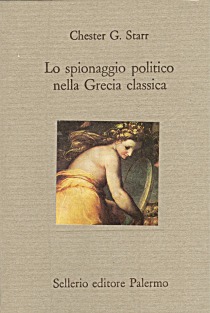
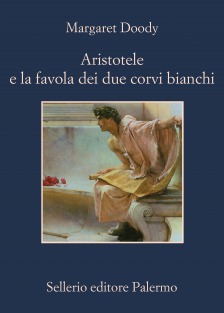


 Qualche tempo fa ho letto sulla rivista Internazionale (18/24 ottobre 2013) un articolo di Jonathan Franzen, dedicato a Karl Kraus. Era un estratto, in verità, di un lavoro più ampio,
Qualche tempo fa ho letto sulla rivista Internazionale (18/24 ottobre 2013) un articolo di Jonathan Franzen, dedicato a Karl Kraus. Era un estratto, in verità, di un lavoro più ampio,  Alla poesia segue, sempre per volontà di Franzen, una nota esplicativa di Daniel Kehlmann, tanto sintetica quanto puntuale. E tuttavia ho avvertito un moto di insoddisfazione, e mi sono quasi pentito di aver comprato questo volume. Mi sono subito ricordato, ad esempio, del fatto che, in Italia, per capire Kraus, ci possono essere ben altri e potenti strumenti per ogni più utile
Alla poesia segue, sempre per volontà di Franzen, una nota esplicativa di Daniel Kehlmann, tanto sintetica quanto puntuale. E tuttavia ho avvertito un moto di insoddisfazione, e mi sono quasi pentito di aver comprato questo volume. Mi sono subito ricordato, ad esempio, del fatto che, in Italia, per capire Kraus, ci possono essere ben altri e potenti strumenti per ogni più utile 