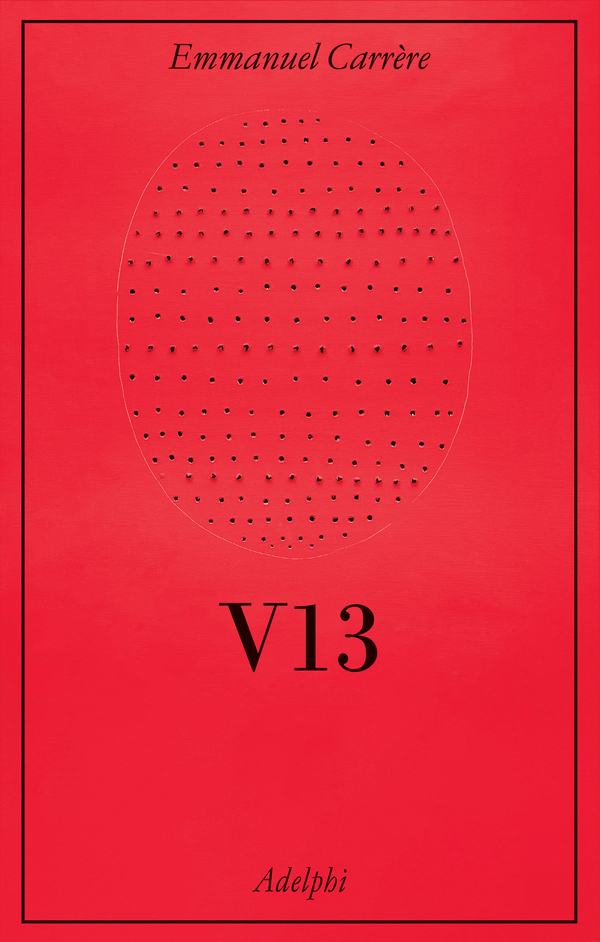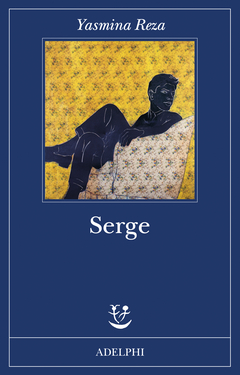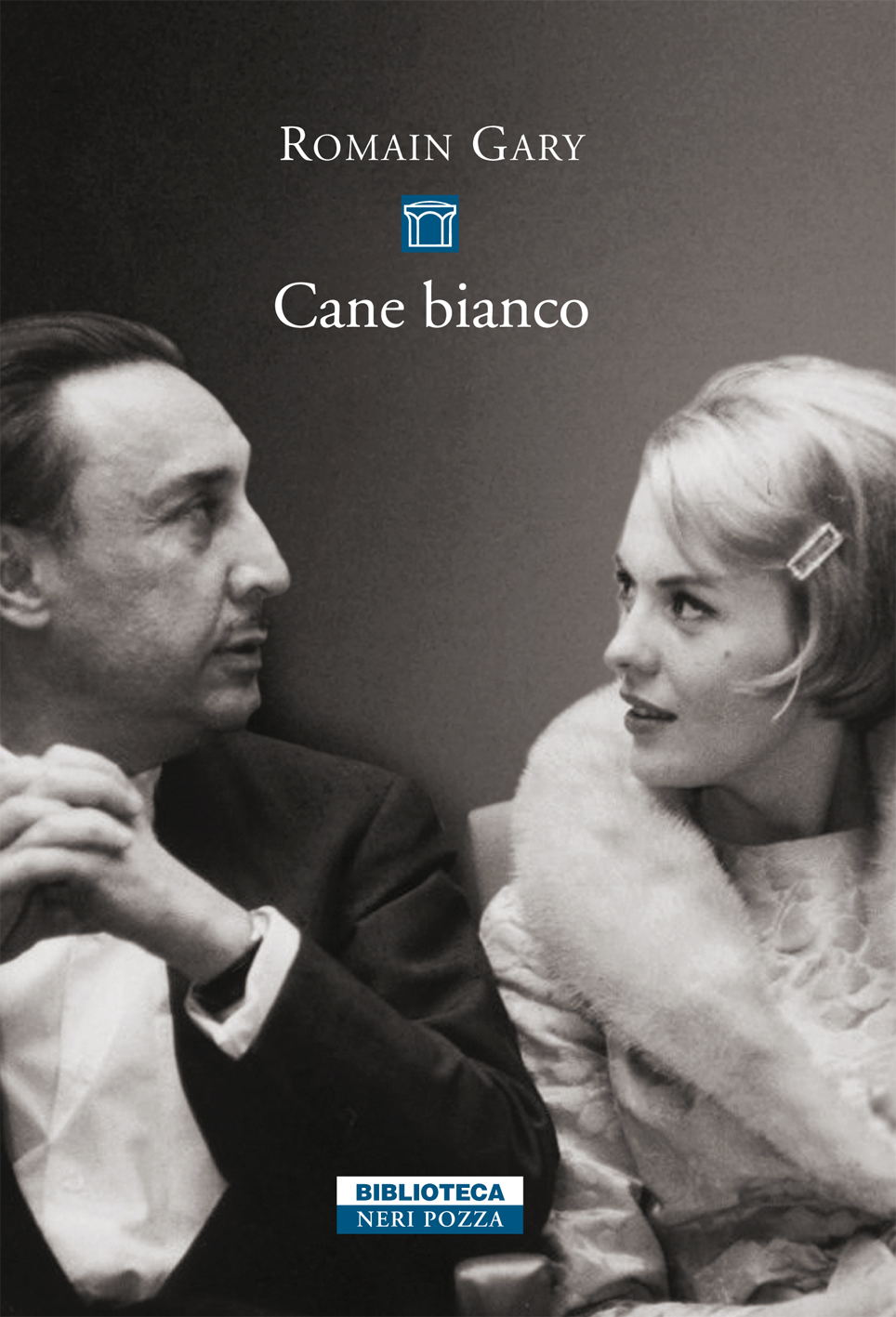Si può identificare un autore solo con la sua produzione e con il flusso di significati che ne possono derivare? Oppure conta di più la dimensione soggettiva? Sono questioni classiche, per la cui risposta occorre assumere, preliminarmente, posizioni ben più complesse. Quando, poi, ci si imbatte nel pensiero di Foucault, il problema si rivela ancor più difficile. Perché non c’è dubbio che da quel pensiero, e dai testi che lo hanno veicolato, ha avuto origine una serie tuttora proficua di re-interpretazioni, declinazioni o, addirittura, nuove correnti filosofiche. L’opera foucaultiana, pertanto, si staglia come un dato autonomamente generativo. Eppure non c’è dubbio, allo stesso tempo, che quell’opera, anche nelle sue virtù seminali, è il frutto di un’esperienza formativa personale e costante; di un itinerario individuale pressoché irripetibile, le cui scelte sono più che mai avvinte alle virtù e ai condizionamenti di un intero sistema socio-culturale e accademico, quello francese, traguardato nei profili dei suoi protagonisti e nell’attrito con i più importanti eventi di un certo periodo storico. Pertanto anche l’individuo Foucault, immerso nel suo tempo, non può essere trascurato. Della fecondità di questi intrecci – tra oggettività di un lascito intellettuale e irriducibilità di un percorso esistenziale – la preziosa biografia di Eribon – comparsa nel 1989, riedita con aggiornamenti nel 2011 e riproposta in Italia, da Feltrinelli, dieci anni dopo la prima edizione del 1991 – rappresenta la migliore e più ricca dimostrazione. Che, peraltro, non rinuncia a sintetizzare in maniera assai efficace i poli sostanziali di una riflessione tanto cangiante quanto coerentemente evoluta.
Sul piano delle opere, il Foucault de Storia della follia nell’età classica (1961) non è lo stesso de Le parole e le cose (1966); né quest’ultimo coincide con l’autore de L’archeologia del sapere(1969) o di Sorvegliare e punire (1975) o de La volontà di sapere (1976). E pure i famigerati corsi al Collége de France (come, ad esempio, Bisogna difendere la società-1975/1976 o Nascita della biopolitica-1978/1979) sono altra cosa ancora. C’è da ammettere che la mutevolezza, o il tormento, non è da meno nelle vicende della carriera universitaria o dell’impegno pubblico: ambiti, entrambi, in cui Foucault sa essere eccentrico, urticante, antipatico, istintivo, politicamente scontroso e schierato, ambiguamente profetico, ma anche accomodante, ligio al dovere d’ufficio, instancabile nell’organizzazione e nell’aggregazione di persone e cose, cosciente del galateo istituzionale, strategico nelle conoscenze e nelle relazioni sociali, intelligentemente conservativo. Possono sembrare lineamenti di un profilo contraddittorio, talvolta opportunistico e talaltra passionale. In realtà sono aspetti che, nel racconto di Eribon, risuonano di libertà e indipendenza; di un’ambizione onnipresente, che non rinuncia mai alla peregrinazione, al viaggio, al confronto (dalle prime esperienze giovanili, svedesi, polacche e tunisine, alle grandi trasferte della maturità, in Brasile, Stati Uniti e Giappone). E che non rinuncia neanche all’azzardo (come nel caso del reportage in Iran e dei presentimenti sul futuro dell’Islam). In effetti Foucault è costantemente alla ricerca del luogo e della condizione congeniali, in cui specchiarsi ed essere riconosciuto. La scrittura fa parte dello stesso viaggio, visto che, come ricorda Eribon, secondo Foucault si scrive per essere amati. E anche la forma e la sequenza con cui un pensatore si esprime, già sul piano editoriale, non possono che riflettere questa istanza di rimodulazione e adeguamento progressivi (ne sono plastica espressione le riprogettazioni continue dei volumi dell’opera sulla Storia della sessualità).
La biografia, peraltro, riesce a isolare intuizioni ricostruttive e profili metodologici distintivi e costanti, e a restituire così il ritratto di uno studioso a suo modo esemplare. A Foucault, come è noto, si devono acquisizioni importanti: sui rapporti, nell’evoluzione del pensiero occidentale, tra normalità e patologia; sulla formazione, tra il Diciassettesimo e il Diciannovesimo secolo in particolare, della c.d. società disciplinare e della sua varia tecnologia di misurazione, valutazione, classificazione, controllo, inclusione/esclusione; sul rapporto tra pratica moderna delle pene e scienze umane; sulla natura e sull’origine del potere (che deriva dai molteplici effetti di divisione che percorrono l’insieme del corpo sociale: in questo senso, “il potere viene dal basso”); sull’indispensabilità, per ogni società, e per ogni sistema di giustizia, di un’interrogazione continua sulle proprie istituzioni; sul fatto che al governo delle persone è funzionale non solo l’obbedienza, ma anche la manifestazione piena, da parte dei governati, di ciò che si è; sulla remotissima nascita, nelle tecniche della cura di sé e nelle morali dell’antichità, dei laboratori in cui si forgiano specifici modi di assoggettamento; etc. Dell’esperienza foucaultiana, comunque, ciò che ancor più colpisce è la commistione strutturale tra riflessione teorica e indagine storica, quest’ultima effettuata sempre sul campo (negli archivi, con i documenti, con le testimonianze materiali di specifiche prassi e organizzazioni…): perché, per fare ricerca, “bisogna andare in fondo alla miniera”. In questo modo, la filosofia non solo si mescola alla storia, ma si imbatte (e si interroga, dialogando) con il diritto, con la psicologia, con la religione, con la letteratura, con l’economia. In un’età di forte enfasi sull’interdisciplinarità nella ricerca scientifica, tornare a Foucault è quanto mai formativo.
Recensioni (di S. Catucci; di M. Cicala; di M. Marchesini; di R. Ronchi)