
Quest’anno si celebra il centenario della nascita di Gianfranco De Bosio, che è stato regista (e co-sceneggiatore, assieme a Luigi Squarzina) de Il terrorista. Il film, che risale al 1963 e ha tra i propri attori anche Raffaella Carrà, è stato nuovamente proiettato, in questi giorni, alla Mostra internazionale cinematografica di Venezia. Per l’occasione Mimesis ha pubblicato, a cura di Maria Ida Biagi e Giuseppe Ghigi, un interessante volume, che, oltre all’originale copione (già edito a suo tempo per Neri Pozza), raccoglie contributi sulla pellicola e sul suo restauro. Il plot è essenziale. In una Venezia vuota, livida e fredda, sorvegliata dai repubblichini di Salò e occupata dall’esercito tedesco, un ingegnere – un giovane Gian Maria Volonté, già pienamente calato nella sua iconica, tagliente espressività – si pone a guida di un GAP (Gruppo di Azione Patriottica) e organizza un attentato contro i comandi nazifascisti. L’azione non è stata condivisa con il Comitato di Liberazione Nazionale veneziano, che si riunisce clandestinamente, discutendo a lungo e facendo emergere le diverse posizioni delle forze politiche che lo compongono. È in gioco un radicale problema di legittimazione della lotta per la liberazione, e di responsabilità nei confronti della popolazione civile. Mentre si decide di tentare una mediazione ufficiale per evitare sanguinose rappresaglie, l’ingegnere, che nel frattempo ha fatto perdere le proprie tracce, compie un altro atto, questa volta dimostrativo, scatenando però, definitivamente, la reazione nazifascista: venti ostaggi vengono immediatamente fucilati. Il Comitato, nuovamente tormentato per i rischi che incombono, chiede istruzioni al CLN nazionale, che sta a Milano. Ma l’ingegnere e i suoi tentano subito una nuova operazione, che viene sventata, aprendo la strada alla caccia spietata della polizia fascista. La morsa va stringendosi attorno a tutti i cospiratori e pure ai membri del CLN veneziano, e l’ingegnere, prima di intraprendere la fuga, confessa alla compagna Anna le ragioni e l’angoscia della sua disperata risolutezza. Il finale è tragico.
Vedere, o rivedere, oggi Il terrorista è assai importante. In primo luogo, perché il suo carattere asciutto, quasi didascalico, e la recitazione da piece teatrale lo rendono un’efficace testimonianza di un momento drammatico della storia italiana e delle articolazioni spesso conflittuali delle forze che hanno fatto la Resistenza; una testimonianza tanto efficace perché verosimile e credibile, visto che De Bosio ha vissuto in prima persona l’appartenenza a una brigata partigiana (la Brigata “Silvio Trentin”, comandata dal patavino Otello Pighin). Ciò che colpisce è la capacità di ricostruzione e rielaborazione critica, visto che la composizione è assai consapevole e matura: a dimostrazione che anche dall’interno del mondo che ha partecipato direttamente alla Resistenza l’autoanalisi è sempre esistita. In secondo luogo, vi si trova rappresentato l’intreccio disperante, vissuto dall’ingegnere gappista, tra tensione ideale e civile, da un lato, e abisso morale, dall’altro: nel volantino di rivendicazione del primo attentato, il protagonista si compiace alla lettura della frase “È necessario agire anche se agire porterà necessariamente a soffrire”; nel dialogo intimo con Anna, però, improvvisamente, la fragilità esistenziale, la solitudine e le incertezze prospettiche di questa posizione vengono completamente allo scoperto (siamo sicuri che, dopo tanta sofferenza, non ci “sarà di nuovo un periodo che la gente si lascerà addormentare… anestetizzare… da un po’ di pace e di abbondanza”?). Su questo piano, il film passa dalla ricostruzione quasi documentaristica alla messa in scena di una dinamica tristemente universale, e anche attuale. Assume, infatti, i toni e la forza di una tragedia classica, che come tale tocca nel profondo e continua ancora a interrogarci.


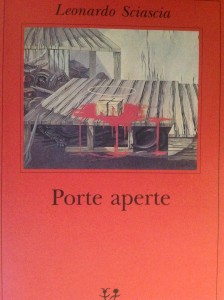

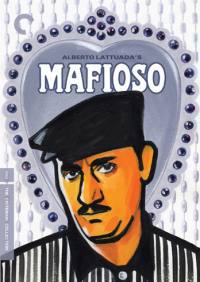 Ad
Ad 


