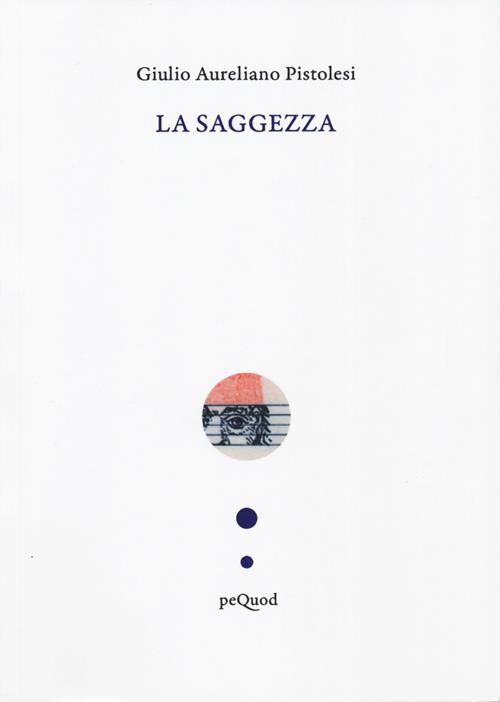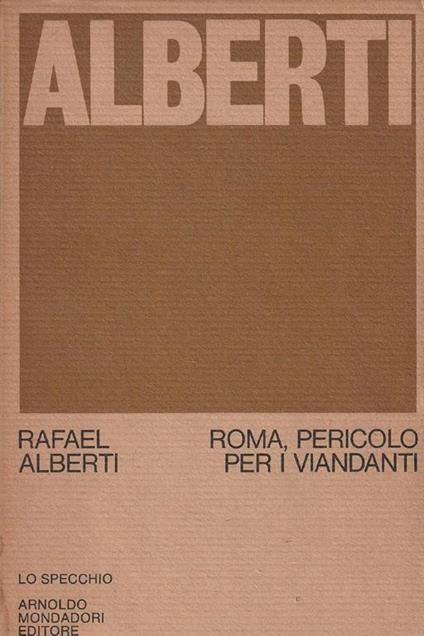Semel in anno… perdersi felicemente e tornare ad Acitelli è indispensabile. Ci si metterebbe volentieri e in ogni momento sulle tracce di questo infaticabile indagatore. Il quale, da parte sua, è continuativamente impegnato nella ricerca di sempre: sulla città e sul popolo di Roma che ha conosciuto da ragazzo, e che si rinnovano in miti vecchi e nuovi; sui luoghi che ha percorso e scoperto col padre, camminando per la capitale; sugli spazi e le vie e le piazze e le pietre e i marmi del Rinascimento e del Barocco e… su tutti i dettagli che dall’Urbe portano all’arte, alla storia, all’eternità. Ma anche alla nostalgia, quella più dolce e nutriente, e – in quest’ultima raccolta di poesie – pure alla Fede e al Sacro. Le vene dell’Ostia, infatti, sono un viaggio, un piccolo pellegrinaggio, che per prima cosa è punteggiato da tante chiese e chiesuole. Del Campo Marzio, del Foro; e moltissime altre ancora. Se ne può fare una mappa suggestiva e proficua, da consultare e utilizzare alla prima occasione. Tuttavia non si tratta di turismo. Al poeta le chiese interessano perché – lo dichiara bene alla fine (ne Il Vangelo oltre le Colonne d’Ercole) – “[e]ntrare in chiesa è come avvistare / un Faro ai confini del mondo e se il veliero / è disperso, a nulla valgono scie di stelle / e bussola, così dal ponte di prua / l’unica intermittenza vera è quel Faro / in mare aperto”. Entrare in chiesa, allora, equivale a rifugiarsi e trovare conforto; a pensare e vedere la madre in un presepe, “A un passo da Dio”; ad ascoltarne ancora la voce, a sentirne il cuore: “È il non vedervi più che m’addolora, / non il recludermi nella morte – m’hai detto / uscendo di chiesa, nel sole”.
È proprio in chiesa, in effetti, che Acitelli si sofferma su ciò che gli preme di più: studia lapidi, iscrizioni, cappelle, marmi e pale d’altare, muovendosi quasi furtivo nelle pieghe della storia e delle vite passate; osserva sacerdoti, frati, sagrestani, anziani e malati devoti, per carpire il segreto della loro fiducia, che in fondo è anche la sua; e così rammenta la madre: la fonte, col padre, di ogni sua più intima consuetudine e dei riti che, oggi, lo riportano sugli stessi sentieri. Ma c’è qualcosa di aggiuntivo. Spesso a Roma le chiese sono anche porte per accedere al continuum spazio-temporale di cui la caput mundi è l’ombelico di un’esauribile vortice. Sotto le chiese si nascondono sovente templi e altari pagani. Sono Fede e Sacro a tutto tondo, per l’appunto, ad essere in comunicazione. Non è un caso che l’Autore ami frequentare le rovine, sperimentare i contatti tra romanità e cristianesimo, smarrirsi con Samuel Beckett sull’Appia Antica, ché “… la verità / sta lì stampata…”. E dunque il “piano ferie / è quotidiano / e prevede / assiduità / nei magazzini / dell’Antichità”. Come non capire? La via dell’Ostia può fungere certamente da bussola per chiunque, a Roma, se ne voglia avvalere. A patto, però, di attivare i sensi; di fare come Acitelli, cui basta “[q]uel tabacco respirato in strada che sa / di marinai olandesi in chioma bianca e codino” per sognare, mettersi a cercare “una locanda che somigli / all’alloggio del Comandante” e interrogare i marinai “se nella navigazione / contemplano, oltre il mare, qualcosa di celeste”. A questo serve la Visita alla Città, alle sue Chiese e alle altrettanto misteriose e inestricabili Archeologie. A questo serve la Poesia.
Recensioni (di M. Bennici; di D. Piccini)
Leggere Sant’Agostino nell’età della tecnica (di F. Acitelli)
Mattini infiniti
(studi sulla felicità)
Anche oggi m’allestisco in una chiesa,
l’ora in cui il lavoro è decollato.
Mi sono alzato tardi, ho fatto spesa,
ho sbadigliato a lungo e ho pensato
a come mitigare la discesa
negli anni, ad inoltrarmi nel venato
epitelio in cui più non v’è difesa
e v’è da consolarsi col Creato.S
Soggiornare in chiesa
Perché cerco una chiesa quando piove?
Io sono la mia nave tra le onde,
voglio vedere fuori la tempesta:
acquattarsi tra i banchi, le rovine
sì prolungata tosse, quei sospiri
che parlano d’un cuore affaticato,
pio, esausto, ma incline al classico
se c’è da pensare a una conversione
in quel tratto bello in cui l’Impero
sul cristianesimo lieve s’adagia.
Lì dormire nella consunzione
pensando a quel nessuno che m’attende
né a casa e neppure altrove: soltanto
nei Vangeli sogno il riposo eterno:
adagiarmi tra quelle righe e poi
chiudete gli altri libri e il lume: Amen!
Piazza Farnese, rifugio a cielo aperto
Tepore cerco nel Rinascimento,
pittori con scarsella stretta in vita
con arte da Verrocchio e Ghirlandaio
e chioma lunga come Raffaello.
Un committente lieto di gorgiera
fa essere la vita proprio bella.
Un Papa che rilegge Tertulliano
e convoca Sangallo in Vaticano.
Eccolo il sentiero mio profondo
e il desiderio è evadere dal mondo.
Piazza Farnese, il marmo lustro ovunque:
qui la mia esistenza giunge al dunque.