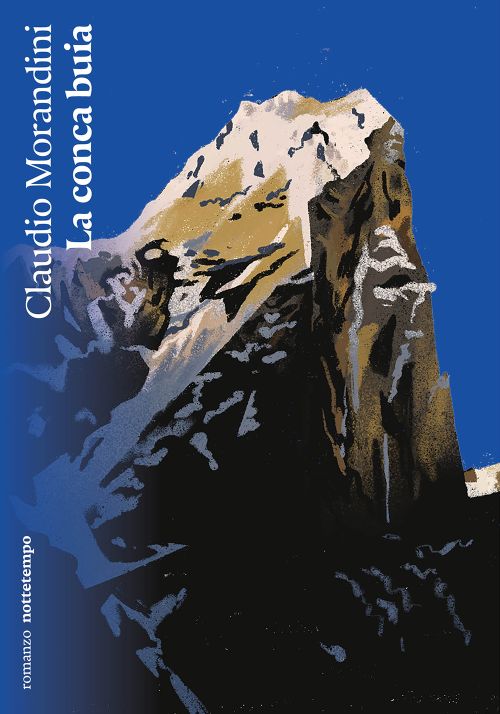Coltivo da anni quella che considero una buona abitudine. Se viaggio verso un luogo, tanto più se mi devo impegnare in una qualche attività di riflessione, confronto o discussione critica, cerco di sintonizzarmi con alcuni demoni di quel luogo. Specialmente se figurano tra i protagonisti del dibattito. Così è stato qualche giorno fa, nell’itinerario per un bel convegno che si è tenuto a Cagliari: l’occasione perfetta per leggere un breve, ma intenso, racconto di Emilio Lussu, Il cinghiale del Diavolo. È un piccolo capolavoro. Si tratta di una storia di caccia, scritta tra il 1936 e il 1938, come Un anno sull’Altipiano, e pubblicata, però, solo nel 1967. Durante una battuta al cinghiale, gli anziani del gruppo, stimolati dai ripetuti, inspiegabili, errori dei tiratori più abili, rievocano attorno al fuoco una misteriosa vicenda sepolta nel passato. E quasi celebrano, in questo modo, un vero e proprio rito apotropaico, di rispettoso ricongiungimento agli spiriti profondi dei loro avi e della natura più segreta e avvolgente. Tutto funziona in questa prova letteraria, che tiene in equilibrio temi e toni alla Rigoni Stern – citato anche da Lussu nel suo commento introduttivo – con un’atmosfera weird degna di Lovecraft. Il confezionamento complessivo dell’edizione ha meriti ancor maggiori, che vanno oltre l’utilissima digressione antropologica offerta dall’Autore nelle pagine che precedono il racconto. Il volume, nella riedizione di Ilisso, raccoglie, infatti, altri cinque testi: sulla cultura paterna e familiare, sulle origini del Partito Sardo d’Azione, sul futuro dell’isola, sul brigantaggio e su di un episodio puntuale di vita politica e parlamentare. Sono pezzi interessanti, ma, nella sua essenziale incisività, quello di apertura – La mia prima formazione democratica – è formidabile. Perché ricorda le lezioni ricevute dal padre, “un provinciale semplice, senza nessuna cultura”. Eppure capace di comunicare coraggio e integrità, spirito critico e realismo, riconoscimento e rispetto, umiltà e dignità. A dimostrazione che il rapporto con le radici, proprio quando sa farsi veicolo di una trasmissione dialettica e metabolizzata, è capace di custodire le virtù che meglio alimentano ogni stabile progresso.