
È ogni volta un bel dono poter leggere un grande scrittore. Anche quando ci si imbatte in un racconto che forse non è mai stato veramente ultimato. Insomma, Dostoevskij è sempre Dostoevskij. Qui si cimenta con una trama sospesa tra la realtà e l’immaginazione più spinta. È la storia di un funzionario pubblico, uno come tanti, che si reca con la moglie a vedere l’esotica attrazione del momento, giunta dall’Europa per inaugurare quello che oggi diremmo un centro commerciale. Si tratta di un coccodrillo, esibito da una coppia di avidi e fastidiosi mercanti tedeschi, madre e figlio. La bestia pare tranquilla, immobile e indifferente a ciò che la circonda, ma all’improvviso ingoia il funzionario, che sparisce nelle sue fauci. In verità l’uomo non è morto, ma parla dal ventre del coccodrillo, ostenta salute e sicurezza, vagheggia presuntuoso un futuro di prosperità economica e grandi successi per sé e la consorte, e preconizza nuove e risolutive visioni del mondo, capaci di cambiare il destino dei popoli. La voce narrante è quella di un collega di lavoro del funzionario mangiato dal coccodrillo. Da un lato ripercorre stupefatta e preoccupata l’accaduto, cercando di ricondurlo a una qualche razionalità; dall’altro misura le reazioni vacue della bella sposa dello sventurato amico, dei suoi conoscenti e degli altri colleghi. I quali, tutti, percepiscono certo la straordinarietà del caso, ma restano avvinti nel ruolo di inguaribili e disarmanti macchiette borghesi, avviluppati anch’essi nel propri piccoli desideri e meschini individuali.
Nei brevi appunti che Serena Vitale dedica a quest’opera, definita da Dostoevskij una “birichinata letteraria”, si possono apprezzare tante cose. Si può scoprire, ad esempio, che – a dispetto delle rimostranze del suo stesso Autore – il racconto era stato considerato dai contemporanei come una parodia delle vicende accadute a Nikolaj Gavrilovič Černyševskij, intellettuale e rivoluzionario risucchiato dalle prigioni zariste della Siberia. Forse è vero – più in generale – che la sferzante ironia che percorre la storia intera si scaglia su ciò che di moderno stava invadendo Pietroburgo e la Russia alla metà del XIX secolo, e sulla mentalità che i gusti di matrice occidentale e il “principio economico” – così lo chiama Dostoevskij – stavano diffondendo. Il coccodrillo, quindi, è il campione, l’immagine ficcante di questa cultura virale, con la sua capacità egemonica e, per l’appunto, fagocitante: una forza irresistibile, che si impadronisce delle persone, come se fosse una possessione, e che non trova certo opposizione nel carattere molle, fatuo e debosciato della gente di Pietroburgo. Anch’essa è bersaglio diretto di Dostoevskij. Si diverte a ridicolizzarla, a denunciarne la povertà morale di fronte alla logica prevalente del tornaconto personale, del profitto e del consumo, già allora raffigurato come fattore disgregante di ogni ordine sociale. E pure di qualsiasi idea di verità, alla stregua di ciò che si verifica nella nostra modernissima e tecnologica società dell’informazione: nelle pagine dei quotidiani la vicenda dell’uomo mangiato dalla bestia viene riportata, a seconda della testata (e ciascuno sceglie naturalmente quella che più gli è congeniale), in variazioni completamente dissonanti, fantasiose, se non irriconoscibili. Forse che siamo davvero finiti tutti nelle viscere di un rettile implacabile? Dostoevskij continua a interrogarci.
Recensioni (di M. Archetti; di M.C. D’Alisa; di D. Gabutti; di A. Gnocchi; di A. Pagliuso; di V. Parisi)

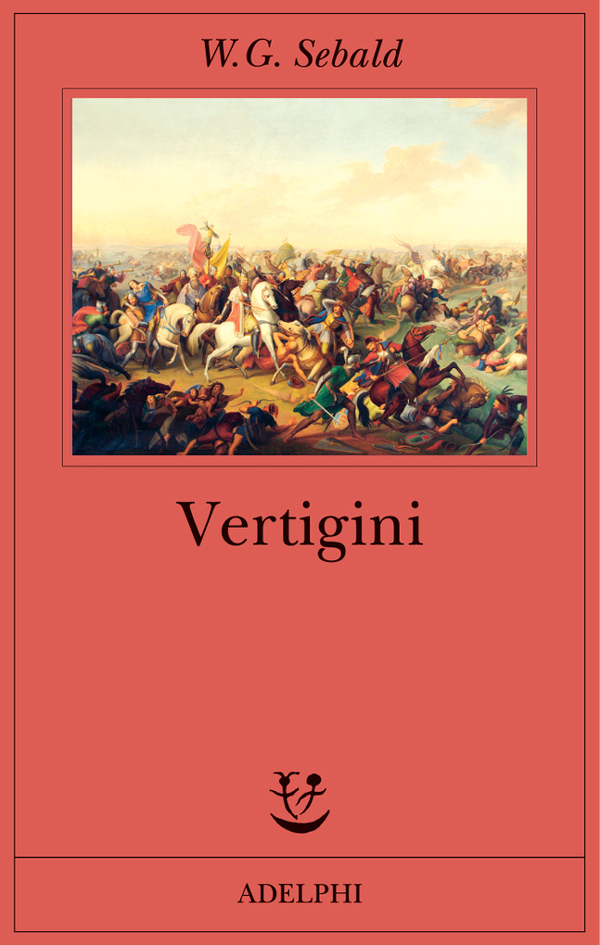






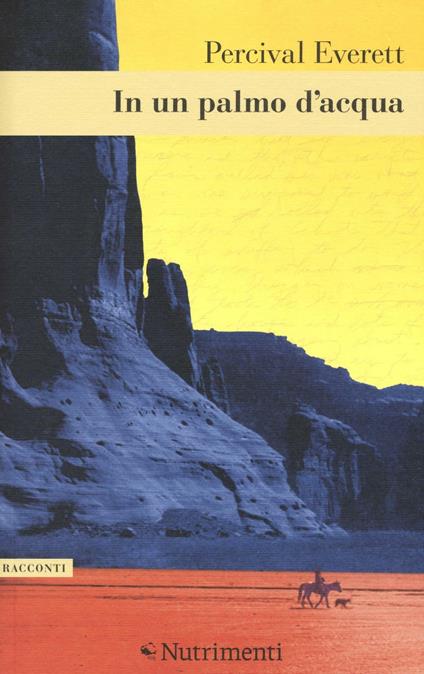 Sono nove racconti pressoché perfetti, ambientati tra il Colorado e il Wyoming. La prosa è semplice e asciutta, giusto quella che serve, non una parola di più e non una parola di meno. Anche le storie sono essenziali, eppure curiose, originali e toccanti. Un veterinario si mette alla ricerca di una bambina sorda scomparsa nel deserto, rischiando la vita con serena, appagante e sorprendente tenacia. Un ragazzo che ha perso la sorella, e per il quale tutti si preoccupano, pesca e dorme d’inverno sulle rive selvagge di un torrente, e all’improvviso sorride. Una vecchia ranchera, ormai sola e malata, e anche un po’ scorbutica, cavalca a lungo, fino al paradiso, ma senza accorgersene veramente. Padre e figlia sfidano qualcosa che va al di là delle loro semplici paure, tra un puma affamato e un freddo letale. Un allevatore scapolo, un po’ saggio e un po’ smaliziato, riesce a mostrare a moglie e marito come si fa ad andare nel verso giusto. Uno sceriffo conciliante e prudente incontra comunque il suo destino. Un tizio vuole capire chi sia un altro tizio che gli ha lasciato uno strano messaggio sotto casa e che tutti dicono di conoscere e di non volerne sapere nulla. Un incubo si racconta da solo, e alla fine, dopo una scena quasi horror, non si capisce che cosa sia vero e che cosa sia falso. Un giovane aiuta un’anziana della riserva a morire felice, mentendole in modo provvidenziale. Ecco: è “l’arcipelago Everett” che si manifesta, riga dopo riga; e che ci cattura definitivamente.
Sono nove racconti pressoché perfetti, ambientati tra il Colorado e il Wyoming. La prosa è semplice e asciutta, giusto quella che serve, non una parola di più e non una parola di meno. Anche le storie sono essenziali, eppure curiose, originali e toccanti. Un veterinario si mette alla ricerca di una bambina sorda scomparsa nel deserto, rischiando la vita con serena, appagante e sorprendente tenacia. Un ragazzo che ha perso la sorella, e per il quale tutti si preoccupano, pesca e dorme d’inverno sulle rive selvagge di un torrente, e all’improvviso sorride. Una vecchia ranchera, ormai sola e malata, e anche un po’ scorbutica, cavalca a lungo, fino al paradiso, ma senza accorgersene veramente. Padre e figlia sfidano qualcosa che va al di là delle loro semplici paure, tra un puma affamato e un freddo letale. Un allevatore scapolo, un po’ saggio e un po’ smaliziato, riesce a mostrare a moglie e marito come si fa ad andare nel verso giusto. Uno sceriffo conciliante e prudente incontra comunque il suo destino. Un tizio vuole capire chi sia un altro tizio che gli ha lasciato uno strano messaggio sotto casa e che tutti dicono di conoscere e di non volerne sapere nulla. Un incubo si racconta da solo, e alla fine, dopo una scena quasi horror, non si capisce che cosa sia vero e che cosa sia falso. Un giovane aiuta un’anziana della riserva a morire felice, mentendole in modo provvidenziale. Ecco: è “l’arcipelago Everett” che si manifesta, riga dopo riga; e che ci cattura definitivamente.