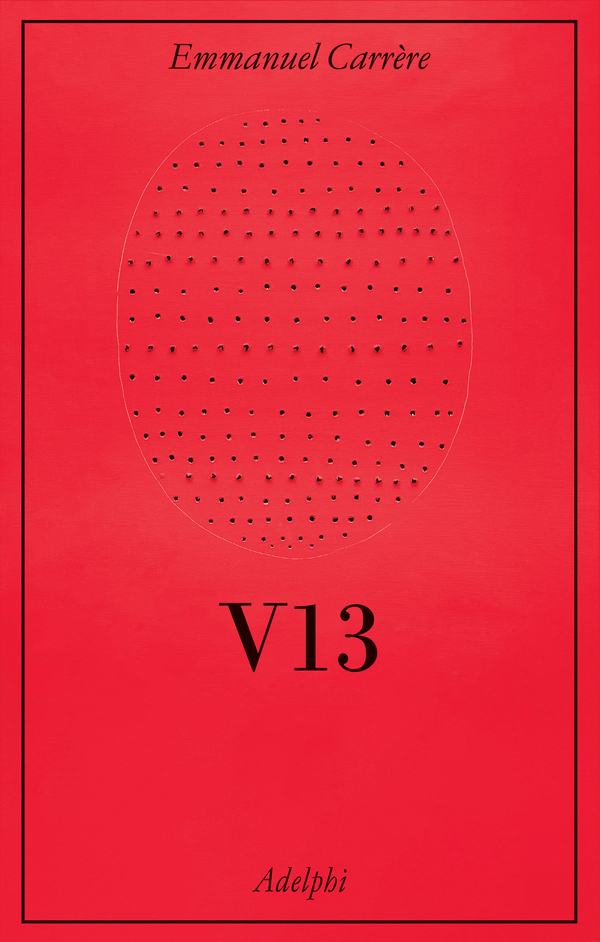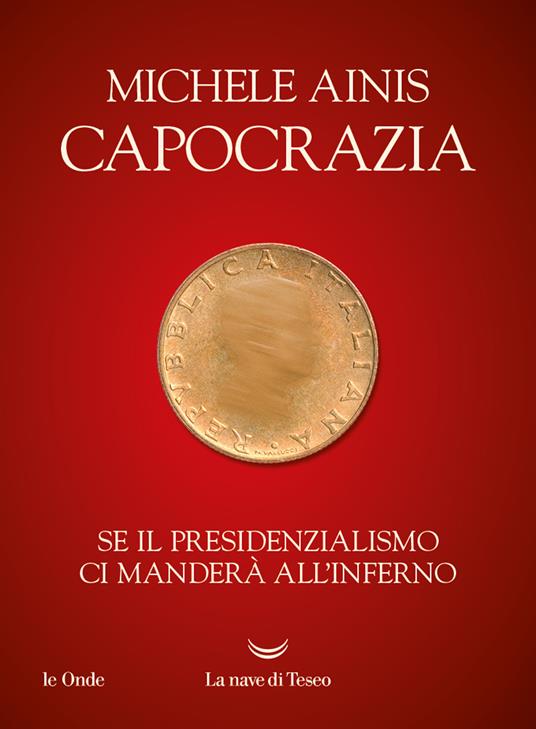
La Legislatura in corso prevede, tra i suoi appuntamenti più caldi, il dibattito sul cd. “premierato”, un disegno di legge costituzionale presentato al Senato nel novembre dello scorso anno e concernente l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. Naturalmente la discussione è già montata e si è fatta presto arroventata, sia nel discorso pubblico (sono stati molti, ad esempio, gli editoriali sulle testate giornalistiche nazionali), sia nelle riflessioni strettamente giuridiche (a quest’ultimo riguardo v. i commenti e i contributi prodotti da un gruppo di lavoro formatosi in seno alla Fondazione Astrid; ma cfr. anche le audizioni svolte in Parlamento). Il libro di Michele Ainis, noto costituzionalista, saggista e romanziere, si pone un po’ a metà strada. Con lo stile arguto che lo contraddistingue, l’Autore non cerca solo di fornire ai comuni cittadini gli strumenti conoscitivi per collocare la proposta italiana di riforma nell’ambito delle diverse forme di governo che attribuiscono una diretta legittimazione democratica all’Esecutivo (il “modello statunitense”, la “variante francese”, il “brevetto israeliano”). Né si ferma a soppesare pregi e difetti delle possibili ricette presidenzialiste (rispettivamente, alle pp. 77 e 85). Non gli interessano i “figurini” della modellistica. Più che analizzare in dettaglio la “proposta italiana” (di cui si mettono in luce le imprecisioni, le aporie e le mancanze), gli preme porre in luce alcuni profili, metodologici come di tendenza.
Dal primo punto di vista, Ainis invita a riflettere su come sia necessario, per poter fare realmente le riforme, riavvicinare i cittadini alla partecipazione politica. In proposito non rinuncia a qualche provocazione, immaginando, ad esempio, che si possa scegliere (eleggere? Sorteggiare?) un gruppo di persone comuni, cui affidare la formulazione di idee specifiche, ovvero che si possa anche costringere il circuito politico-rappresentativo e le sue articolazioni decisionali a raccogliere nel modo più diffuso, anche online, sollecitazioni o spunti utili al cambiamento. Oltre a ciò, Ainis descrive la tensione trasformativa verso modelli presidenziali come qualcosa di tipico nell’evoluzione più recente dei sistemi parlamentari. Così suggerendo, quasi, che sia quanto mai urgente riallineare la forma alla sostanza anche nel contesto nazionale, che pure, tuttavia, egli descrive in termini assai scettici e preoccupati, data l’onnipresenza – ad ogni livello – di una sfibrante cultura del capo. Se i rilievi concernenti la partecipazione paiono un po’ troppo ingenui, quelli sulla dilagante “capocrazia” – e sulla dubbia opportunità di assecondare un certo trend – oltre a palesarsi come parzialmente contraddittori, finiscono per generare una sorta di irrimediabile pessimismo (tradito in modo assai plastico dal sottotitolo del saggio: “Se il presidenzialismo ci manderà all’inferno”). Al punto che, in definitiva, il libro lascia il lettore con l’amaro in bocca e con la sensazione che la (lunga) rassegna degli intoppi e degli errori del passato (e del presente) sia destinata a completarsi e a consolidarsi anche nel prossimo futuro. Ma qualcosa di interessante, nei pensieri ad alta voce dell’Autore, rimane. Vale a dire il duplice insegnamento che le riforme che funzionano sono quelle che davvero si configurano come un meditato atto collettivo, e che quest’ultimo evento va in qualche modo promosso e coltivato con una seria consapevolezza dei fallimenti già sperimentati.