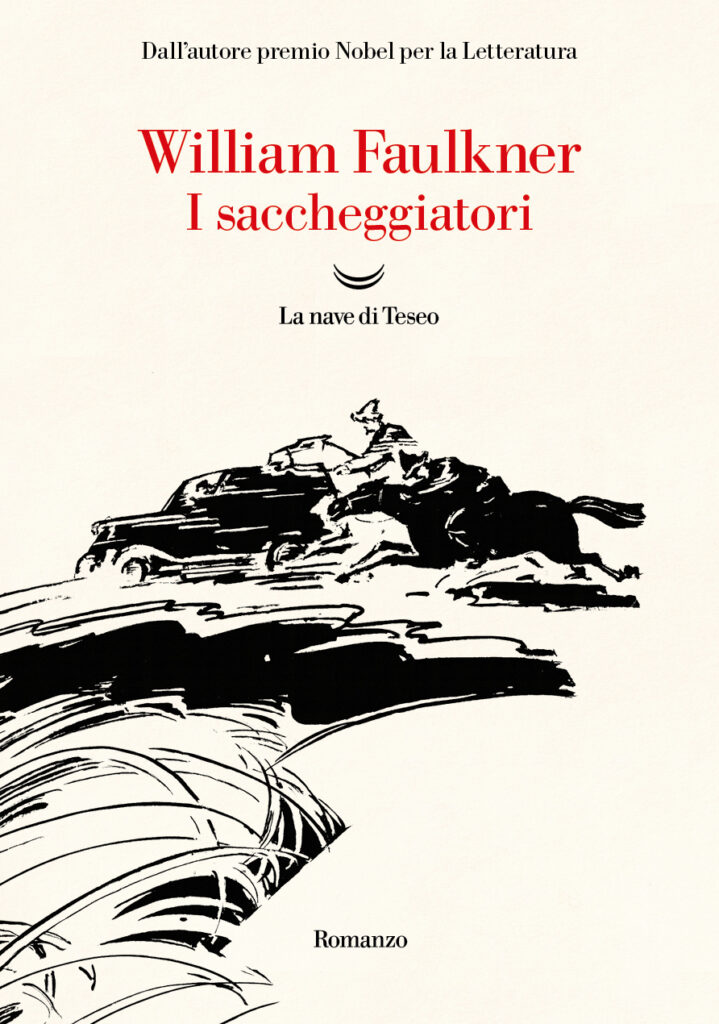
Per fortuna che d’estate si trova quasi sempre un Faulkner da leggere. Questa volta è l’ultimo romanzo, dato alle stampe nel 1962, l’anno della morte del grande scrittore. Lo ripropone La Nave di Teseo in una edizione leggibilissima (una rarità: caratteri ampi, spaziature altrettanto ariose, una pagina che scorre e si fa bere con gusto). Di questo romanzo si possono sapere facilmente molte cose: che tra tutti quelli del Premio Nobel di Oxford (Mississippi), è stato a lungo considerato come uno dei meno riusciti; che ha fornito la materia per un film del 1969, con Steve McQueen, a quanto pare anch’esso poco apprezzato; e che ripropone i consueti topics dell’universo faulkneriano (l’epos della contea di Yoknapatawpha, il rapporto tra “bianchi e neri”), in una trama avventurosa e in parte tragicomica, sulle orme dell’Huckleberry Finn di Twain. In effetti la prima impressione può essere proprio questa. Il protagonista è Lucius Priest, che racconta al nipote ciò che gli è accaduto quando aveva undici anni, nel 1905. Cioè quando, assieme a Boon Hogganbeck e a Ned (un meticcio di origine chickasaw e un lavorante di colore), sottrae al nonno (il Padrone) la sua nuova automobile, finendo prima a Memphis, in una casa di piacere, e poi a Parsham, nella fattoria del vecchio Zio Possum, all’insaputa di tutta la famiglia. E restando coinvolto in furti, sortite notturne, corse clandestine di cavalli, scommesse, improbabili storie d’amore: in altre parole, vivendo un’avventurosa e perturbante occasione per diventare adulto. L’apparenza, dunque, è quella di un classicissimo romanzo di formazione, calato nel mondo e nello stile lussureggianti e inconfondibili di un maestro della narrazione.
Fosse solo questo, il libro si distinguerebbe già dal canone cui potremmo ricondurlo. Perché è un plot che Faulkner restituisce in modo magistrale. La voce del ragazzo, i suoi pensieri, il suo percorso psicologico, l’ingenuo trasporto, il divertimento e il disorientamento… Tutto è reso nel modo migliore. C’è piena immedesimazione da parte dell’Autore, il lettore lo sente rapidamente e si immedesima a sua volta. Per chi volesse approfondire, poi, c’è un sofisticato sottotesto, che – come rivela anche la nota del traduttore, in chiusura del volume, rimandando ad un recente studio – coincide con il tema iniziatico delle Metamorfosi di Apuleio. Lucius è come il Lucio di quell’antica storia, ed anche qui è una figura femminile (Miss Corrie come la dea Iside) a farsi mediatrice del rito di passaggio (che è tale anche per Boon Hogganbeck, che di Corrie è innamorato). È senz’altro una prospettiva interessante, che forse spiega anche il mood sotteso alla scelta del titolo: the reivers, i saccheggiatori, i picari che se ne approfittano, ma cui per definizione è concesso superare il confine; non meri ladruncoli, dunque, come invece potrebbe apparire superficialmente, se ci soffermasse solo sulla sgangherata fisionomia dell’improbabile banda che lo scrittore mette sulla scena. Ma più che per simili raffinatezze, il racconto faulkneriano è impagabile per altri fattori, di immediata, istintiva percezione: la caratterizzazione perfetta dei personaggi (la saggezza sfrontata e lo slang di Ned non si dimenticano facilmente, come il temperamento di Miss Reba, la stoica tenutaria); l’umanità assoluta e nobile di alcune immagini (Zio Possum, l’anziano ex schiavo che al cospetto degli altri si staglia come giudice e patrizio); il tratto argutamente pedagogico di certe divagazioni (i passi sull’intelligenza degli animali, tra pag. 152 e pag. 155, sono iconici quanto quelli di un Fedro o di un La Fontaine); il dualismo implicito, quasi cavalleresco, tra eroi ed antieroi (Lucius vs. Otis; Boon vs. Butch). Insomma, con Faulkner si respirano letteratura e vita allo stato puro. È una bella boccata d’ossigeno.

Finita l’Università, Matteo è rimasto a Roma. Si mantiene con piccole collaborazioni editoriali ed è appassionato di cose arcane. Un giorno riceve un messaggio sul cellulare: viene convocato, non si sa da chi, in un luogo preciso, al tramonto, sulla terrazza sopra il Tabularium. Da lì assiste a una strana rappresentazione, che si svolge nel foro sottostante, svanendo all’improvviso. Non riesce a comprenderne il senso. Tuttavia in un successivo sopralluogo scopre che sul punto esatto in cui aveva intravisto la misteriosa cerimonia si trova una pietra, che reca scolpite le lettere F C S, iniziali per Fulgur Conditum Summanium. Capisce, allora, che lì era caduto anticamente un fulmine e che l’evento era stato segnato dalla rituale sepoltura del fulmine stesso, secondo una tradizione che i romani avevano mutuato dagli etruschi. Nel frattempo Matteo conosce Silvia, una ragazza che si occupa di beni culturali. Lo coinvolge in una relazione magnetica, capace di evocare strani, realistici fantasmi; ma anche di metterlo sulla strada giusta, perché è Silvia a stimolarne ulteriormente la curiosità. Tanto che Matteo decide di rivolgersi al Prof. Mulini, l’anziano e autorevole docente con cui si è laureato. L’avventura prende presto una piega sempre più enigmatica: a Matteo appare addirittura il suo doppio; poi parte una ricerca metodica delle tombe dei fulmini, per capire se la loro collocazione sia capace di rivelare un senso recondito; si avverte anche che Mulini nasconde più di qualche segreto, specie quando muore e lascia a sua casa e la sua enorme biblioteca (con la sapienza che essa occulta) proprio a Matteo… Altro non si può dire, per non togliere il piacere della lettura a chi voglia sperimentarla direttamente. I nodi verranno comunque al pettine e il protagonista saprà di esserlo stato, sin dall’inizio, anche nei pensieri di qualcun altro.
Il romanzo è del 2017, libro d’esordio dell’Autore e prima puntata di una trilogia (completata dal Libro del sole e dal Libro del sangue). Nel Matteo-personaggio c’è molto, evidentemente, del Matteo-scrittore, che pure si occupa di filosofia, esoterismo e magia in quel di Roma. È una formula che gli consente di scrivere di quello che sa, in un approccio, peraltro, che stimola facilmente immedesimazione. Lo fanno sempre i motivi centrati sull’iniziazione, e qui ve ne sono almeno due (quello del passaggio dalle Marche a Roma, in viaggio col padre; ma soprattutto quello della transizione a una maturità diversa e ad un grado superiore di coscienza). Poi – con la facile scorta della mappa che apre il volume – Trevisani spinge anche all’esplorazione dei tesori della città ipogea e di siti storici e archeologici non sempre al centro dell’attenzione turistica (come la Basilica dei Santi Quattro o la Domus Fulminata di Ostia Antica). Anche questo è qualcosa che suscita curiosità. Ma non c’è dubbio che gli spunti autobiografici e topografici sono solo la miccia per una sublimazione letteraria vera e propria, e ben riuscita. Lo si può dire non tanto per il senso della trama: il mistery è abbastanza schematico, anche dove rimette in gioco una suggestione simile a quella del famoso romanzo di Cazotte, Il diavolo innamorato, con il quale c’è più di un’assonanza (ed è un merito). Il punto di forza è la scrittura: precisa, elegante ed efficacemente evocativa di luoghi e sensazioni; densa, ma a suo modo delicata, non pesante, specie perché ripartita opportunamente in capitoli agili. A tratti si ha l’impressione che sia uno stile del tutto inadatto ad avvincere il lettore nel thrilling di un indagine da compiersi in segreti millenari. È così, in effetti, visto che Trevisani non insegue Dan Brown. Pertanto è giusto che le sue parole siano quelle di un viaggio interiore, di una meditazione che rivela la vera natura – classica in senso proprio – del racconto e dell’intenzione che lo percorre. Pierre Hadot avrebbe apprezzato.
Recensioni (di L. Alvino; di S. Bachechi; di O. Labbate; di M. Manon; di M. Nucci; di C. Taglietti)
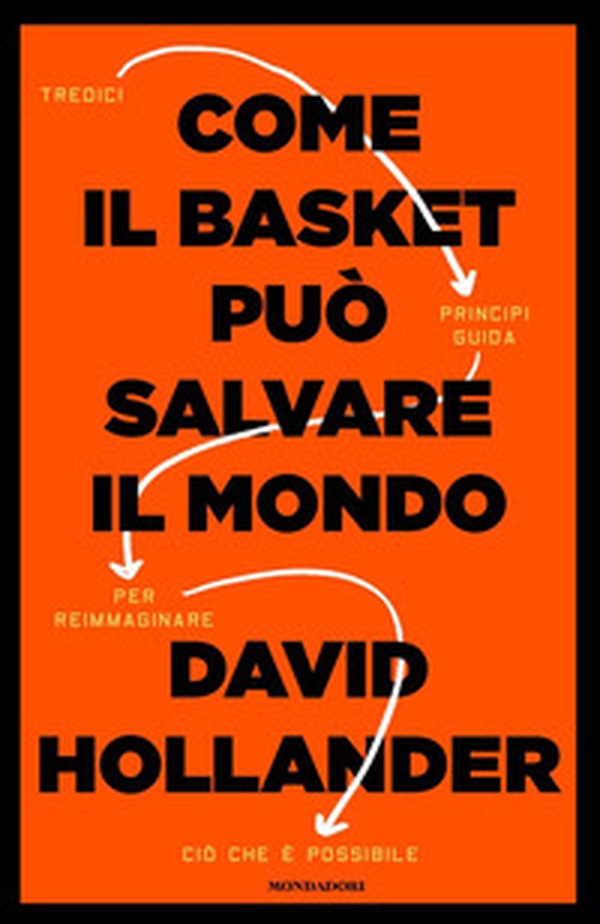
Nel quadro delle letture dell’anno, per quanto compiute finora, questa è stata la migliore. Una scoperta, si potrebbe dire, fatta sulla scorta dell’entusiasmo (ritrovato) per uno sport che sa dare grandissime soddisfazioni. Anche in quest’ultimo senso l’annata è stata più che mai proficua. E promette di continuare ad esserlo. Le NBA Finals hanno consacrato l’inarrestabile forza dei Denver Nuggets, vincitori dell’anello per la prima volta, e il ruolo di assoluto protagonista che da qualche tempo si è ritagliato Nikola Jokić (guardare per credere). I mondiali – che sono in corso tra Indonesia, Filippine e Giappone – forse non fanno presagire cose eccelse per la Nazionale italiana: ma il podcast allestito durante il ritiro da Gigi Datome e Niccolò Melli è assai divertente, ed è sempre bello soffrire partecipando agli alti e bassi del quintetto azzurro. Che per ora, comunque, ha saputo trasmettere emozioni inattese. Il fatto è – tornando al punto – che il libro di David Hollander non è necessariamente un testo per amanti della pallacanestro. È il laboratorio di una scuola di pensiero: un itinerario, scandito in 13 lezioni / principi, per sperimentare quanto la logica del playground possa fungere da stimolo per intuizioni e soluzioni utili ai fini del miglioramento della società. A suo modo, infatti, Come il basket può salvare il mondo è una proposta politica, ovvero, usando le parole assai esplicite dell’Introduzione, “una storia nuova, una nuova cornice in cui inquadrare il senso di quello che facciamo, un nuovo ismo”.
L’Autore gioca con alcune parole-chiave (collaborazione, equilibrio individuale e collettivo, equilibrio di forza e tecnica, non posizionalità, alchimia, inclusività, etc.) per scandire e illustrare una serie di insegnamenti. È il frutto che le origini, le evoluzioni, lo spirito, i protagonisti e alcune grandi culture del basket possono consegnare a chi volesse costruire, oggi, una leadership consapevole ed efficace. C’è un po’ di retorica, naturalmente, come è tipico di chi sia fortemente appassionato; e ci sono anche tutte le radicalità e ingenuità prospettiche – delle vere esagerazioni, talvolta – di una visione americana fino al midollo. Di un approccio che si esalta solo nell’essere larger than life. Ma non si può non restare catturati dal modo con cui Hollander dà corpo ai propri ragionamenti ricorrendo a episodi o vicende da assumere come metafore incisive ed ispiranti. In tanti casi chiama in causa le gesta, le qualità, il carattere e le imprese di eroi, vecchi o nuovi, della NBA (Wilt Chamberlain, Steve Nash, Larry Bird e Magic Johnson, Draymond Green…) o di alcune squadre (i Boston Celtics, i Philadelphia 76ers, I Golden State Warriors, gli Oklahoma City Thunder, i Toronto Raptors…). In altri casi, invece, trasla il succo, o il valore, che si può trarre da ogni singolo exemplum per provare l’universalità del linguaggio che va elaborando. Ad esempio, la parte dedicata all’alchimia umana (che si può riassumere con questa citazione: “Ogni persona e ogni istituzione deve impegnarsi a viso aperto con il mondo che cambia e mescolarsi coraggiosamente con esso, non per diventare migliori ma per diventare diversi”) funziona benissimo come una delle migliori introduzioni all’importanza dell’interdisciplinarità nella ricerca.
C’è un aspetto, però, più di tutti, che lega l’intero discorso di Hollander e che quasi al principio, in un paragrafo, è apertamente esplicitato. È il parallelo tra il passaggio critico dal XIX al XX Secolo e le lunghe e reiterate transizioni di cui è innervata la nostra epoca; tra una fase di intense trasformazioni economiche e di correlati conflitti sociali, con forte divaricazione di classe e di “ruoli”, e una fase in cui la combinazione di crisi ecologica e incombenti orizzonti di ulteriore rivoluzione tecnologica stanno generando dinamiche analoghe. In questo raffronto il basket, per Hollander, non può che rilanciarsi spontaneamente, perché inventato in un momento in cui vi era bisogno proprio di ciò che serve tuttora: un’occasione facilmente approcciabile per rieducarsi e avvicinarsi reciprocamente, e per scoprire uno scopo capace di stimolare empatia, idee nuove ed emancipazione. Non a caso, l’ultimo capitolo è intitolato alla trascendenza: perché “la fatica deve andare di pari passo con l’aspirazione”; e del resto “per segnare devi scendere lungo il campo ma poi devi anche salire!”. Ecco, Hollander, riannodandosi all’esperienza di James Naismith, il geniale creatore di questo sport, ci fa capire non tanto che alla base della rifondazione politica di cui il mondo ha bisogno ci dev’essere una radicale istanza etica, quanto che quest’ultima non può esistere se non per mezzo di infrastrutture concrete in cui metterla alla prova e assimilarla ex novo.
Recensioni (di M. Pettene; di U. Zapelloni)