
Simon Sunderson è un forte e dedito bevitore, assomiglia moltissimo a Robert Duvall ed è un ex poliziotto del Michigan, fresco di pensione. Decide di dare la caccia ad un ambiguo santone, il Grande Capo, che si sposta di stato in stato e si fa chiamare in molti modi, anche Re Davide. Sunderson sospetta che questo personaggio approfitti della sua setta per abusare di ragazze adolescenti, ma gli mancano le prove decisive. Ne segue le tracce fino in Arizona, dove si reca per andare a trovare la madre ultra-ottantenne. Si fa aiutare da Mona, una giovane hacker che abita accanto a lui e che gli sollecita sensazioni contrastanti: da un lato, ne è irresistibilmente attratto; dall’altro, prova sentimenti paterni. Sunderson, infatti, dopo il divorzio da Diane, è rimasto solo, ed è costantemente in cerca di avventure e di relazioni umane più o meno solide. Le uniche cose che paiono dargli equilibrio sono la pesca al salmerino, le lunghe camminate nella natura più selvaggia e la compagnia dell’amico Marion, che fa il preside di una scuola ed è di origini indiane. La cultura e le tragiche vicissitudini dei nativi americani hanno sempre affascinato Sunderson, che ha un passato di brillante laureato in storia. Ora ritiene che queste conoscenze gli possano essere utili per il caso, e che – complici le suggestioni prodotte dallo studio di un fortunato saggio accademico: Sunderson acquista e legge molti libri – lo possano aiutare a capire il sincretismo religioso e la psicologia distorta di Re Davide e dei suoi accoliti. Proprio qui si manifesta il vero cuore del romanzo e della ricerca di Harrison. La detective story è solo un pretesto, destinato a sciogliersi tra vagabondaggi, piccole peripezie e qualche intermezzo erotico, con un epilogo tanto scontato quanto casuale e addirittura goffo. Quello che conta, invece, è il viaggio, il disorientamento, con la dinamica autoriflessiva generata nell’anziano protagonista e nella sua lotta con i fantasmi personali e con quelli della nazione bianca. Sunderson-Harrison fa i conti con la vecchiaia, con la sua biografia e con quella del Paese, e così facendo si immerge e si perde nel paesaggio e si spoglia del proprio io, cercando di mettersi in contatto con le radici dell’America per integrarsi in un ordine spontaneo e istintivo. La caccia all’uomo, quindi, diventa una caccia rituale, iniziatica, animata anche da simboliche opposizioni letterarie: tra una consolidata immagine posticcia (il mito suggestivo ma artefatto dei Classici americani di D.H. Lawrence) e un’esperienza di fiduciosa adesione alla natura primigenia e avvolgente delle cose (seguendo i passi di Gary Snyder). Questo Harrison è lo stesso di Ritorno sulla terra. Chi ha amato quelle atmosfere, amerà mettersi anche sulle orme del Grande Capo.
Recensione (di P. Dexter)
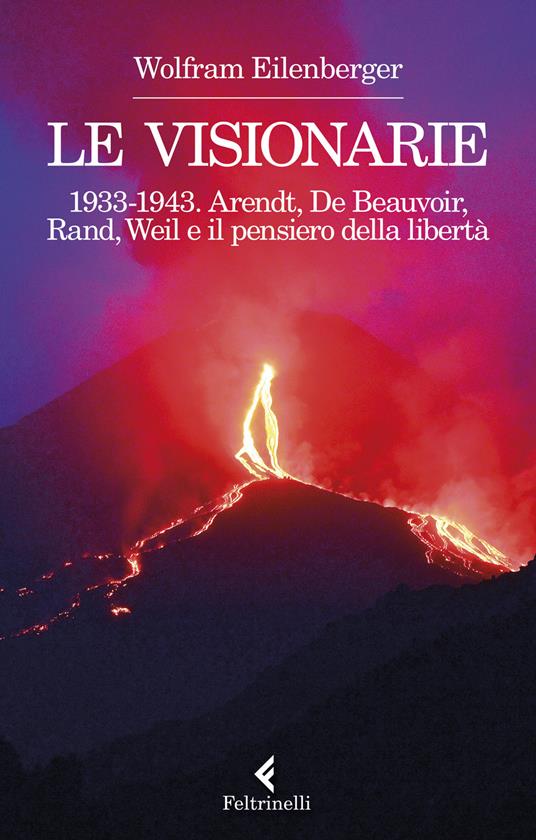
Qualche anno fa, con Il tempo degli stregoni, Wolfram Eilenberger ha illustrato l’itinerario speculativo di quattro giganti della tradizione filosofica novecentesca (Benjamin, Cassirer, Heidegger e Wittgenstein). Non lo ha fatto in modo didascalico. Ha mescolato le carte: ha isolato un decennio (1919-1929) e all’interno di ogni capitolo, dedicato volta per volta a uno specifico torno di anni, ha alternato spezzoni di biografia a opere di ciascuno dei suoi campioni. Ne ha seguito i pensieri e le vicissitudini, osservandoli in vitro, nell’impasto di vita e teoria, e nella fase in cui sono diventati ciò per cui vengono ancor oggi ricordati. Con Le visionarie Eilenberger compie la stessa operazione su quattro protagoniste assolute: Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand e Simone Weil. E questa volta si concentra su un altro decennio, particolarmente drammatico: 1933-1943. L’effetto è ancor più convincente, oltre che coinvolgente. Lo è senz’altro per l’efficacia delle singole ricostruzioni. È difficile, in effetti, capire la Arendt senza il racconto del suo originario scavo sul rapporto tra ebrei e cultura nazionale. Al contempo, è essenziale, per comprendere l’Autrice del Secondo sesso, assistere allo snodarsi progressivo della vita libera di Simone de Beauvoir e al singolare ménage costruito con Sartre e con le loro giovani frequentazioni. Lo stesso si può dire per l’importanza del significato quasi iniziatico della sofferenza e del rapimento costante cui si sottopone Simone Weil, o per la centralità della prolifica, assorbente ostinazione di Ayn Rand, per la quale il teatro e il romanzo altro non sono che i veicoli migliori per immettere nel sogno americano le proiezioni libertarie che soltanto chi è fuggito dalla Rivoluzione d’Ottobre poteva concepire con tale determinazione.
Le visionarie è un libro riuscito non solo perché raccoglie medaglioni molto espressivi. Il suo punto forte consiste nell’aver portato ad un grado di perfezionamento ulteriore l’approccio seguito ne Il tempo degli stregoni: affiancare idee e identità apparentemente distanti, e parlarci così di ciò che le accomuna, dello spirito di un momento storico cruciale e dell’interazione tra questo spirito e l’esistenza individuale. C’è qualcosa di hegeliano in questa impostazione; nulla di più adatto, in verità, per guardare alle matrici delle più significative letture critiche sulle grandi ideologie del Novecento. In un passaggio del libro – in cui si esplica con chiarezza quale sia l’elemento che per l’Autore avvicina visioni tanto diverse – il metodo affiora chiaramente: “Colui o colei che abbraccia la filosofia oscilla tra due figure opposte: l’Asociale, portatore di idee devianti, e il Profeta di una vita autentica, di cui è possibile scovare e decifrare le tracce anche nel trionfo della falsità. In ogni caso, questo schema permette di definire il ruolo che all’inizio degli anni trenta Ayn Rand – e con lei la Weil, Arendt, de Beauvoir – assume con sempre maggiore consapevolezza. Non si tratta di una scelta esplicita. Semplicemente, esse si accorgono della propria radicale diversità. E condividono una certezza di fondo: che a essere bisognosi di cura non sono loro ma gli altri. Se possibile: tutti gli altri” (p. 80). È un punto di vista che costituisce tuttora il lascito più influente delle grandi donne di cui Eilenberger tratta, e che rappresenta la bussola non solo per orientarsi tra le pagine di un saggio davvero molto affascinante, ma anche per ragionare un po’ meglio sui rapporti tra identità e discorso pubblico nell’epoca attuale.
Recensioni (di A. Ambrosio; A. Benini; C. Consoli; D. Gabutti)