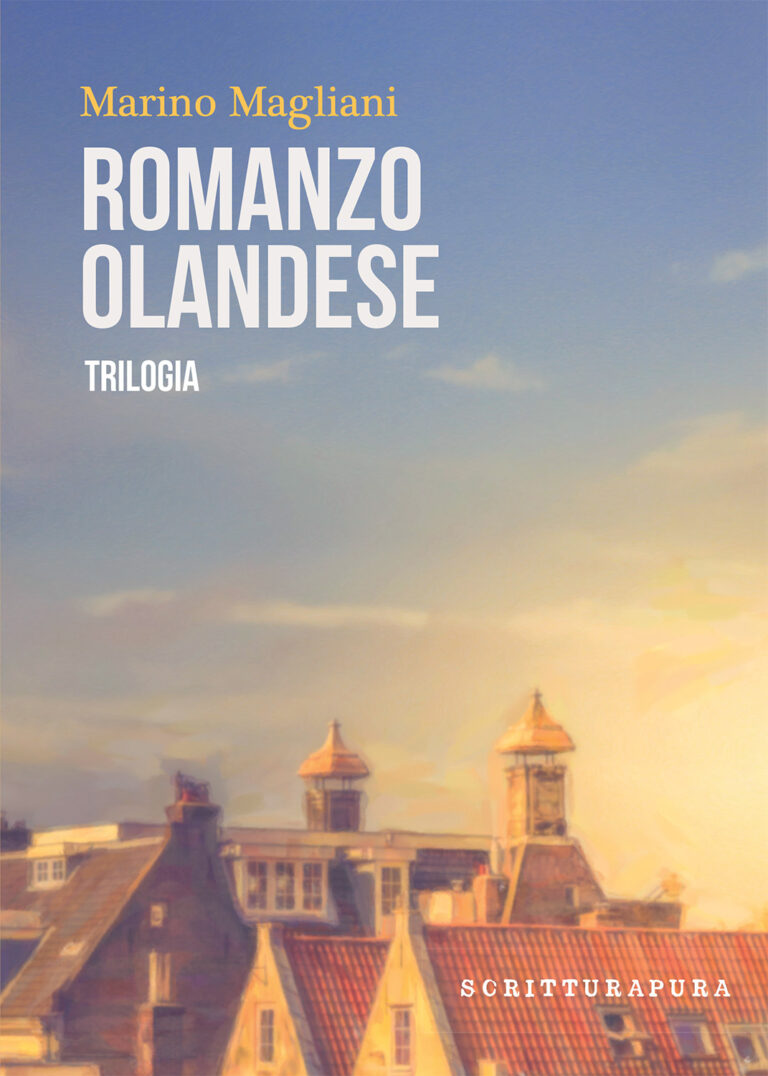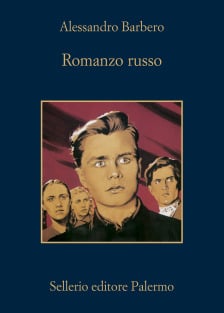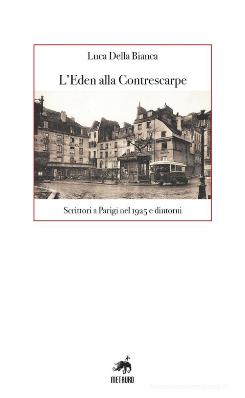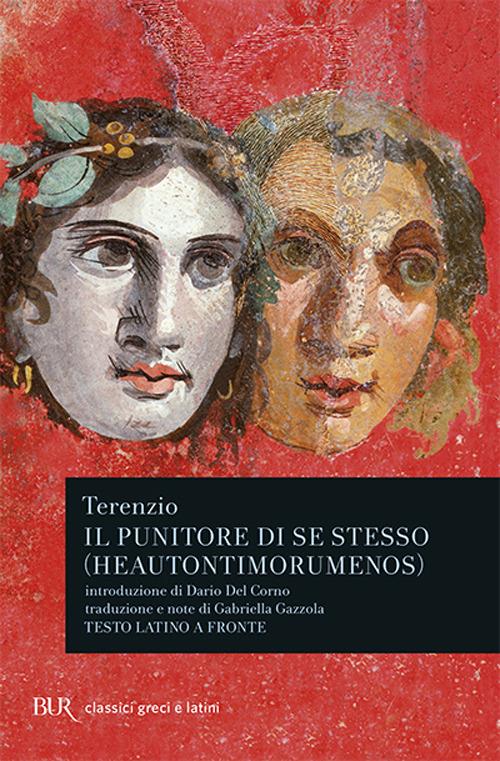
Pur essendo facoltoso, Menedemo si affanna tutto il giorno a lavorare la terra, anche nelle ricorrenze festive. Vuole, a suo modo, espiare quella che ritiene la sua colpa più grande: l’aver impedito le nozze del figlio Clinia, che dunque, non avendo potuto sposare la giovane Antifilia, è partito come mercenario alla volta dell’Oriente. Cremete, che di Menedemo è il vicino, cerca di consigliarlo, mosso dalla più umana sollecitudine. Nel frattempo, peraltro, Clinia è tornato ed è addirittura giunto segretamente a casa di Cremete, fingendo di portare con sé proprio la sua donna, che in verità è Bacchide, la cortigiana di cui è irresponsabilmente innamorato Clitifone, figlio di Cremete. Una simile messinscena è frutto di una delle prime astuzie del servo Siro, che spera così, tutelando Clitifone dalle possibili ire del padre, potenzialmente impaurito da un fidanzamento rischioso, di ricevere qualche vantaggio. Il fatto è che Sostrata, moglie di Cremete, scopre che l’ancella di Bacchide – che altri non è che Antifilia – è la figlia che aveva abbandonato neonata su ordine del marito; e che, quindi, è viva e vegeta. Gli eventi, allora, accelerano improvvisamente, le parti si scambiano ed è Menedemo, infine, trovata l’insperata occasione per riconciliarsi col figlio, a soccorrere Cremete, indirettamente stimolandogli un duro stratagemma per dare una lezione a Clitifone e riportare in famiglia l’equilibrio tanto desiderato.
Perché leggere questa commedia di Publio Terenzio Afro? Formalmente le ragioni sono tante; tutte quelle che già si possono apprendere sui banchi del liceo. E dunque: perché è esemplare dell’originalità del teatro Terenziano e delle mutazioni da esso indotte; perché vi si trova, per bocca di Cremete, la prima testimonianza scritta di una sensibilità universale (“Homo sum: humani nihil a me alienum puto”); perché la figura di Menedemo (il punitore di se stesso, come recita il titolo greco, lo stesso della commedia di Menandro, che Terenzio riprende), ha ispirato le scelte esistenziali di grandi poeti (da Baudelaire a Gozzano); perché – come è stato bene sintetizzato – l’Heautontimorumenos ha canonizzato anche il tema padri e figli, ben prima di Turgenev, aggiungeremmo (e, visto che è una commedia, ben prima di Totò e Aldo Fabrizi); perché – ciò dovrebbe essere d’interesse pure per i giuristi – lo stratagemma finale messo in atto da Cremete passa per una soluzione tecnico-giuridica, a sigillo della pregnanza diffusa della cultura giuridica e dei suoi evoluti e sofisticati dispositivi nella cultura popolare romana; perché il manoscritto più antico dell’opera è ben conservato e leggibile online, anche nelle sue miniature eccellenti, sul portale delle collezioni vaticane; e perché, infine, la sola rassegna di tutti questi profili fa apprezzare che cosa sia un classico, nella sua proverbiale ricchezza e polivalenza. Senza dire del fatto che viene voglia di prendere le pagine del manuale di letteratura latina di Concetto Marchesi, dove si può reperire un riassunto ancor più analitico della commedia.
Tuttavia c’è anche un altro motivo per accostarsi a questo piccolo capolavoro, in cui, tra l’altro, e come si dice espressamente nel Prologo, “la trama unitaria del modello si complica in un duplice intrigo”. Il motivo – non si consideri questa affermazione come un’arbitraria deminutio – è che il cenno iniziale all’umanità del rapporto tra Cremete e Menedemo, lungi dall’anticipare paradigmi fin troppo moderni (e salve le discussioni sul clima del cd. “Circolo degli Scipioni”), predispone l’animo del lettore a un atteggiamento di assoluta disponibilità e comprensione; di calma e fiducia, cioè, nella relazione intersoggettiva più autentica e partecipe, che non a caso supera ogni genere di inganno, alimentando solidarietà e reciprocità di contegno e di rispetto, ed anche ottimismo per il futuro. Mi sembra che sia questo il vero lascito – morale e financo pedagogico – del pezzo terenziano, che invita alla prossimità e alla redenzione individuale che solo l’amicitia può garantire, e lo fa in una semplicissima vicenda, a sua volta esemplare di rapporti normalmente egoistici ed emulativi. Il che, al fondo, vuol dire che, di fronte ad un problema, chiudersi in se stessi non garantisce alcun destino.