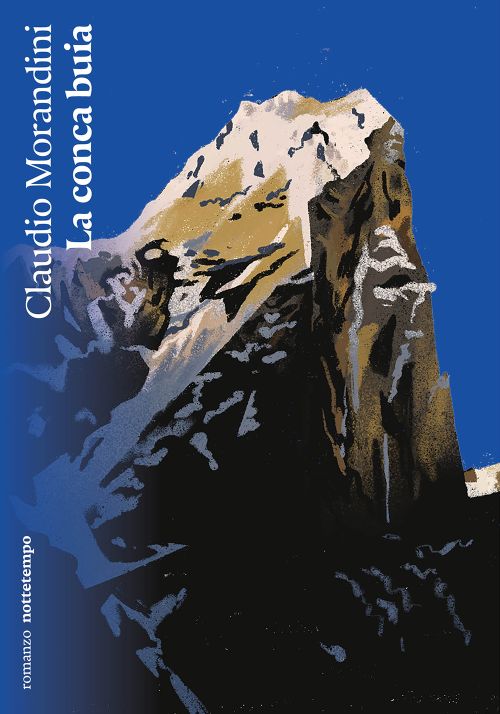
Franco Gavaglià è sindaco di un piccolo comune. Viene da una frazione di montagna, dove è cresciuto in baita, sopportando le difficoltà di una vita, e di una natura, aspra e le continue violenze, terribili, del padre. Soltanto negli anni dell’università è riuscito a realizzare il suo sogno di fuga e a costruirsi uno spazio autonomo di riconoscimento sociale. Ora si avvicina una nuova campagna elettorale e, a quanto dice il suo vice, occorre inventarsi qualcosa di efficace per continuare a convincere gli elettori e contrastare le mire dell’altro candidato, il temibile Ursini. È questa la scena in cui si articola la storia che le stesse parole di Gavaglià percorrono passo dopo passo, nel suo rivolgersi, un po’ pacato e sollecito, ma anche un po’ disilluso, alla figlia Leda. Ed è una storia che, in parte, è buia come la conca in cui il piccolo Franco cercava rifugio, sui monti, lontano dalle angherie paterne; e in altra parte, invece, è semplicemente trista, perché disseminata da un sentimento diffuso di soffocato rancore e di reiterato fallimento. Il fatto è che, al termine di un farsesco e calcolato tentativo di comunicazione elettorale – nel quale il protagonista cerca di ripescare l’anziano padre e farne l’esempio inverosimile di antiche e formidabili virtù, e di un rapporto filiale autentico – il disastro, per Gavaglià, si presenta in tutta la sua inevitabile dimensione.
Quello di Morandini è libro duro, che macina dentro. Inoltre, contiene moltissime sollecitazioni. Non è soltanto un antidoto alle troppo facili idealizzazioni di certi ambienti, considerati sempre, romanticamente, come primigeni e fortificanti. È anche una somma di parabole: sul rapporto padri-figli, come, più in generale, sulle relazioni, e incomprensioni, tra generazioni diverse; sulla pochezza di un modo ben noto di fare politica; sulle insidie delle ambizioni e dei traumi più radicati e irrisolti; sull’ostinata, ma terribile, tendenza a restare pur sempre vincolati a un’idea troppo personale delle proprie origini; sul bisogno, reale, di interlocuzioni più umane e comprensive. La conca buia, poi, è anche il trattamento perfetto per una commedia nera, che funzionerebbe molto bene sia in teatro, sia al cinema. Più di tutto, però, a stupire è lo stile o, meglio, il tono della narrazione. Che si tiene sul registro agro e disincantato della nevrosi; dell’amara consapevolezza, cioè, che solo chi è davvero afflitto o malato sa provare fino in fondo. Ci troviamo, dunque, di fronte a una scrittura molto più studiata ed elaborata di quanto possa apparire: un esperimento di sintonia – tra verbo e argomento – che può dirsi riuscito.
PS: a conferma della lungolatenza delle suggestioni che questo romanzo sa imprimere su chi lo legge, non resisto a esprimere la sensazione che questo Autore abbia una spiccata sensibilità leopardiana. Anche la Natura di Morandini non si arresta, né si accomoda, di fronte a nulla…
Recensioni (di S. Bonazzi; di G. Gala; di G. Montieri; di A. Pisu)

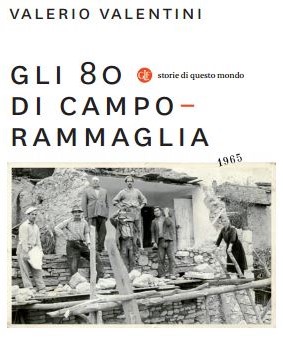
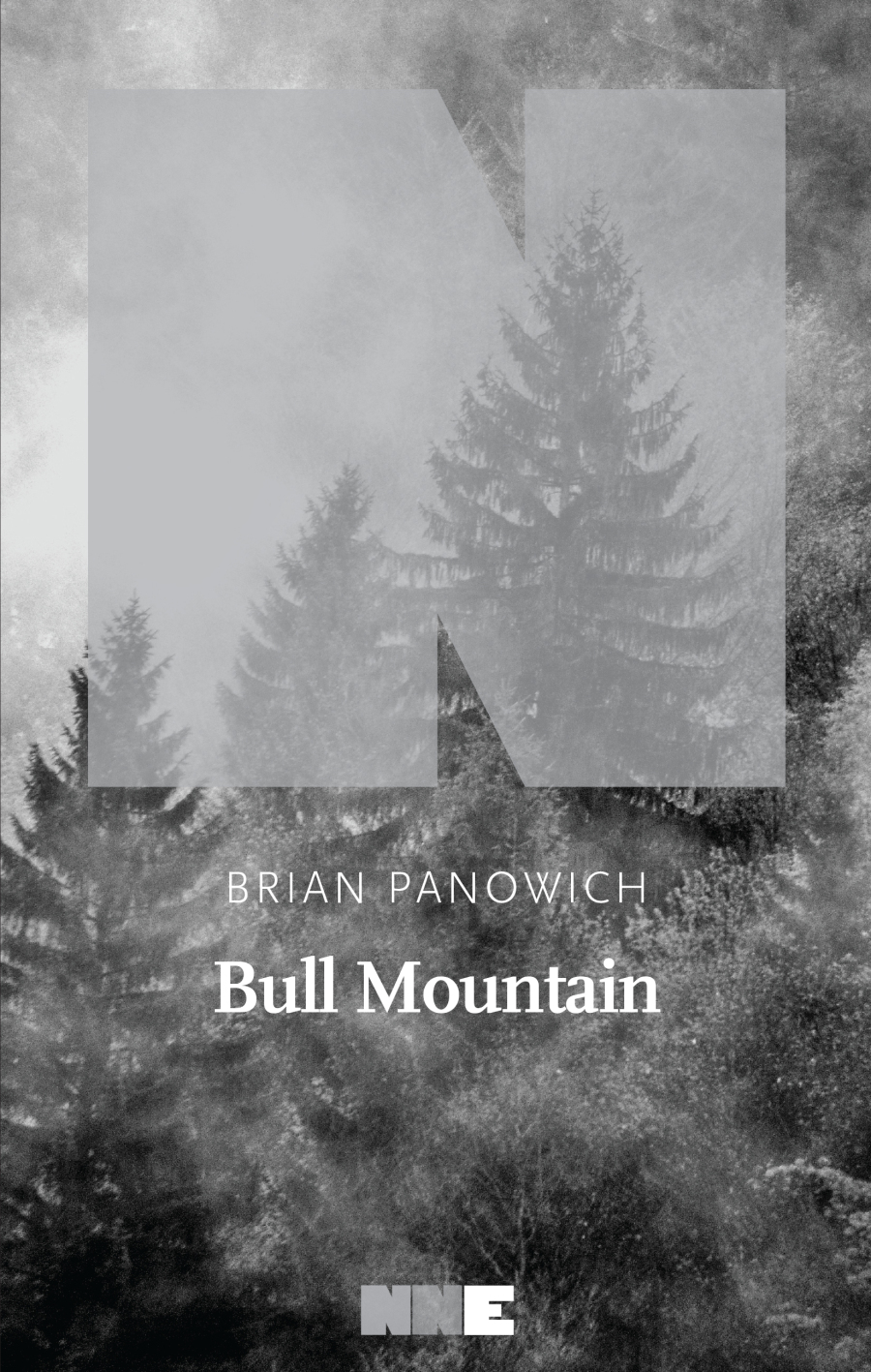

 Nella classica notte buia e tempestosa, lungo una strada fangosa delle montagne dell’Alto Vicentino, una ragazza viene accoltellata. Prima di morire, però, riesce a consegnare alcuni misteriosi documenti a Gigi Marcante, un giovane geometra che, pur restando anonimo, non esita a denunciare l’accaduto ai carabinieri, ai quali trasmette anche copia di quelle strane carte. Entrano subito in gioco tutti gli altri personaggi: il maresciallo Piconese e i suoi uomini, da una parte; il giornalista Andrea Rezzonico, la postina Silvana e suo fratello Nello, dall’altra. Cercano di risolvere il caso, per trovare l’assassino, ancora a caccia del suo prezioso bottino, ma anche per capire se gli enigmi nascosti dietro le parole e i segni di quello strano e composito lascito vi sia la possibilità di recuperare un tesoro. È un rebus in piena regola e l’intreccio è subito intrigante: alcune tracce, infatti, portano verso una singolare comunità religiosa, abbarbicata su quelle montagne e devota custode delle antiche radici del
Nella classica notte buia e tempestosa, lungo una strada fangosa delle montagne dell’Alto Vicentino, una ragazza viene accoltellata. Prima di morire, però, riesce a consegnare alcuni misteriosi documenti a Gigi Marcante, un giovane geometra che, pur restando anonimo, non esita a denunciare l’accaduto ai carabinieri, ai quali trasmette anche copia di quelle strane carte. Entrano subito in gioco tutti gli altri personaggi: il maresciallo Piconese e i suoi uomini, da una parte; il giornalista Andrea Rezzonico, la postina Silvana e suo fratello Nello, dall’altra. Cercano di risolvere il caso, per trovare l’assassino, ancora a caccia del suo prezioso bottino, ma anche per capire se gli enigmi nascosti dietro le parole e i segni di quello strano e composito lascito vi sia la possibilità di recuperare un tesoro. È un rebus in piena regola e l’intreccio è subito intrigante: alcune tracce, infatti, portano verso una singolare comunità religiosa, abbarbicata su quelle montagne e devota custode delle antiche radici del  1978: Lucilla è innamorata di Ilio, alpinista estremo; vive l’esplosione della sua passione come una fondamentale opportunità di rinascita, nella quale la maternità si palesa come un evento quasi provvidenziale, rispetto ad un passato di emarginazione e alcolismo. Nel 2012, nello stesso paese della montagna trentina, Anna si trova a tavola con i suoi più stretti familiari e sta vivendo un dramma terribile: la nascita improvvisa, inattesa, incompresa, di un bambino di cui non aveva mai percepito la presenza, confuso con i sintomi di un dolore lontano e massacrante, il risultato della solitudine cui è stata condannata dalle persone da cui si sarebbe aspettata amore e protezione. Nel 1627 Gheta, originaria di quel medesimo luogo, è accusata di stregoneria e viene torturata brutalmente; per le autorità la responsabilità della povertà del raccolto e degli eventi naturali che hanno piagato il territorio non può che essere imputata alla donna più eccentrica, a chi sostiene di aiutare le altre donne a liberarsi delle loro malattie e paure, a colei che può essere accusata anche di aver ucciso il proprio figlio. Lucilla sente e vede, nel sonno, il dolore di Gheta; Anna cerca aiuto nei consigli di una vecchia e preveggente Lucilla; Gheta sa già come tutto andrà inevitabilmente a finire. E così Ilio muore in una spericolata spedizione himalayana e Lucilla impazzisce dal dolore, rifiutando il frutto di quell’amore, entrando in cortocircuito con se stessa e con gli altri, e finendo in un ospedale psichiatrico giudiziario; Anna viene nuovamente tradita da chi le sta più vicino, in un percorso di negazione e rinnovata solitudine che non può che finire al cospetto del carcere; Gheta viene graziata, sicché la sua morte non sarà sul rogo, ma sul ceppo della decapitazione.
1978: Lucilla è innamorata di Ilio, alpinista estremo; vive l’esplosione della sua passione come una fondamentale opportunità di rinascita, nella quale la maternità si palesa come un evento quasi provvidenziale, rispetto ad un passato di emarginazione e alcolismo. Nel 2012, nello stesso paese della montagna trentina, Anna si trova a tavola con i suoi più stretti familiari e sta vivendo un dramma terribile: la nascita improvvisa, inattesa, incompresa, di un bambino di cui non aveva mai percepito la presenza, confuso con i sintomi di un dolore lontano e massacrante, il risultato della solitudine cui è stata condannata dalle persone da cui si sarebbe aspettata amore e protezione. Nel 1627 Gheta, originaria di quel medesimo luogo, è accusata di stregoneria e viene torturata brutalmente; per le autorità la responsabilità della povertà del raccolto e degli eventi naturali che hanno piagato il territorio non può che essere imputata alla donna più eccentrica, a chi sostiene di aiutare le altre donne a liberarsi delle loro malattie e paure, a colei che può essere accusata anche di aver ucciso il proprio figlio. Lucilla sente e vede, nel sonno, il dolore di Gheta; Anna cerca aiuto nei consigli di una vecchia e preveggente Lucilla; Gheta sa già come tutto andrà inevitabilmente a finire. E così Ilio muore in una spericolata spedizione himalayana e Lucilla impazzisce dal dolore, rifiutando il frutto di quell’amore, entrando in cortocircuito con se stessa e con gli altri, e finendo in un ospedale psichiatrico giudiziario; Anna viene nuovamente tradita da chi le sta più vicino, in un percorso di negazione e rinnovata solitudine che non può che finire al cospetto del carcere; Gheta viene graziata, sicché la sua morte non sarà sul rogo, ma sul ceppo della decapitazione.