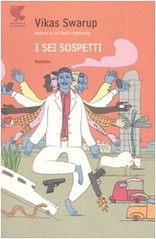Si vede ancora, non solo d’estate, su qualche rete locale; è sempre una sorpresa, al di là di ciò che possono pensare gli amanti delle series d’Oltreoceano o dei celebrati successo del momento. Non ci si può proprio vergognare, infatti, di considerare tuttora fondamentale un film con John Wayne, soprattutto quando è diretto dal regista che lo ha “creato” e che, in quest’occasione, inspiegabilmente valutata come minore anche dalla critica più tradizionale, lo propone nella sua versione più “completa”. D’altra parte si tratta di essere anche in buona compagnia: leggo che Nanni Moretti (sic) ricorda Soldati a cavallo (1959) come il primo film che ha avuto modo di vedere, assieme a suo padre, e che alla domanda su quali fossero i tre più grandi registi della storia del cinema Orson Welles (niente di meno che…) avrebbe risposto “John Ford, John Ford e ancora John Ford”. Possono bastare questi testimonials per decidere di non cambiare canale?
Il film trae spunto da un fatto realmente accaduto durante la Guerra di Secessione: un colonnello nordista “taglia” tutto il territorio confederato per penetrarvi nel mezzo e per sabotare un importante snodo ferroviario delle retrovie sudiste. John Wayne interpreta quel colonnello alla perfezione, ma non solo per il fatto che ne ritrae i lineamenti nel modo più verosimile di una compiuta e riuscita retorica made in U.S.A.; questa è la consueta “sovrastruttura”, come sempre in John Ford. Quello che conta è “sotto traccia”: è, cioè, in un sorprendente e ripetuto gesto critico, che, pur enfatizzando un militarismo mai rinnegato, prende a bersaglio gli orrori del conflitto fratricida ed esalta una sensibilità ed un senso del dovere senza “patina”, perché sostenuti, e resi “tragici”, da ragioni umanissime e insospettabili.
Non c’è soltanto l’epica, tuttavia; c’è anche la commedia, rilanciata dalla complicità di William Holden (nelle parti del Maggiore Kendall) e Constance Towers (nei panni di Miss Hannah Hunter), come di alcune impagabili figure comprimarie (ad es. quella del Sergente Maggiore Kirby), in una fusione di tempi e di ritmi che, lungi dal contraddire il tono e il filo della narrazione, rende Wayne ancor più verosimile. Oltre a tutto questo, però, c’è soprattutto l’assoluta maestria di Ford: la carica sudista a Newton, specialmente, dovrebbe essere vista e rivista…
Un ricordo di John Ford, di Leonardo Locatelli
Tutto John Ford in 40 secondi (su Radio3)
Un documentario su John Ford (con John Wayne)
La scheda su Ford (da www.scaruffi.it)