 L’avventura comincia il 23 novembre 1932. L’io narrante è in viaggio, in un trenino diretto verso una stazione sperduta ai confini orientali del Regno, dove approda soltanto a notte fonda. Dopo uno stranissimo assopimento, il giovane “aiutante volontario di cancelleria” ricorda di essere giunto lì, ad Aidussina, oggi Slovenia occidentale e allora limite estremo dell’Italia, per prendere servizio nella locale pretura. Il suo esordio nell’amministrazione, in verità, era già avvenuto a Pontebba, ma c’era rimasto poco: giusto il tempo di conoscere il cancelliere Cadringher, il pretore Zolla Carbonero e lo sbandato Carlo Fohn, nel loro intreccio di nostalgie austriacanti, miserie umane e sventure di confine. Su queste si era ben presto scagliata la furia ordalica dell’Alto Commissario Speciale per la Giustizia, il terribile e inflessibile Mordace, che ottiene anche il trasferimento d’ufficio del nostro eroe. Uno scenario consimile, tuttavia, lo attende anche ad Aidussina, dove si abitua subito a galleggiare, da perfetto impiegato imboscato, e dove diventa complice delle meschinerie del pretore Merdicchione e del cancelliere Semitecolo, passando le sue giornate tra il pokerino pomeridiano nell’ufficio del giudice, gli appuntamenti conviviali nell’animata trattoria della Cermeli e le tante pause di lettura, noia e torpore. La giustizia di Mordace, implacabile, non tarda ad abbattersi anche su questo luogo, e così l’aspirante travèt finisce a Cividale, la provincia perfetta che aveva già cominciato a desiderare da tempo con tanto compiacimento. Le aspirazioni in parte si avverano, e non mancano le occasioni per stringere amicizie e sodalizi e per nuove avventure sentimentali. Ma il Caffè Longobardo non attrae i suoi avventori soltanto per il gioco del biliardo. Presto, infatti, il piccolo funzionario si infatua della bella, irraggiungibile e ambigua Ilde. Complice la sua tendenza ormai naturale allo spregio di ogni regola dell’ufficio, l’aiutante cancelliere si imbatte ancora nelle ire di Mordace e comprende che il suo futuro non può più essere in quella città: non gli resta che fingersi malato di picnolessia e sperare in un’aspettativa, che al fine gli viene concessa. La storia ovviamente non termina a Cividale, perché il sogno d’amore, tanto coltivato, viene amaramente frustrato dalle feroci determinazioni di Ilde, e in quel di Trieste giunge anche il momento della resa dei conti con Mordace e della possibile e salvifica fuga via mare. È così che, sul punto di imbarcarsi come scrivano di bordo alla volta dei mari orientali, il protagonista si chiede, prossimo al puntuale e ricorrente momento di sonnolenza, se riuscirà mai a vedere Singapore o se tornerà al paese natale, tra le onde del Lago Maggiore.
L’avventura comincia il 23 novembre 1932. L’io narrante è in viaggio, in un trenino diretto verso una stazione sperduta ai confini orientali del Regno, dove approda soltanto a notte fonda. Dopo uno stranissimo assopimento, il giovane “aiutante volontario di cancelleria” ricorda di essere giunto lì, ad Aidussina, oggi Slovenia occidentale e allora limite estremo dell’Italia, per prendere servizio nella locale pretura. Il suo esordio nell’amministrazione, in verità, era già avvenuto a Pontebba, ma c’era rimasto poco: giusto il tempo di conoscere il cancelliere Cadringher, il pretore Zolla Carbonero e lo sbandato Carlo Fohn, nel loro intreccio di nostalgie austriacanti, miserie umane e sventure di confine. Su queste si era ben presto scagliata la furia ordalica dell’Alto Commissario Speciale per la Giustizia, il terribile e inflessibile Mordace, che ottiene anche il trasferimento d’ufficio del nostro eroe. Uno scenario consimile, tuttavia, lo attende anche ad Aidussina, dove si abitua subito a galleggiare, da perfetto impiegato imboscato, e dove diventa complice delle meschinerie del pretore Merdicchione e del cancelliere Semitecolo, passando le sue giornate tra il pokerino pomeridiano nell’ufficio del giudice, gli appuntamenti conviviali nell’animata trattoria della Cermeli e le tante pause di lettura, noia e torpore. La giustizia di Mordace, implacabile, non tarda ad abbattersi anche su questo luogo, e così l’aspirante travèt finisce a Cividale, la provincia perfetta che aveva già cominciato a desiderare da tempo con tanto compiacimento. Le aspirazioni in parte si avverano, e non mancano le occasioni per stringere amicizie e sodalizi e per nuove avventure sentimentali. Ma il Caffè Longobardo non attrae i suoi avventori soltanto per il gioco del biliardo. Presto, infatti, il piccolo funzionario si infatua della bella, irraggiungibile e ambigua Ilde. Complice la sua tendenza ormai naturale allo spregio di ogni regola dell’ufficio, l’aiutante cancelliere si imbatte ancora nelle ire di Mordace e comprende che il suo futuro non può più essere in quella città: non gli resta che fingersi malato di picnolessia e sperare in un’aspettativa, che al fine gli viene concessa. La storia ovviamente non termina a Cividale, perché il sogno d’amore, tanto coltivato, viene amaramente frustrato dalle feroci determinazioni di Ilde, e in quel di Trieste giunge anche il momento della resa dei conti con Mordace e della possibile e salvifica fuga via mare. È così che, sul punto di imbarcarsi come scrivano di bordo alla volta dei mari orientali, il protagonista si chiede, prossimo al puntuale e ricorrente momento di sonnolenza, se riuscirà mai a vedere Singapore o se tornerà al paese natale, tra le onde del Lago Maggiore.
 Per il suggerimento di questa lettura devo ringraziare un anziano ma arguto avvocato di Tolmezzo. È un romanzo bellissimo, in effetti; non c’è da stupirsi che nel 1981, anno della sua prima pubblicazione, sia stato salutato da un notevole successo. Il motivo attorno al quale Piero Chiara costruisce la sua storia è tutto autobiografico: il primo attore è proprio l’Autore, che ha vissuto realmente il curioso apprendistato amministrativo descritto nel libro, dal quale ha tratto anche altri memorabili racconti (come Il pretore di Cuvio). Occorre dire che il gustoso e caustico ritratto che in questo testo viene offerto di certa burocrazia e delle sue gerarchie assume i tratti di qualcosa di eterno e invariabile. E in ciò ritroviamo conferma del fatto che l’impiego pubblico sa sempre dare grandi spunti alla migliore letteratura, come ha recentemente ricordato anche Luciano Vandelli. Ma il punto forte di Vedrò Singapore? è la graziosa semplicità con cui riesce a restituire un mondo intero, quello dell’antica e immarcescibile melmosità della provincia, delle sue istituzioni e dei suoi miti. Il protagonista vi scopre, da un lato, il luogo quieto e ideale per l’ingrasso dell’uomo senza grandi ambizioni, dall’altro il palcoscenico di un’educazione morale e affettiva tanto dubbia quanto naturalmente accettata. Non c’è spazio per un giudizio, neanche nei confronti delle autorità fasciste, certo incarnate dal feroce Mordace, che del resto non si palesa come titolare dell’arbitrio o della sopraffazione, bensì come castigamatti del vizio e dell’indolenza. Allo stesso tempo, il viaggio del nostro impiegato non nasconde nulla, neanche il grottesco, perché si tratta di un itinerario che si sovrappone a un processo di crescita e di maturazione che deve comunque compiersi e che si alimenta, così, necessariamente, di tutto ciò che può accadere. Se c’è qualcosa di cui Chiara e il suo personaggio – novello Renzo Tramaglino nel caos sensuale della vita extradomestica – non hanno paura è l’esperienza, anche quando è piccola, subdola o banale; d’altra parte, come dimostra la strana fascinazione del protagonista per la figura di Lunardini, anche in ciò che è dichiaratamente modesto e appartato può nascondersi il segreto della felicità. Vedrò Singapore? merita un ultimo appunto, quello sullo stile. A Chiara – che è, per così dire, un artigiano del mestiere d’artista – bastano poche e giuste parole di buonissimo italiano per costruire una fisionomia, dargli un nome, delineare una situazione, esprimere un’opinione, raffigurare un’azione. Ricorda da vicino Pratolini e Pirandello, ma la freschezza della lingua è spesso vicina a quella di Comisso. Questo romanzo va letto anche per le sue innegabili virtù espressive, come se fosse un manuale di una scrittura forse perduta per sempre.
Per il suggerimento di questa lettura devo ringraziare un anziano ma arguto avvocato di Tolmezzo. È un romanzo bellissimo, in effetti; non c’è da stupirsi che nel 1981, anno della sua prima pubblicazione, sia stato salutato da un notevole successo. Il motivo attorno al quale Piero Chiara costruisce la sua storia è tutto autobiografico: il primo attore è proprio l’Autore, che ha vissuto realmente il curioso apprendistato amministrativo descritto nel libro, dal quale ha tratto anche altri memorabili racconti (come Il pretore di Cuvio). Occorre dire che il gustoso e caustico ritratto che in questo testo viene offerto di certa burocrazia e delle sue gerarchie assume i tratti di qualcosa di eterno e invariabile. E in ciò ritroviamo conferma del fatto che l’impiego pubblico sa sempre dare grandi spunti alla migliore letteratura, come ha recentemente ricordato anche Luciano Vandelli. Ma il punto forte di Vedrò Singapore? è la graziosa semplicità con cui riesce a restituire un mondo intero, quello dell’antica e immarcescibile melmosità della provincia, delle sue istituzioni e dei suoi miti. Il protagonista vi scopre, da un lato, il luogo quieto e ideale per l’ingrasso dell’uomo senza grandi ambizioni, dall’altro il palcoscenico di un’educazione morale e affettiva tanto dubbia quanto naturalmente accettata. Non c’è spazio per un giudizio, neanche nei confronti delle autorità fasciste, certo incarnate dal feroce Mordace, che del resto non si palesa come titolare dell’arbitrio o della sopraffazione, bensì come castigamatti del vizio e dell’indolenza. Allo stesso tempo, il viaggio del nostro impiegato non nasconde nulla, neanche il grottesco, perché si tratta di un itinerario che si sovrappone a un processo di crescita e di maturazione che deve comunque compiersi e che si alimenta, così, necessariamente, di tutto ciò che può accadere. Se c’è qualcosa di cui Chiara e il suo personaggio – novello Renzo Tramaglino nel caos sensuale della vita extradomestica – non hanno paura è l’esperienza, anche quando è piccola, subdola o banale; d’altra parte, come dimostra la strana fascinazione del protagonista per la figura di Lunardini, anche in ciò che è dichiaratamente modesto e appartato può nascondersi il segreto della felicità. Vedrò Singapore? merita un ultimo appunto, quello sullo stile. A Chiara – che è, per così dire, un artigiano del mestiere d’artista – bastano poche e giuste parole di buonissimo italiano per costruire una fisionomia, dargli un nome, delineare una situazione, esprimere un’opinione, raffigurare un’azione. Ricorda da vicino Pratolini e Pirandello, ma la freschezza della lingua è spesso vicina a quella di Comisso. Questo romanzo va letto anche per le sue innegabili virtù espressive, come se fosse un manuale di una scrittura forse perduta per sempre.
Recensioni (di Renzo Montagnoli; di Luigi Fattorini)
L’introduzione al libro (di Mauro Novelli)

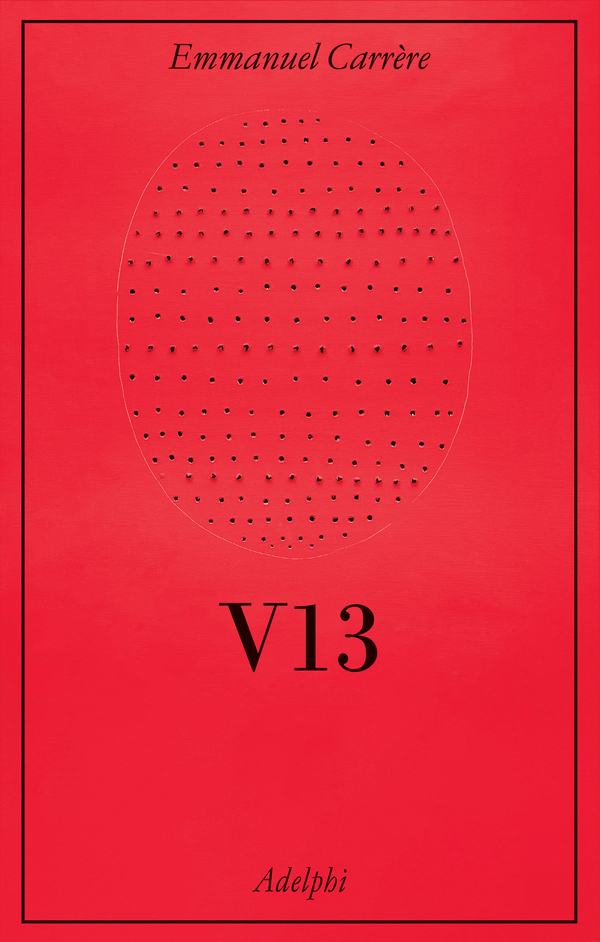



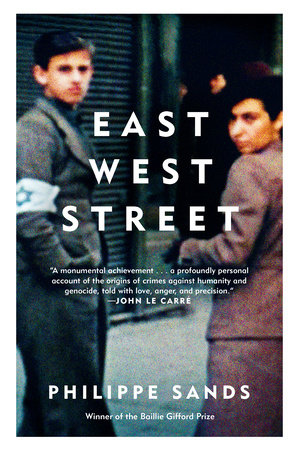


 Per il suggerimento di questa lettura devo ringraziare un anziano ma arguto avvocato di Tolmezzo. È un romanzo bellissimo, in effetti; non c’è da stupirsi che nel 1981, anno della sua prima pubblicazione, sia stato salutato da un notevole successo. Il motivo attorno al quale
Per il suggerimento di questa lettura devo ringraziare un anziano ma arguto avvocato di Tolmezzo. È un romanzo bellissimo, in effetti; non c’è da stupirsi che nel 1981, anno della sua prima pubblicazione, sia stato salutato da un notevole successo. Il motivo attorno al quale 
