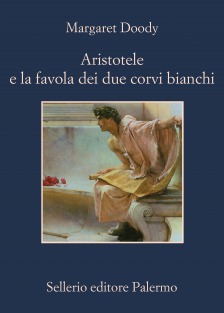L’Autrice di questo piccolo saggio è una nota e autorevole studiosa dei diritti dell’antichità. Che ha deciso di affrontare senza molte cerimonie un argomento potenzialmente scomodo, ossia la relativizzazione, o contestualizzazione storica, dell’Antigone di Sofocle. D’altra parte, nei secoli, il personaggio Antigone è diventato un mito a tutti gli effetti: un modello di resistenza all’abuso del potere; un’icona delle garanzie dei diritti fondamentali e, come tali, irrinunciabili; un’eroina univocamente simbolica e indiscutibile. Lo aveva ricostruito bene, da par suo, George Steiner, in un volume che funge da base forte anche per Eva Cantarella. Quindi non è cosa facile restituire la famosissima tragedia alla sua primigenia complessità; a un livello di lettura, cioè, nel quale le parti risultano più equivoche di quanto siamo stati abituati a pensare. In quest’ultimo senso, però, la tesi dell’Autrice non fa sconti: “Antigone era un’individualista, per la quale la polis non contava, non esisteva; per Creonte, dunque, era la personificazione dell’inconcepibile, dell’intollerabile, un pericolo inaccettabile” (p. 82). E ancora: “L’Antigone del mito non è una lettura ‘diversa’, è il travisamento del personaggio di Sofocle, è la sua trasformazione in un personaggio altro, operato in chiave antilluminista dal romanticismo letterario e filosofico” (p. 102). Per giungere a queste affermazioni, Eva Cantarella compie diverse operazioni: ricostruisce la collocazione dell’Antigone nella trilogia (tebana) cui appartiene; contrappone la figura dell’eroina ai lineamenti di altri personaggi, come la sorella Ismene o il marito Emone (figlio di Creonte); spiega il senso dell’ideologia e della prassi funerarie nella Grecia antica, con precisi commenti ad alcune famose pagine dell’Iliade; e infine illustra le perduranti inclinazioni sociali alla vendetta nell’Atene del V secolo, evidenziando proprio in questo frangente la prospettiva da cui interpretare correttamente l’opera sofoclea. Che non assume per principio una parte rispetto ad un’altra e che, viceversa, ammonisce sugli eccessi che possono mettere a rischio la città e le sue leggi, presidio di ogni possibile convivenza. Non c’è che dire: di questi tempi, non si tratta soltanto di un (condivisibile) invito all’intelligenza intrinseca dello studio più accurato; è un richiamo alla phronesis e alle sue (attualissime) declinazioni civili.
Recensioni (di A. Ambrosio; di P. Buttafuoco; di D. Fusaro)

 Dopo la monumentale prova de
Dopo la monumentale prova de