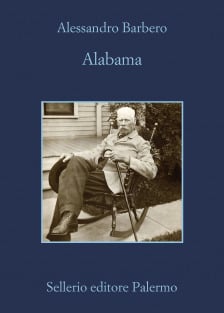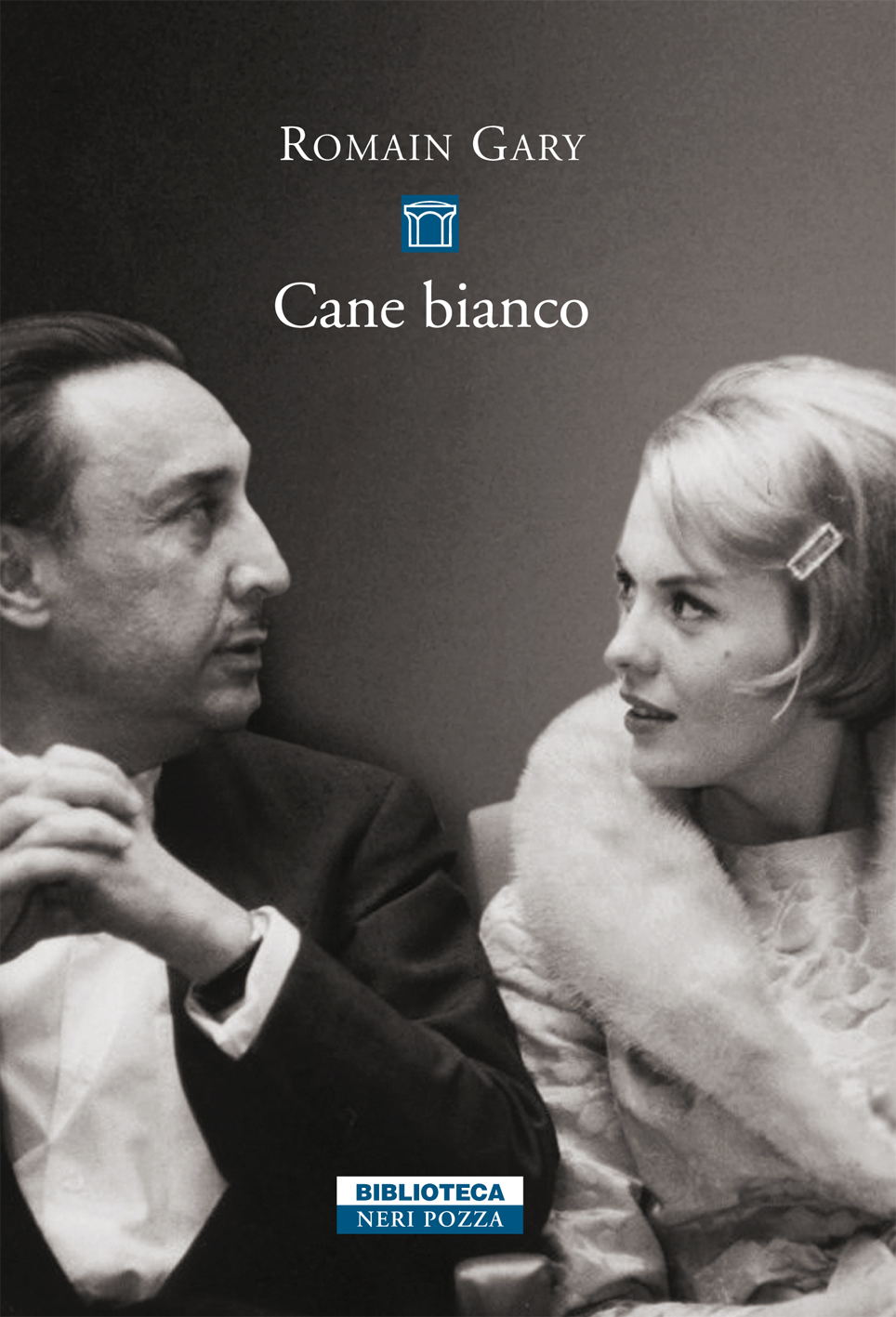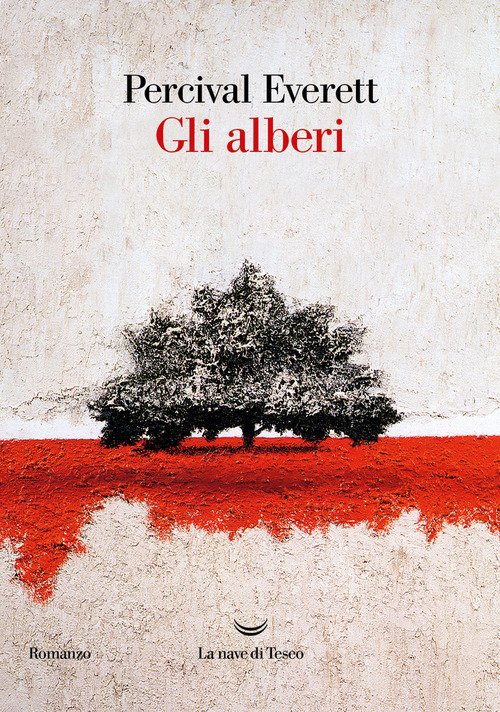
Money, Mississippi. Un piccolo centro abitato. Uno sputo di case nel Sud che più Sud non si può. Dove, all’improvviso, vengono barbaramente e misteriosamente uccisi, uno dopo l’altro, due uomini bianchi. Accanto ai quali è rinvenuto il cadavere, anch’esso pesto e malridotto, di un piccolo uomo di colore. Sempre lo stesso: perché dopo il primo delitto è scomparso dall’obitorio ed è ricomparso, quasi fosse un fantasma, sulla nuova scena del crimine. Che cosa sta succedendo? Lo sceriffo locale e i suoi due stolidi aiutanti poco ci capiscono. Entra in scena allora una coppia di investigatori della polizia statale, Ed e Jim, due detective di colore spediti fino a lì dagli headquarters di Hattiesburg. Nel frattempo muore allo stesso modo anche il coroner, “reverendo” Fondle, capo (nemmeno troppo occulto) del locale Ku Klux Klan. D’altra parte si scopre subito che i primi delitti sono connessi, perché gli avi dei defunti erano stati autori, nel 1955, di un terribile linciaggio, quello di Emmett Till, un ragazzo accusato – sic – di aver salutato una ragazza bianca. Un fatto storico realmente accaduto. E a morire, nella fiction, è pure Nonna C, la ragazza bianca protagonista di quell’evento. È forse una qualche forma di vendetta? La vicenda, però, si fa ancor più complessa e inesplicabile, perché i morti, con analoghe scene del delitto, si moltiplicano: a Chicago, in California e in altri luoghi del Mississippi e di tutta l’America. Tanto che entra in scena pure l’FBI. Mentre si comincia a comprendere che tutto ciò che sta accadendo riguarda non solo la gente di colore, ma ogni soggetto gravato dal peso di una qualche diversità.
Percival Everett riesce sempre a sorprendere. In parte, per aver deliberatamente e scopertamente scelto la forma del romanzo impegnato. Che va alle radici dei linciaggi che scossero l’America del movimento dei diritti civili, per riaccendere le coscienze in un tempo, quello di oggi, in cui il razzismo pare riemergere, attecchire e rinsaldarsi alle esplicite posizioni di una certa classe politica repubblicana. Siamo oltre Black Lives Matter: è una chiamata espressa ad INSORGERE; e a farlo, con Billie Holiday, sulle note strazianti di Strange fruit (il chiaro riferimento da cui è tratto il titolo del libro: “Southern trees bear strange fruit / Blood on the leaves and blood at the root / Black bodies swinging in the southern breeze / Strange fruit hanging from the poplar trees”). In altra parte, tuttavia, l’effetto stupefacente di quest’ultima prova letteraria è l’opzione stilistica per una sorta di fumettone, sospeso tra il satirico, l’ironico e il grottesco. I personaggi sono così carichi che il lettore non può non pensare a una sceneggiatura alla Tarantino. Al di là di ciò – ma senza rivelare nulla di più di quanto si è già scritto – la sensazione, specie per il pubblico italiano, è di trovarsi di fronte a un’avventura alla Dylan Dog, in uno scenario – letteralmente – da notte dei morti viventi. Come se Everett avesse seguito le ispirazioni dei peggiori incubi di Tiziano Sclavi. Dunque si può fare memoria anche così, combinando impegno civile e proiezione fantastica. Del resto, più si moltiplicano gli zombies dei vendicatori, più si rinominano, e si fissano, nero su bianco, i tantissimi casi delle violenze subite nel tempo dalla gente di colore. Sono quelli che, nel romanzo, raccoglie e custodisce l’enigmatica Mama Z, e che neanche il più giovane e talentuoso studioso (il Damon Thruff cui Mama Z apre le porte del suo archivio) riesce a razionalizzare utilmente. Perché parlano da soli, in effetti. O, quanto meno, dovrebbero parlare da solo, seppure soltanto l’assurdo e l’impensabile – ecco la denuncia paradossale di Everett – possano creare la chance per renderli attivi e terrificanti nelle coscienze di tutti. E per rivelare il carattere lunatico e introverso di una società politica alla deriva.