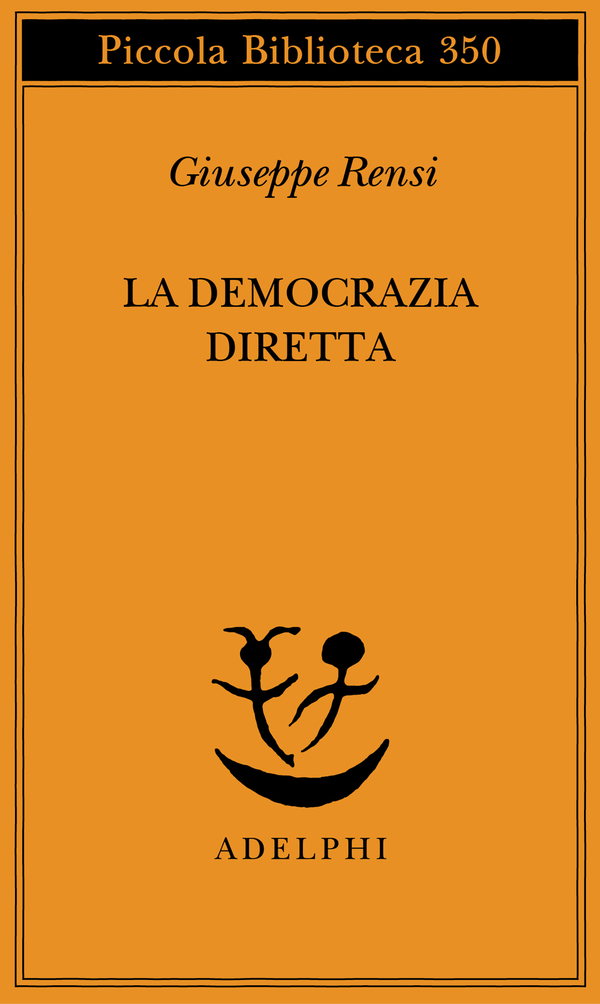 Per la preparazione di un convegno ho avuto modo di ripescare questa bellissima lettura, il cui titolo completo è Gli anciens régimes e la democrazia diretta, testo oggi disponibile anche on line con la premessa che fu di Arcangelo Ghisleri. Il volume adelphiano del 1995 riproduce l’ultima versione dell’opera e riporta in chiusura le due prefazioni che l’Autore – avvocato e filosofo socialista di natali svizzeri (1871-1941) – ha dedicato alle diverse e fortunate edizioni del libro (le due del 1902 e quella del 1926). La rilevanza del saggio va ben al di là di ciò che si può immaginare fermandosi alla copertina. La tesi del giovane Rensi è la seguente: tra gli assetti di potere dell’ancien régime e le forme di governo parlamentari può non esservi, di fatto, alcuna differenza se il popolo non ha la possibilità di intervenire direttamente per correggere le ricorrenti degenerazioni del governo rappresentativo. Perché l’effettiva realizzazione della sovranità popolare è sempre cosa molto difficile: la classe dirigente, in primo luogo, tende a ridurre i cittadini in soggetti meramente amministrati, a favore delle strutture burocratiche; ma anche le istituzioni rappresentative possono farsi autoreferenziali, prestandosi facilmente a servire gli interessi dei gruppi al potere. E così, prendendo prevalente ispirazione dalle esperienze statunitensi ed elvetiche, Rensi suggerisce l’introduzione di specifiche forme di referendum, dell’iniziativa legislativa popolare, di un “diritto di revisione” (come possibilità di condizionare il processo di modifica della costituzione), di un sistema elettorale proporzionale e della “nazione armata” (quale principale modo d’essere dell’esercito statale, svincolato dal controllo del solo ceto politico).
Per la preparazione di un convegno ho avuto modo di ripescare questa bellissima lettura, il cui titolo completo è Gli anciens régimes e la democrazia diretta, testo oggi disponibile anche on line con la premessa che fu di Arcangelo Ghisleri. Il volume adelphiano del 1995 riproduce l’ultima versione dell’opera e riporta in chiusura le due prefazioni che l’Autore – avvocato e filosofo socialista di natali svizzeri (1871-1941) – ha dedicato alle diverse e fortunate edizioni del libro (le due del 1902 e quella del 1926). La rilevanza del saggio va ben al di là di ciò che si può immaginare fermandosi alla copertina. La tesi del giovane Rensi è la seguente: tra gli assetti di potere dell’ancien régime e le forme di governo parlamentari può non esservi, di fatto, alcuna differenza se il popolo non ha la possibilità di intervenire direttamente per correggere le ricorrenti degenerazioni del governo rappresentativo. Perché l’effettiva realizzazione della sovranità popolare è sempre cosa molto difficile: la classe dirigente, in primo luogo, tende a ridurre i cittadini in soggetti meramente amministrati, a favore delle strutture burocratiche; ma anche le istituzioni rappresentative possono farsi autoreferenziali, prestandosi facilmente a servire gli interessi dei gruppi al potere. E così, prendendo prevalente ispirazione dalle esperienze statunitensi ed elvetiche, Rensi suggerisce l’introduzione di specifiche forme di referendum, dell’iniziativa legislativa popolare, di un “diritto di revisione” (come possibilità di condizionare il processo di modifica della costituzione), di un sistema elettorale proporzionale e della “nazione armata” (quale principale modo d’essere dell’esercito statale, svincolato dal controllo del solo ceto politico).
Le analisi di questo eccentrico interprete – che spesso è stato vicino a posizioni prettamente liberali, tanto più con l’affermarsi del fascismo, del quale per una prima parte del suo percorso fu strenuo oppositore – stupiscono per molte ragioni: l’acutezza delle considerazioni critiche dedicate all’ordinamento costituzionale della monarchia; la valorizzazione degli studi di Gaetano Mosca, con cui Rensi ebbe anche un interessante carteggio; le considerazioni illuminanti, oltre che attualissime, sul ruolo delle “seconde camere”, sulle propensioni pericolosamente “espansive” degli esecutivi e della loro funzione, sugli inganni e sulle tante trappole che si nascondono nella complessità redazionale dei testi legislativi; l’attenzione costante per l’argomentazione storica e per i raffronti comparativi. La modernità estrema dell’approccio di Rensi si può apprezzare del tutto leggendo anche l’articolo su Lo Stato di diritto (del 1900), che è quasi contemporaneo alla redazione di questo libro e che nel testo di Adelphi è opportunamente posto in Appendice. Basti, sul punto, menzionare che, tra le “riforme urgenti” che Rensi propone già sotto la vigenza dello Statuto albertino vi sono, oltre alla previsione del referendum, anche l’istituzione di una Corte Suprema (sul modello americano, come essenziale guarentigia giuridica della democrazia) e la riforma del Consiglio di Stato (per “garantire l’indipendenza dei suoi membri”) e della Corte dei conti (per eliminare la registrazione “con riserva”).
Sappiamo, certo, che la Costituzione repubblicana del 1948 ha parzialmente raccolto buona parte dei suggerimenti di Rensi. L’importanza di tornare nuovamente al suo messaggio, però, è ancora apprezzabile in un frammento tristemente presago, che è correttamente evidenziato (p. 233) nella Nota di Nicola Emery (curatore del volume e appassionato conoscitore del Nostro) e che risale ad un intervento giornalistico del 1925. È una sorta di monito estremo sul destino politico-giuridico cui rischia sempre di essere ricondotta l’Italia, a causa della reiterata incoscienza dei tanti problemi cui Rensi si è dedicato: “Troppo modesti erano stati quei fascisti che hanno limitato a sessant’anni la previsione della durata del loro governo. Questo sarà invece, probabilmente eterno, nel senso che la ‘fase fascista’ non cesserà più per l’Italia. Non si ripristinerà più per l’Italia il sistema di Governo normale, diciamo lo ‘Stato di Diritto’, l’ordine politico in cui v’è una legge o consuetudine forte come la legge che determina e regola le condizioni e il modo del pacifico succedersi dei partiti al potere. Un tale sistema di Governo fu forse per sempre infranto con l’ottobre 1922. E con quest’epoca l’Italia è entrata forse per sempre nel sistema di governo di quella che, in un certo senso, si potrebbe chiamare la periferia europea”.
Un’intervista al Curatore dell’opera
L’importanza di Rensi filosofo della vita (di Roberto Esposito)
Giuseppe Rensi e il problema della democrazia diretta (di Paola Lubelli)
Sorry, the comment form is closed at this time.