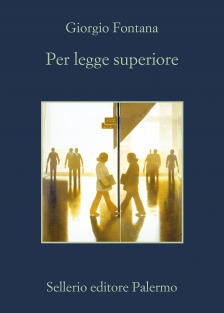Ennio Guarneri vive a Milano, ama il body building ed è un ex poliziotto. Era entrato nel corpo da giovanissimo e aveva anche avuto modo di diventare presto ispettore. Poi il suo personale senso di giustizia – l’idea, cioè, che la giustizia non segua necessariamente i percorsi della legge e che, quindi, debba essere veicolata per altre vie – lo ha indotto a cooperare con alcuni colleghi per praticare saltuari e sostanziali “tagliandi” a figure spregevoli, ma capaci di farla sempre franca. Un giorno è stato colto sul fatto e costretto alle dimissioni. Nel bel mezzo del limbo in cui la nuova vita di disoccupato sembra farlo galleggiare decide di prendere lezioni private dalla sua vecchia maestra, per ripetere le elementari. Una mattina, casualmente, mentre si trova in riva al Ticino, sventa un’esecuzione e uccide il killer, facendo fuggire la vittima. La storia comincia proprio da qui. Perché è da quel momento, in effetti, che Ennio finisce in una spirale pericolosissima, che decide di raccontare giorno per giorno in un diario privato. L’uomo che ha ucciso era il fratello del capo di una spietata organizzazione nigeriana, il cui scopo è di fare giustizia dei “mercanti di uomini” e di quanti si siano macchiati di gravi crimini nei confronti dei migranti. Uno strano personaggio, un investigatore privato – finito, forse, allo stesso modo nelle grinfie dell’organizzazione – fa sapere a Ennio che c’è una sola via per sperare di salvarsi dalla rappresaglia del capo: mettersi al suo servizio come sicario. Di fronte a questa sorta di inaccettabile e tragica “proposta contrattuale” Ennio entra in crisi, tanto più che, proprio in quel momento, si innamora perdutamente e la sua vita sembra riacquistare un senso. Che fare?
Gli sviluppi successivi non si possono rivelare, anche se occorre anticipare che la via d’uscita non sarà semplice e che, in ogni caso, il protagonista, se potrà salvarsi, lo farà grazie a un aiuto che aveva programmaticamente escluso. Guarneri, infatti, non ne uscirà da solo, e forse, alla fine, troverà un nuovo potenziale amico. Ma liberarsi dal vizio della solitudine non è così facile, specie per chi sembra esservi condannato da sempre. Del resto anche l’epilogo è tutt’altro che pienamente positivo, visto che Guarneri dovrà comunque affrontare due perdite molto importanti. In questo libro, che si potrebbe ascrivere al genere noir, Montanari riesce a intrecciare una trama quasi, e scopertamente, banale (che ben si addice allo stereotipo del tipico thriller metropolitano) con una traiettoria esistenziale particolarmente solida e paradigmatica (e che all’apparenza potrebbe dirsi del tutto sproporzionata rispetto alle esigenze di quella stessa trama). Non è dato sapere se questo genere di costruzione corrisponda a un espediente calcolato. Eppure il risultato convince: tanto distrae e annoia l’avventura per così dire principale, quanto attrae e fa riflettere l’evoluzione laterale della dimensione personale del protagonista, in un gioco incrociato di salite e discese narrative. Con l’effetto che, alla fine, è quella dimensione ad essere veramente al centro del romanzo. Come si finisce per intuire al termine della lettura, il cuore della storia e già del tutto riassunto nell’immagine panoramica di apertura, nello sguardo impaurito di un cormorano ferito, che dinanzi alle inspiegabili e temibili insidie del mondo, separato dai suoi compagni e rimasto fatalmente da solo, può soltanto soccombere.
Recensioni (di R. De Marco; di G.P. Serino)