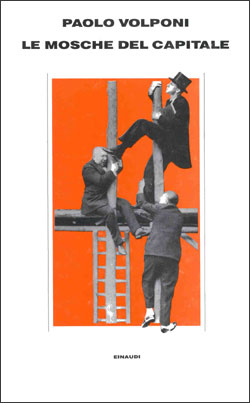Tutti conoscono Marcel Duchamp. Almeno per l’esposizione del famoso orinatoio del 1917, che viene sempre ricordato come qualcosa di assolutamente rivoluzionario. E lo è stato davvero. Ma siamo sicuri di averne compreso il senso fino in fondo? Il Duchamp politique di Pablo Echaurren – edito in versione bilingue, inglese e italiana, con un’originale postfazione di Marco Senaldi – offre una lettura incisiva e illuminante. Come può essere quella di un artista – pittore singolarissimo e maestro del graphic novel – che a Duchamp ha sempre guardato come a un punto di riferimento essenziale. Anzi, esistenziale, perché morale, oltre che politico. Un passaggio del libro riassume efficacemente questi caratteri: “In una società di finzione e rappresentazione, in cui le immagini si sono separate dalla vita e lo spettacolo domina ogni campo umano come ornamentazione, come produzione di oggetti-immagine, come insieme di merci che contemplano se stesse in un mondo da esse creato, in una simile società Duchamp adotta oggetti scarni, elementari, sfuggenti alle leggi dell’apparire, sottraendoli al mondo indistinto della merce. Oggetti che non si ergono sui loro produttori espropriati, che emergono in sordina dal paesaggio urbano, troppo urbano, che scoprono un inedito e imprevisto valore d’uso, che riacquistano dignità e si riqualificano nella scelta dell’artista” (p. 98). Questa, di per sé, non è una ricostruzione nuova. E se ne può comprendere bene anche l’attualità, se non la profezia su ciò che molta arte contemporanea sarebbe stata ed è. Basta leggere l’ultimo, aguzzo libro di Andrea Bellini. Tuttavia, a colpire nel segno è la maniera con cui la traiettoria duchampiana è presentata, perché ne evidenzia tutta la radicalità.

L’estrema ironia, la critica delle istituzioni museali, la pratica di uno stile di vita essenziale, il rigetto del denaro e delle sue infrastrutture sociali, la scelta della decostruzione apparentemente più casalinga e spiazzante, eppure ricercata, perché animata dalla volontà di restaurare la profondità intrinseca delle cose ben fatte: sono tutte coordinate di un manifesto umanista che da artistico si fa totalizzante, diremmo antropologico. L’avvio del ragionamento compiuto nel saggio – che induce a un parallelo ficcante tra l’universo duchampiano, l’arte medievale e una sorta di ascetismo filosofico – spiega i fondamenti teorici del ready-made e la sua valenza etica e metodologica. Che nulla ha a che fare con la distruzione dell’arte o dell’artista, bensì, all’opposto, si propone di rigenerarne le esperienze. Quasi in un percorso di liberazione da tutti i fattori che possono, viceversa, svolgere un ruolo condizionante o, addirittura, standardizzante. Si potrebbe scorgere, qui, un sorprendente punto di contatto con il pensiero heidegerriano, con le riflessioni ontologiche su che cosa sia “una cosa”. Chi l’avrebbe mai detto? Alla fine del saggio viene spontaneo tornare all’inizio, per constatare che Echaurren ha proprio ragione: Duchamp è “un palinsesto su cui scrivere e riscrivere all’infinito senza pregiudicarne la superficie, senza mai graffiarla, intaccarla, o anche solo scalfirla”. Perché “tutti giochiamo a scacchi con Marcel, ciascuno di noi portandosi appresso una propria scacchiera è un proprio schema variamente, diversamente, truccati”.
 Why Information Grows? È la domanda cui cerca di rispondere l’
Why Information Grows? È la domanda cui cerca di rispondere l’