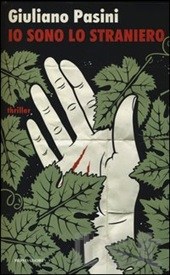C’era il mare… Ghe gera el mar… Mar-ghe-gera… Marghera! Neanche il narratore crede a questa pittoresca progressione etimologica. Però non c’è dubbio che, a darle credito, si comprende subito il nesso tra il romanzo e il suo titolo. Infatti, pur svolgendosi anche a Treviso, l’ennesima indagine dell’ispettore Stucky – per intendersi, quello del prosecco e di tante altre avventure – ruota soprattutto attorno a un certo luogo: ai noti cantieri navali della laguna veneta e ai resti di un Petrolchimico altrettanto, e tristemente, famoso. Ma in questo giallo il primo cadavere, quello di un noto giornalista locale, viene ritrovato nel capoluogo della Marca. È senz’altro un caso di avvelenamento, anche se per Stucky – che deve affrontare le temporanee mattane delle sue estroverse vicine di casa – ci sono tante cose che non quadrano. Nel frattempo, a Mestre, viene ucciso un ex sindacalista, pure questa volta una figura conosciuta. Se ne occupa Luana Bertelli, una collega che Stucky conosce bene, e che non crede alle apparenze: la morte dell’uomo non può essere stata l’accidente di un tentativo di furto, né è verosimile che il colpevole sia stato uno straniero. I due ispettori brancolano tra facili pregiudizi e piccole intuizioni, imbattendosi in personaggi di varia e ambigua estrazione, così diversi, e così insospettabili, da rendere improbabile qualsiasi collegamento. Poi sulla scena irrompe un terzo, strano, decesso, quello di un avvocato, che aveva rapporti con entrambe le vittime. Le indagini, dunque, finiscono per convergere e, grazie ad uno spunto della Bertelli, il baricentro della storia si sposta all’improvviso tra Marghera e Venezia, verso il magnetismo oscuro di uno spregiudicato e spietato animatore del rancore sociale.
In questo libro sembra un po’ affaticato, l’ispettore Stucky. Tant’è vero che, alla fine, il passo decisivo lo fa la Bertelli, vero fulcro del racconto. Non è che al nostro eroe manchino la consueta e scanzonata disinvoltura e lo sguardo un po’ obliquo, che gli consente sempre di intravedere la pista giusta. Anche i simpatici punti fermi del suo universo, poi, ci sono tutti: le sorelle di vicolo Dotti, lo zio Cyrus, il trio degli agenti Landrulli, Sperelli e Spreafico. Tuttavia l’iniziativa risolutiva sembra difettargli. C’è da chiedersi se questo sia un segno di stanca per il personaggio e il suo ciclo narrativo o se, invece, sia semplicemente la conseguenza, sul piano della trama, della scelta di un bersaglio sfuggente, fondamentalmente illogico, cresciuto come un virus incomprensibile sulle macerie materiali e morali della crisi. Che per Ervas – così, almeno, si può arguire – non è soltanto quella dell’ultimo decennio. Il campo di battaglia, infatti, è simbolicamente posizionato in un territorio martoriato da una storia, lunga e dannata, di cortocircuiti imprenditoriali e ambientali; un territorio che, ciononostante, continua deliberatamente a non fare memoria, abbandonandosi alla ricerca e alla caccia diffuse, e quasi disperate, del capro espiatorio più vicino. È comprensibile, dunque, che Stucky – il più riflessivo, meditabondo e bonario Stucky di oggi… – sia meno pronto del solito, perché il nemico non è uno, ed è perciò disorientante. Come è altrettanto comprensibile, viceversa, che sia la tenacia di una donna irrequieta, che potrebbe anche rischiare di lasciarsi andare di fronte all’avversario, a diventare l’esempio dell’energia necessaria: per sconfiggere il risentimento tiranno che inchioda i molti alle loro fragilità e a un inutile disegno di vendetta. Sembrerebbe stanco, Ervas. Piace constatare che è più consapevole e motivato che mai.