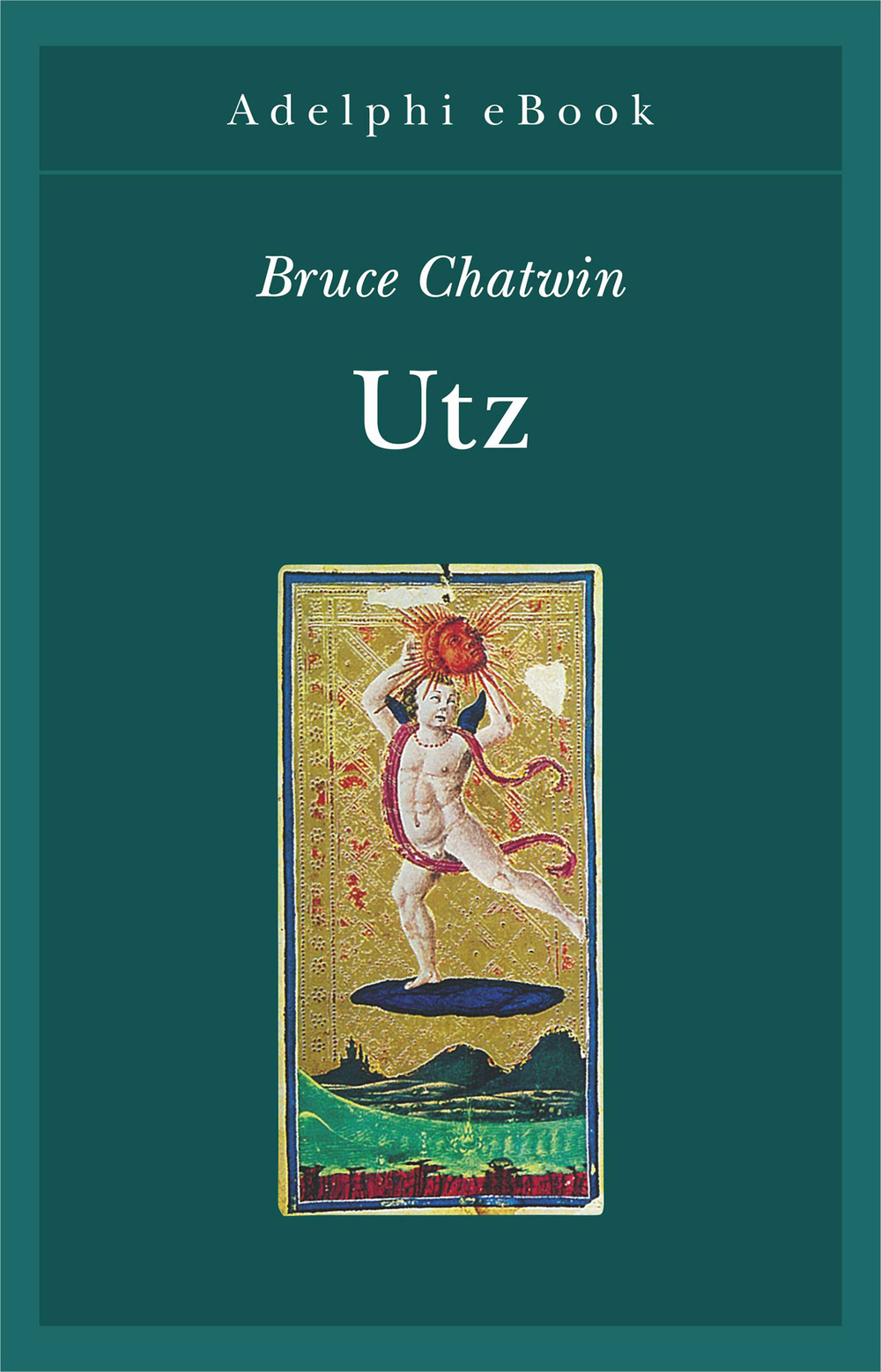
In questo piccolo romanzo del 1988 – l’ultimo scritto da Chatwin prima della morte – si racconta di un certo Utz, morto a Praga negli anni Settanta. La storia comincia con il mesto funerale del protagonista: scarno, malinconico e un po’ surreale. Ma, subito dopo, la trama riparte da un tempo anteriore: dall’anno che aveva preceduto l’occupazione della Cecoslovacchia da parte dei carri armati sovietici. Precisamente da quando l’io narrante entra in scena, nelle vesti di appassionato ed esperto d’arte, e di collezionismo, cui un amico consiglia di incontrare, per l’appunto, l’enigmatico Utz. Proveniente da una piccola e incerta nobiltà terriera dei Sudeti, Utz – che vive in un piccolissimo appartamento, assistito dalla sua governante – è stato in grado, sin da giovane, di raccogliere una formidabile raccolta di porcellane di Meissen; un patrimonio prezioso, che ha saputo difendere e incrementare a più riprese, anche durante l’occupazione nazista e poi, a guerria finita, di fronte alle mire del sopraggiunto regime socialista.
Al suo più giovane interlocutore Utz racconta moltissime cose: sui misteri del Golem, sulle passioni (e ossessioni) artistiche della casata di Sassonia, sui segreti alchemici della porcellana… E gli fa incontrare anche un pedante ed eccentrico amico, il paleontologo Orlik. Le strade si dividono, e tuttavia la storia continua, perché Utz cerca in ogni modo di conciliare la sua morbosa attrazione magnetica per la collezione e la volontà di liberarsi dal clima oppressivo del regime, immaginando anche di fuggire all’Ovest. Ciò che il narratore viene a scoprire, però, è che, alla scomparsa di Utz, anche le porcellane svaniscono. Dove saranno mai finite? Chi se ne sarà impossessato? Sono forse andate distrutte? Di più non è lecito dire, di questo libro. Non solo per non privare il lettore della sorpresa dell’epilogo, bensì perché sono le tante (studiatissime) divagazioni che lo preparano meticolosamente alla comprensione del giusto significato: evidenziando, cioè, quanta e quale cura di sé occorre per non scivolare – non importa se laici o religiosi – nella più esiziale delle idolatrie.
In questa direzione, Utz, apparentemente così diverso dall’altro Chatwin (quello dei viaggi), è l’opera forse più rappresentativa, perché fondamentalmente teorica, di un’etica di abbandono e nomadismo strutturali, concepiti ad antidoto per il male più grande delle cose; patologia che l’Autore conosceva assai da vicino, vista la vicinanza estrema tra il tema trattato in Utz e l’originaria militanza dello stesso Chatwin quale dipendente di una famosa casa d’aste. Un’ultima notazione: dal libro è stato tratto un film delizioso, che, diversamente da ciò che accade di solito, è molto fedele allo scritto. Vale quasi la pena (così è stato per me) partire da lì.
