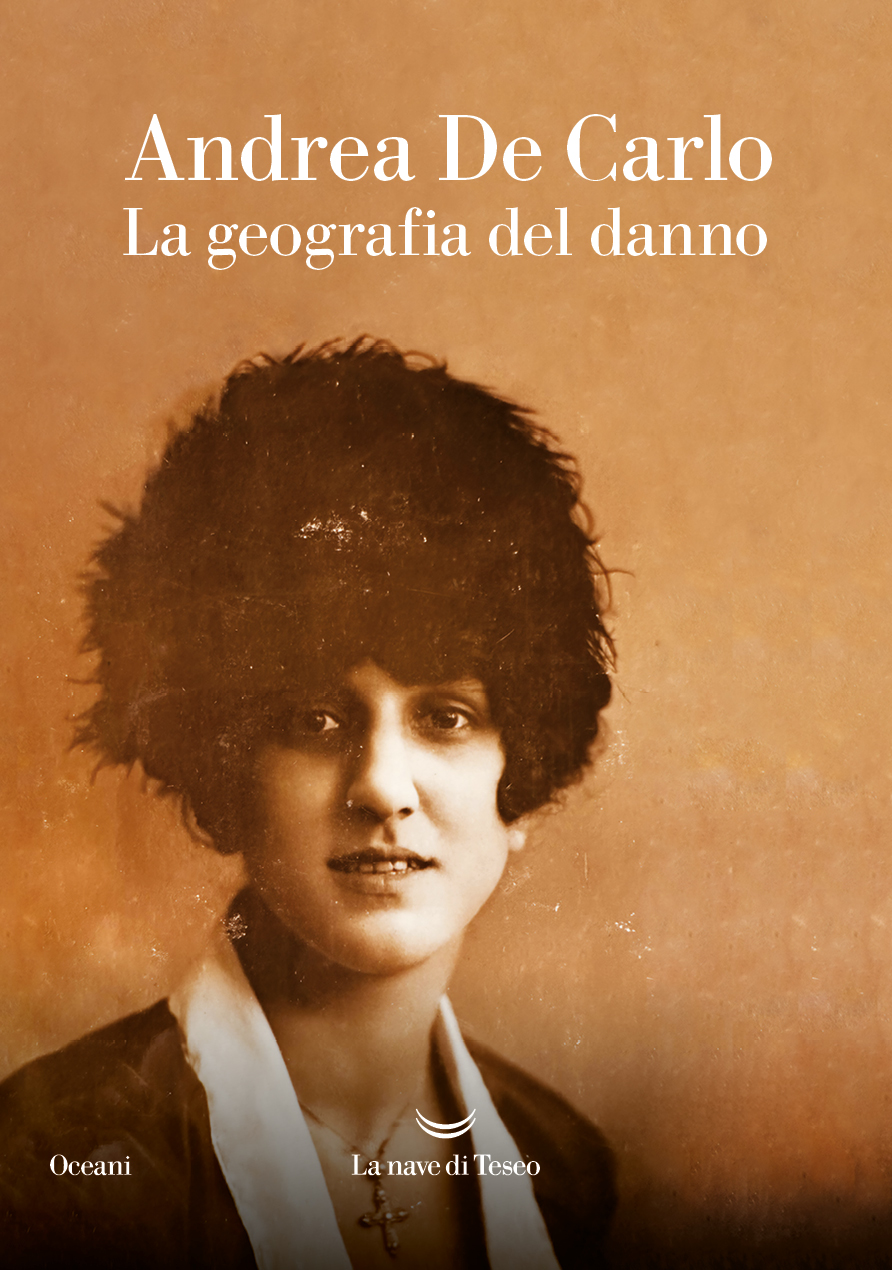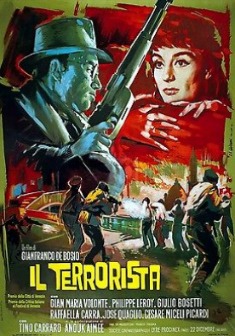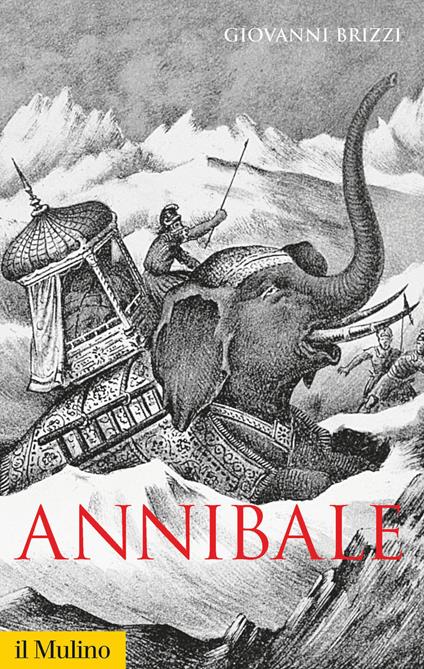Che cos’è la poesia? Domanda persa nella notte dei tempi e, già per ciò solo, risposta difficile. Che, tuttavia, Aldo Nove prova, di fatto, a formulare in questo singolarissimo libro, focalizzandosi sull’unica risorsa cui si possa accedere per riuscire nell’impresa, ossia sulla propria personale esperienza. Perché per Nove la poesia è una specie di pratica, una disciplina, un procedimento (inspirazione, respirazione…), per il cui tramite stupirsi e inabissarsi – come il palombaro di Govoni – alla ricerca di un tesoro nascosto, spingendosi al limite, mettendosi completamente in gioco. È anche un tirocinio, lento e complesso, che in parte richiede di essere scoperto e assecondato, da sé come da altri che lo possano intuire e accompagnare. Dunque quello dell’Autore diventa presto il diario di un’iniziazione lunga una vita intera. Dalla scoperta delle poesie di Guido Ballo, in una piccola mostra a Viggiù, ai rapporti, veicolati da un suo sensibile professore, con Franco Buffoni e Milo De Angelis; dalla conoscenza di Nanni Balestrini fino al lavoro nella redazione dell’editore Crocetti. Nel mezzo: il racconto di molte incomprensioni e di un’estraniazione progressiva da ciò che è comune e normale; l’ambizione di immergersi sempre di più nell’essenza del linguaggio poetico e nelle sue autonome virtù catartiche e filosofiche; due righe soltanto per la soddisfazione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e distanziarsi da proposte poetiche eccessivamente mainstream; e tante, tante (e talune formidabili) poesie: che non sono semplicemente raccolte, una dopo l’altra, ma punteggiano un itinerario di pensiero, quali pietre miliari o, meglio, exempla – nel senso medievale del termine – di ciò di cui Nove intende discutere, con galleria di altrettanti poeti e poetesse (Pascoli, Pagliarani, Hölderlin, Zanzotto, Giudici, Dickinson, Leopardi, Rimbaud, Bonnefoy, Thomas, Camon, D’Annunzio, Dante, Ritsos, Trakl, Celan, Neri, Caproni, Raffo, Palazzeschi, Penna, Poe, Sereni, Nemésio, Enzensberger, Brecht, Campo, Baudelaire, Pessoa, Shakespeare, Jarry, Campana, Sanguineti, Di Giacomo…).
Di questo volume – che in ogni caso può funzionare come ottima guida d’ingresso a importantissime voci della tradizione poetica – preme evidenziare soprattutto due aspetti. Il primo è quello che si può definire empatico, e che Nove coltiva nel richiamo costante tra arte e vita, tra verso e traiettoria esistenziale. Lo si comprende fino in fondo laddove si ricordano i casi di Lorenzo Calogero e Ivano Fermini, e quello sicuramente più conosciuto di Amelia Rosselli. E quindi quando – con quel sentimento di omaggio, gratitudine e riconoscenza che è proprio di chi sa alimentarsi dei messaggi che altri hanno lasciato, com’è tipico dei poeti – si evocano incontri e storie in cui la diversità o l’eccentricità o la solitudine altro non sono che chiavi privilegiate e condizioni per chi, pur marginalizzato, può accedere davvero al tesoro tanto cercato. È una prospettiva che consente a Nove di fare pure una scelta di campo; di esaltare, cioè, posture poetiche in cui il tesoro non passa per la trasmissione di un senso immediatamente afferrabile, ma per la riproduzione sapienziale di un effetto di fortunato stordimento. È un invito ad una sorta di sciamanesimo, che vale come luogo dell’agnizione, da un lato, ma anche come luogo della resistenza e della libertà a fronte di un regime ordinario e consumistico concepito sempre più come oppressivo (ai lettori di Inabissarsi non sfuggirà che il Nove di quest’opera è quello – arrabbiato – dei Sonetti del giorno di quarzo, scritti nel pieno della pandemia da Covid-19 e delle reazioni pubbliche e securitarie che essa ha generato). C’è un altro profilo che merita attenzione. Nella strada che Nove ha percorso la poesia si ritrova anche nella musica: di Lou Reed, ad esempio, ed è dato che non stupisce nessuno; di Umberto Tozzi ed Edoardo Bennato, che, invece, sono riferimenti meno scontati; e di Taylor Swift, con un interesse che recentemente è stato condiviso da acuti osservatori e che, tuttavia, qui, vale a rafforzare l’intuizione centrale, che “[i]l Regno della Poesia è mercuriale, salta altrove e sempre e chissà dove, ma sai che ti aspetta e ti si concede, se vuoi accoglierlo”.
Recensioni (di D. Brullo; di P. Vitagliano)
A chi esita (Bertolt Brecht, 1933)
Dici:
per noi va male. Il buio
cresce. Le forze scemano.
Dopo che si è lavorato tanti anni
noi siamo ora in una condizione piú difficile di quando si era appena cominciato.
E il nemico ci sta innanzi piú potente che mai.
Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso una apparenza invincibile.
E noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo.
Siamo sempre di meno. Le nostre
parole d’ordine sono confuse. Una parte delle nostre parole
le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili.
Che cosa è errato ora, falso, di quel che abbiamo detto?
Qualcosa o tutto? Su chi
contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti
via dalla viva corrente? Resteremo indietro, senza
comprendere piú nessuno e da nessuno compresi?
O dovremo contare sulla buona sorte?
Questo chiedi. Non aspettarti
nessuna risposta oltre la tua.