Il medesimo mondo di Sabrina Ragucci (da minimaetmoralia.it)

Il romanzo segue, a capitoli quasi alternati, le vicende di Giulio Drigo e Marco Sberga, due giovani artisti trevigiani dietro i quali si nascondono personaggi reali (da un lato, Comisso stesso, suo cugino Nino Springolo e lo scultore Arturo Martini, come fusi in un unico individuo; dall’altro, il pittore Gino Rossi). Prima dello scoppio della Grande Guerra, i due, pur essendo alfieri di approcci differenti, ambiscono ad essere protagonisti di un’arte completamente rinnovata, in polemica con le esposizioni biennali di Venezia. Entrambi si innamorano e si sposano con grande entusiasmo, ma il conflitto interrompe il loro confronto ideale, li separa dalle consorti e li porta al fronte: l’uno diventa ufficiale, viene ferito, ma si salva; l’altro combatte da semplice fante ed è fatto prigioniero. Drigo avvia apparentemente una nuova vita con la giovane moglie, con cui si trasferisce in campagna, speranzoso di tornare a dipingere, e di farlo con una piena e autentica adesione alla verità della traboccante natura che lo circonda. Presto, però, è costretto a tornare in città e ad adattarsi a conciliare la sua arte con le più semplici istanze della vita quotidiana. Viceversa, Sberga, già consumato dalle privazioni, apprende che la moglie lo ha abbandonato ed è costretto a vivere con la madre, in una condizione umiliante, nella quale, pur continuando a immaginare nuovi itinerari artistici, finisce per alienarsi del tutto. Verrà ricoverato in un locale manicomio, dove Drigo, sorpreso, lo incontrerà per l’ultima volta.
Concepito e scritto nel 1934, I due compagni non è stato incluso nel Meridiano che quasi vent’anni fa Mondadori ha confezionato con la curatela di Rolando Damiani e Nico Naldini. Si è trattato di una bocciatura? Quella, per espressa determinazione dei curatori, è stata una ponderata scelta programmatica: voleva offrire un itinerario che potesse dare l’idea del canone comissiano; e per rappresentare un canone (qualsiasi esso sia) occorre sempre selezionare, per definizione. È anche vero che I due compagni è sicuramente classificabile come un lavoro minore. Ma leggerlo, specie dopo le opere più note e acclamate, consente di valorizzarne una particolare caratteristica, a suo modo pre-canonica: rappresenta, infatti, l’anticamera del Comisso più maturo. Naturalmente ci sono molti altri motivi per evidenziare l’importanza del romanzo. Il primo: diversamente da Giorni di guerra, ed in modo pertanto inedito per Comisso, ne I due compagni il conflitto appare nel suo lato più drammatico, spaesante e doloroso; ragione che spiega i tagli, selettivi, ma significativi, voluti dalla censura fascista, dei quali Isabella Panfido dà puntuale testimonianza nella preziosa postfazione. Poi c’è un altro fattore di interesse: la rievocazione di due figure rilevanti (Gino Rossi e Arturo Martini) e la messa in scena di un confronto tra due opposte concezioni dell’arte e del rapporto tra arte e realtà. Tuttavia un’impressione si fa irresistibile: che ne I due compagni Comisso – che istintivamente parteggia per Sberga, ma teme di abbandonarsi alla necessità di essere anche Drigo – sceglie di descrivere un conflitto tutto interno alla sua formazione, e di affrontare il disincanto e la solitudine immergendosi nell’unica empatia che non lo ha mai tradito, quella dell’esplosivo e vibrante paesaggio pedemontano, il vero e onnipresente protagonista del libro. È in questa prospettiva che I due compagni costituisce il piccolo abbozzo, quasi in forma di sceneggiatura, di un percorso estetico che ne La mia casa di campagna sarà destinato a farsi anche scelta di vita.
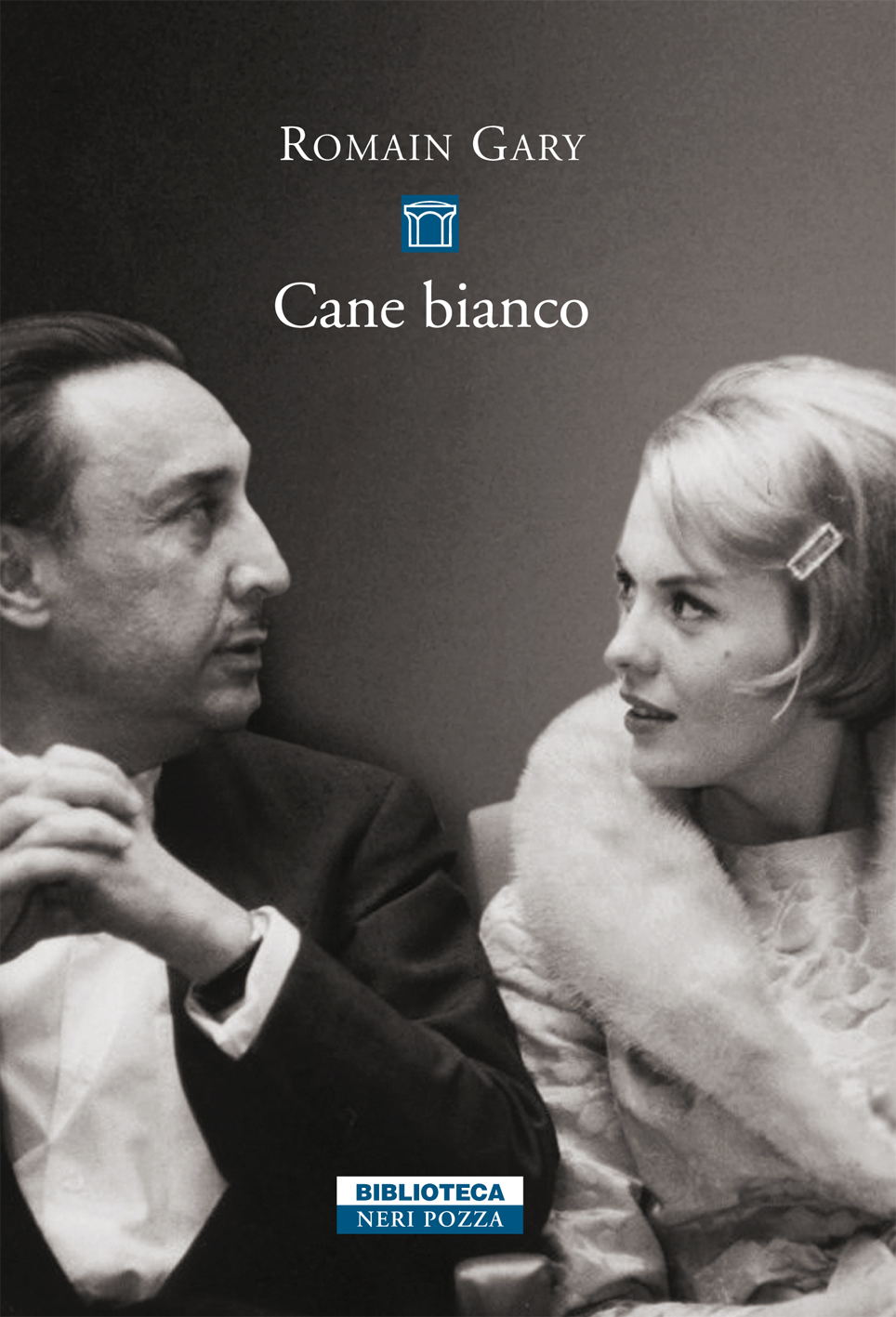
Tra i libri letti negli ultimi tempi, questo è il migliore. Ed è la conferma che su Gary si può sempre puntare. Diplomatico, militare ed eroe, scrittore, sceneggiatore e regista: è una figura poliedrica e inclassificabile, sempre ostinatamente protesa verso esperienze larger than life. Eppure, anche nelle sue opinioni più abrasive e anticonformiste (o forse proprio per questo), Gary – il figlio di immigrati lituani, il poliglotta, il prodotto dell’intreccio di una serie di etnie e tradizioni – è un mirabile prototipo dell’uomo del Novecento. Come in altre sue opere, anche in Cane bianco autobiografia, saggio e fiction si intrecciano. La storia, che è ambientata nel 1968 (il romanzo è stato scritto nel 1969 e pubblicato l’anno successivo), comincia a Hollywood, sullo sfondo dei moti e dei vasti disordini metropolitani che attraversano gli Stati Uniti dopo la morte di Martin Luther King. Gary si trova nella casa in cui abita assieme alla moglie, l’attrice Jean Seberg, che tanto si prodiga per la causa antirazzista e per il sostegno all’azione di molte e diverse fazioni del movimento black. Caso vuole che un giorno il cane di Gary si presenti davanti alla porta di ingresso seguito da un altro cane, un pastore tedesco tutto bianco. È un cane particolare, che si affeziona subito alla sua nuova dimora e a chi ci vive. Ma ha un problema. Quando si avvicina una persona di colore, sembra perdere la testa, ringhia furiosamente e diventa molto aggressivo. Lo shock di Gary è grande, tanto che decide di rivolgersi a un amico, titolare di un rinomato zoo californiano. Lì apprende che Batka – questo il nome russo che ha dato alla bestia: “piccolo padre” – è un white dog, un cane addestrato a cacciare uomini di colore, come accadeva un tempo negli Stati del Sud: un cane che tutti danno per irrecuperabile. Ma un certo Keys, che lavora allo zoo ed è nero, si offre sorprendentemente di rieducarlo. Nel frattempo Gary, turbato dalla situazione surreale di essersi imbattuto in un cane razzista, osserva critico e disincantato tutto ciò che accade attorno a lui e stigmatizza il perbenismo e l’attivismo antirazzista del bel mondo dello spettacolo. Soprattutto, abbatte uno per uno gli stereotipi e i pregiudizi che si nascondono nelle vene dell’America bianca, ed anche le proiezioni illusorie che animano i progetti degli attivisti di colore. La sua è un’intelligenza corrosiva, volutamente provocatoria, che non si allinea a ciò che oggi chiameremmo politicamente corretto e che, tuttavia, non scade neanche in ciò che si potrebbe considerare semplicemente scorretto (il libro è disseminato di intuizioni folgoranti e giudizi illuminanti, oltre che adeguati alla più scottante attualità). È un patriota gollista, reduce della guerra contro il nazismo e il fascismo, ed è convinto che la democrazia debba dischiudere un orizzonte in cui tutti possano diventare più nobili: non sopporta che un paese – gli Stati Uniti, ma anche la Francia, che in quel momento ribolle per le rivolte studentesche – si arrenda al dominio della retorica e alla paradossale ripetizione delle dinamiche ricorsive della diseguaglianza. Per questa ragione, attacca i meccanismi imitativi e intrinsecamente conflittuali della società americana, raffigurata come modello di una perfetta e inguaribile “società della provocazione”, in cui l’esaltazione delle differenze, specie da parte di chi ha successo, pone costanti presupposti per la diffusione di sentimenti rivali. Ma in questo romanzo c’è anche dell’altro: la crisi di una relazione sentimentale; la storia di due fratelli tanto diversi e al contempo tanto vicini; la lite (con tanto di calci bene assestati) con un divo del cinema; un incontro con Bob Kennedy… Ovviamente c’è anche l’epilogo della storia del cane. Che l’odio possa rivelarsi un male davvero inguaribile, è un insegnamento che anche Gary è costretto a verificare proprio nel terribile e scioccante nuovo corso – tutto da scoprire… – cui il white dog è stato ammaestrato.
Una recensione (di G. Alù)
White dog, il film del 1982
Gary “padre di tutte le Ferrante”
I suoi due libri più belli: Educazione europea e La promessa dell’alba

Il dott. Norton Perina è un medico famoso in tutto il mondo: ha vinto il Nobel per aver scoperto in una remota popolazione primitiva una strana patologia, che allunga la vita. Viene condannato a due anni di prigione per aver abusato di molti dei suoi tanti figli adottivi, di volta in volta prelevati dalle isole in cui aveva fatto le sue fortunate ricerche. Un collega e amico, il dott. Kubodera, ne pubblica il memoriale, in cui lo studioso racconta le sue origini, il rapporto complesso con il fratello, le prime e frustranti esperienze di lavoro in un grande laboratorio universitario. Rievoca soprattutto la scelta, quasi fortunosa, di avventurarsi nel ruolo di assistente di un brillante antropologo di Stanford, Paul Tallent, e di andare con lui a Ivu’ivu, un’isola del Pacifico in cui dovrebbe vivere una tribù isolatissima e misteriosa. Arrivati a destinazione – e scortati da alcune guide della vicina U’ivu – Norton, Paul ed Esme, la petulante collaboratrice di Paul, trovano nella giungla un gruppo quasi disperso di alcuni “sognatori”: è così che battezzano questi indigeni, che sono molto anziani e un po’ rimbambiti. Poco dopo scoprono un villaggio vero e proprio, ai cui margini si accampano. Comincia un periodo di meticolosa e straniante osservazione: comprendono che i sognatori hanno più di cent’anni e che sono stati banditi dalla comunità; assistono a rituali molto forti, e in uno di questi gli uomini più vecchi del villaggio sembrano abusare dei ragazzi che diventano adolescenti; capiscono che per quella comunità un ruolo misterioso e fondamentale è svolto da una peculiare specie di tartaruga. È a proposito di questa tartaruga che Norton ha l’intuizione che in pochi anni lo porterà a pubblicare studi rivoluzionari e ad attirare su di sé l’attenzione degli scienziati. Il resto del racconto riferisce della nuova vita di Norton, della fama improvvisa, delle numerose adozioni, della strana scomparsa di Tallent, della distruzione dell’arcipelago di U’ivu per opera delle missioni delle grandi cause farmaceutiche. Poi si narra dell’origine dell’adozione di un figlio particolare, Victor, e del conflitto familiare che porta il protagonista alle accuse per le quali viene arrestato, processato e giudicato colpevole. Fino alla dura e diretta confessione conclusiva, che il dott. Kubodera dapprima espunge dal memoriale e poi rivela dal luogo segreto in cui si è rifugiato con Perina.
Questo libro appartiene al genere di quelli che si leggono perché tutti ne parlano. Ci si arriva con un misto di grande aspettativa e non minore scetticismo, il tipico stato d’animo che ormai è proprio anche del forte lettore. E da cui bisogna guardarsi. Perché anche il forte lettore si nasconde tra i compratori medi, e in quanto forte rischia di esserlo pure nella mediocrità del giudizio. Occorre abbandonarsi alla storia, alla sua articolazione e alla scrittura. Occorre, in poche parole, non fermarsi alla superficie, non cadere nella trappola che la reale vicenda di cronaca – la parabola del dott. Daniel Carleton Gajdusek, nascosto dietro le fattezze di Norton Perina – pare preparare tanto bene. Se si prende quella via, infatti, ci si trova subito incagliati nelle sabbie di interrogativi molto scontati: si può essere geni e mostri al contempo? A quali inquietanti deformazioni può condurre l’omosessualità repressa? Quali sono i costi dell’esplorazione occidentale delle società cosiddette meno evolute? E quanto sono comparabili i modelli sociali? Il rischio è di terminare la rassegna delle domande con quella ancor più banale: anche il dott. Kubodera era omosessuale? Insomma, questo è un caso in cui, prima che il contenuto, sono la forma e la struttura del romanzo ad essere tanto sintomatici. C’è un’evidente sproporzione, infatti, nelle dimensioni come nell’insistenza e nell’accuratezza della descrizione, tra il racconto della scoperta (dell’isola, della giungla, dei riti della tribù, del segreto della tartaruga, della propria consapevolezza, anche sessuale) e il racconto della crisi (che si focalizza sull’ultimo atto, sul crollo di una specie di ecosistema individuale). È nel primo che si trova il centro di gravità dell’intera storia, e ciò, semplicemente, perché è lì che si nasconde l’iniziazione di Norton e la sua vocazione totalizzante, il principio e l’epilogo di tutta la vicenda. In fondo, Norton crolla di fronte alla vendetta, implacabile, della società e della cultura che egli stesso ha tradito, e che non è quella di Ivu’ivu, ma quella occidentale. Solo così si spiega la volatilizzazione di Tallent, che rimane cosciente e distante fino alla fine. Ma c’è di più. Perché questa distanza è quasi metafora di un approccio scientifico alternativo, quello che Perina ha colpevolmente misconosciuto, rompendo il meccanismo dell’obiettività e, cosa ancor più grave, importando la dimensione rituale dentro di sé e dentro la propria esperienza di ricercatore. Se da un lato, dunque, si può leggere Il popolo degli alberi ponendosi questioni fin troppo facili, dall’altro lo si può considerare come la cronistoria perfetta di una tragedia umana e scientifica davvero senza precedenti. Ed è specialmente da questa visuale che l’Autrice e il suo lavoro si lasciano apprezzare.
Recensioni (di M. Crawford; di B. Kimzey; di K. Kitamura; di C. Mazzoleni)