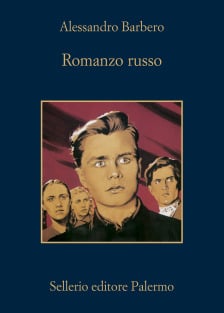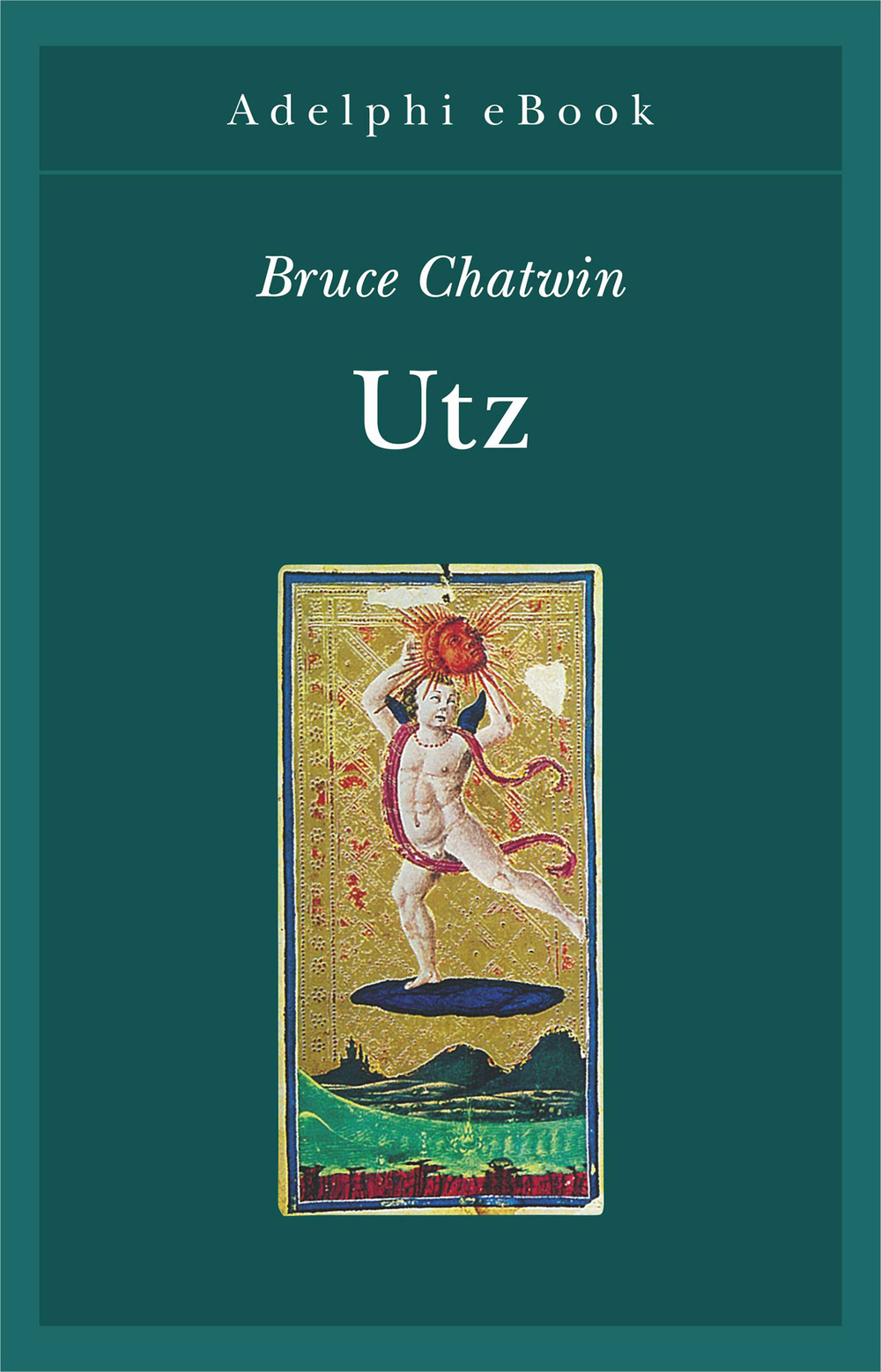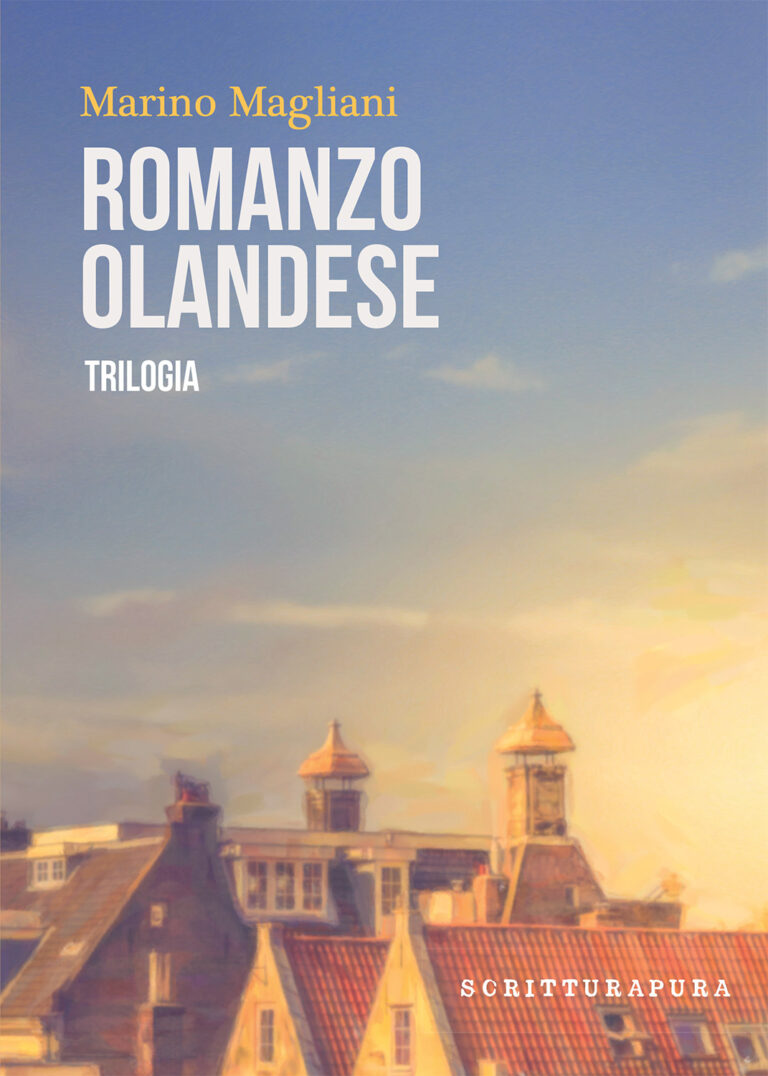
Il libro raccoglie in successione tre diversi testi: La talpa, Le vetrate di Rembrandt e Biografia di un paesaggio anfibio. Sono piccoli romanzi, sospesi tra la forma del diario e quella della fiction. E hanno alcune cose in comune. La prima è che le storie cominciano tutte dal pretesto di dover offrire al proprio editore un pezzo sull’Olanda; proposito che sembra fallire, per trasformarsi volta per volta in personali, sentimentali, ma minuziosi, carotaggi nelle fondamenta e nella cultura della società neerlandese. Come anche in proficue occasioni di auto-osservazione. Altro aspetto condiviso è che quelle di questi romanzi sono trame tra loro collegate, quanto meno nel senso di un ordine cronologico: Le vetrate e Biografia, infatti, sono ambientate in un momento – di insperato e anonimo ritorno – che segue la rocambolesca avventura de La talpa – che termina con una fuga, nientemeno che dai servizi segreti. La terza caratteristica – si discuta delle misteriose viscere di Amsterdam, delle geometriche costellazioni del quartiere di Zeewijk o del mondo variamente mutante che si scopre attorno alle rive del Noordzeekanaal – è che Magliani si esercita in un costante gioco di rimandi e raffronti con le luci e i colori della sua terra d’origine: le ombrose valli liguri, il borgo natio, i campi, i torrenti e i carruggi. Non manca, infine, in ogni testo, qualche allusione erotica, destinata, tuttavia, a spegnersi sottilmente e invariabilmente.
Ci si può indispettire durante la lettura. Da un lato, per un’impaginazione un po’ troppo piena e per una serie di fastidiosi refusi. Dall’altro, per l’andamento complessivamente rapsodico, che non consente di traguardare un qualche orizzonte. In verità Magliani è un Autore tutto da leggere. Perché il suo girovagare, alla fine, produce un piccolo effetto ipnotico, che ha la forza di riportarci, ciascuno, al proprio personalissimo centro di gravità. Ed anche perché – al di là dei numerosi passaggi curiosi o ironici – ci sono figure (il traduttore Roland Fagel e l’amico Piet van Bert) e singole pagine (come quella in cui si riprende la lezione di Sebald sulla famosa Lezione di anatomia di Rembrandt) realmente degne di nota. Occorre anche dire che il Romanzo olandese si può leggere con profitto ancor maggiore alternandolo con Natura morta con briglia di Zbigniew Herbert, il quale, con i suoi saggi (molto narrativi) sulla pittura e sulla cultura del Seicento olandese, ci catapulta nello stato d’animo più adatto ad affrontare le esplorazioni di Magliani. Le ricostruzioni del grande poeta polacco permettono di accedere a un ritratto molto efficace del carattere assai originale di un’intera società: libera e imprenditiva, talvolta anche all’eccesso, ma pacifica e ordinata; borghesissima e ripetitiva, ma popolare; semplice e tranquilla, ma in costante tensione col suo fluidissimo paesaggio. Niente di meglio, dunque, per acclimatarsi, sentirsi accolto e lasciarsi, poi, portare via, alla volta di se stessi, dagli smarrimenti di Magliani.
Recensioni (di C. Grande; G. Festinese; P. Vitagliano)