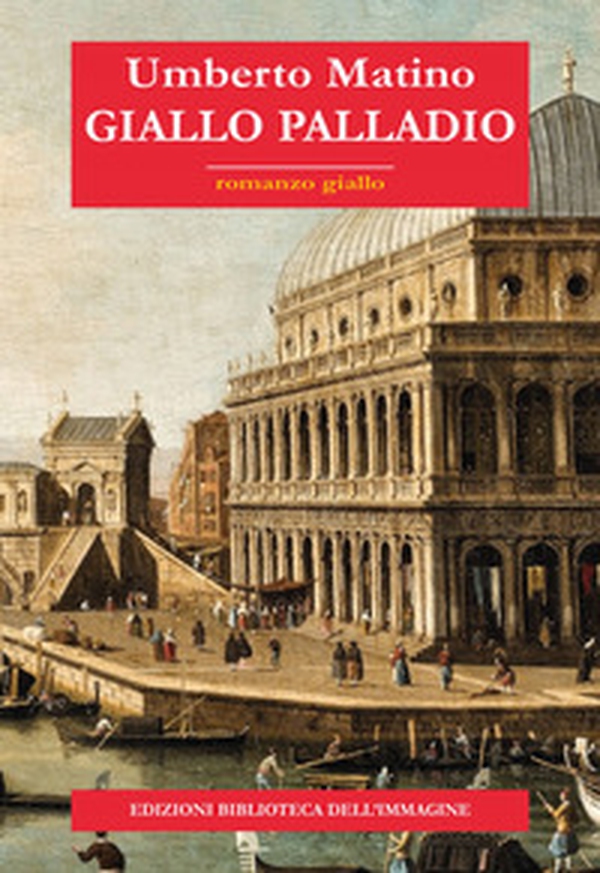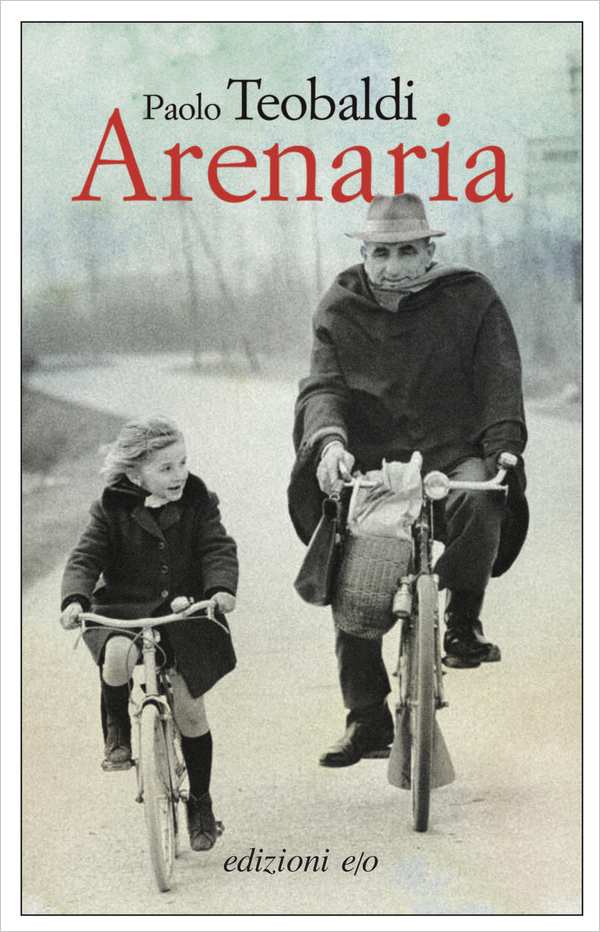Ogni viaggio ha il suo proprio viatico. E per una breve trasferta a Udine ho afferrato questo libro, provvidenziale. Di Giacomini avevo già letto – e apprezzato – l’inclassificabile “trattatello” L’arte di andar per uccelli col vischio, pubblicato All’insegna del pesce d’oro nel 1969, e il romanzo Manovre, edito da Rizzoli l’anno precedente. Il primo, oggi, si trova felicemente riproposto per Quodlibet, assieme ad un corpus di poesie. Il secondo è stato oggetto di riscoperta – come tanti altri titoli di Giacomini, nel corso degli anni – da parte di Santi Quaranta, raffinata casa editrice di origine trevigiana.
Il giardiniere di Villa Manin è una raccolta di pezzi in prosa risalente a un periodo di molto successivo, visto che è stata pubblicata nel 2002. Riunisce, nell’ordine, il testo che dà il titolo al volume – una sorta di estratto di un immaginario diario del giardiniere della bellissima villa di Passariano, scritto a pochi giorni dal pensionamento – e altre tre brevi composizioni, i cui motivi (un po’ storici, un po’ popolari e di costume, un po’ paesaggistici) si collocano a Udine, a Lignano e a Cividale. Il risultato complessivo lo si potrebbe definire come una graziosa e delicata Wunderkammer sentimentale della friulanità. Più di tutto, però, è la voce del giardiniere a meritare un appunto. Non tanto per ciò che rievoca (l’inizio del suo lavoro alla villa, il rapporto con l’enigmatico ed eccentrico conte che ne era proprietario, le ristrutturazioni e manutenzioni dell’immenso parco, l’allontanamento dovuto allo scoppio del conflitto mondiale, le distruzioni dovute all’occupazione delle forze alleate durante la guerra, le visite guidate per le scuole, la consuetudine con gli animali del luogo…), quanto per il sincero, partecipato e tenace affetto che la anima. Il frasario di Giacomini, infatti, tradisce una profonda immedesimazione con il modesto e diligente giardiniere e, per il suo tramite, con il mondo che incarna; un transfert che ce lo rende credibile e che, più di tutto, spiega in modo efficace il segreto e la piccola e concentrata energia malinconica di cui l’Autore si fa sempre portavoce.
È specialmente nel momento dell’abbandono, lungo il viale della villa, nelle ultime pagine del diario e negli ultimi sguardi e sensazioni del giardiniere, che giunge l’immagine risolutiva, quella che getta luce su buona parte della poetica intera di Giacomini: è la comparsa di un certo fringuello, solitario, il cui canto risuona quasi come un pianto. Eppure – si legge nel diario – “avvertivo anche una nota di forza in quei trilli, che lassù egli viveva il gelo della propria solitudine come un dono ricco del più arduo amore, che si sentiva in esso rinato come nel seno di un privilegio, in uno scrigno capace di difenderlo da ogni dolore”. Si fa sera, è ora di andare. Anche la vita lavorativa sta per finire, e non solo quella. C’è un intero cosmo in via di sparizione, aggredito da un tempo inesorabilmente diverso. Ma vicini, inattesi e insospettabili, ci sono gli alfieri di un equilibrio senza tempo, cui occorre guardare: per capire e per trarre ispirazione e forza. Qui è un fringuello, nella sua apparente e fragile resistenza. In Manovre era il piviere, l’ultimo e prezioso ospite dell’ecosistema della grava del Tagliamento, scacciato dalle aggressioni delle esercitazioni militari e di una modernizzazione che non sa farsi ospite rispettoso e si presenta, piuttosto, nelle forme temibili di quel progresso scorsoio di cui dirà Andrea Zanzotto.
Amedeo Giacomini lo è stato, veramente, il più autentico giardiniere di Villa Manin. Che dunque non è un luogo, una splendida dimora storica, una cosa, ma una sineddoche, la parte di un tutto più grande e nobile. Perché, per mezzo della voce del suo indimenticabile personaggio e degli spazi in cui esso si muove, questo scrittore si è fatto custode e aedo di uno scenario intero, di un grumo compiuto di bellezza, semplicità, memoria e cultura. Nonostante le intense e barbariche, e tuttora mai dome, trasformazioni che il Nordest ha subito in più di cinquant’anni, basta frequentare il periodare dolce e pacato dell’Autore friulano per riuscire ad accorgersi dei richiami degli uccelli, a coglierne fuggevolmente l’occhio concentrato e attento, e grattare, così, sotto la superficie di un territorio tuttora ricchissimo e capace di commuovere.