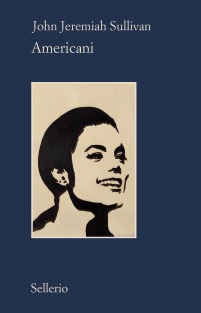Tra il ‘68 e il ‘69, l’Autore de Il male oscuro pubblica sulle pagine di un noto quotidiano (Il Resto del Carlino) alcuni brevi interventi, che lo vedono dialogare con il suo cocker spaniel Cocai (dal Merlin Cocai pseudonimo di Teofilo Folengo, famoso artefice maccheronico del Baldus e del Caos del Triperuno). L’ambientazione dei colloqui – pubblicati in autonomo volume solo negli anni Ottanta, all’interno una ricca e intelligente collana di Marsilio – ha come baricentro topografico la casa d’elezione dello scrittore, da lui stesso edificata sul suggestivo promontorio calabrese di Capo Vaticano. Gli argomenti trattati, innanzitutto, sono quelli caldi di quegli anni: la guerra in Vietnam, le grandi agitazioni studentesche e il conflitto generazionale, i posizionamenti geopolitici di Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina, lo spettro della conflagrazione nucleare, le missioni spaziali. Naturalmente lo scrittore trevigiano trapiantato al Sud non poteva non affrontare anche la questione meridionale, l’industrializzazione del Mezzogiorno e la nascita della nuova Università della Calabria. Nel merito dei discorsi svolti, come nella sostanziale ironia dell’approccio, il Berto di tutti questi testi non è così distante da quello conservatore della Modesta proposta, che verrà pubblicata nel ‘71. E la sua penna si conferma sempre chiara, asciutta ed essenziale, segnata dalla ricerca stilistica che meglio possa esprimere un comune e convincente buon senso. Nessun cedimento a quelle che egli stesso concepisce solo come vane emozioni, ingenuità o strumentalizzazioni.
Ciò che, tuttavia, si nota immediatamente è il carattere quasi dubbioso delle meditazioni, che sono esposte alla conversazione critica e provocatoria di Cocai, in qualità di curioso deuteragonista. Ma anche di compagno, amico e confidente, e di tramite diretto con gli affetti e con l’amore per la figlia (la “diletta” di cui aspetta il ritorno per le vacanze estive). Escluso il cane / tutti gli altri son cattivi, verrebbe da dire, riprendendo una canzone di Rino Gaetano, che uscirà qualche anno dopo, nel ‘75. È un Berto smarrito, che prova, e comunica, solitudine. Non solo quella ideale e, per così dire, storica ed epocale (di fronte a una civiltà i cui sviluppi non riesce a decifrare); ma anche quella letteraria (difesa con ostinazione, come dimostra il pezzo polemico con Moravia) e quella personale (si avverte distintamente che il pensiero ricorrente per la figlia non è solo un escamotage per riproporre l’invariante padri e figli o per esprimersi sulle retoriche della contestazione e del movimentismo). Più che mai, l’abitazione appoggiata sulla cima di un promontorio mozzafiato, lungi dal rivelarsi foriera di illuminanti vaticini (l’etimologia della località va in questo senso, tenta di crederci anche l’Autore), sembra il romitaggio di un intellettuale che non vede né immagina più il suo posto nel mondo e si limita a osservare le cose con franchezza estrema. Questo è, tuttora, il valore aggiunto di una voce pienamente libera.