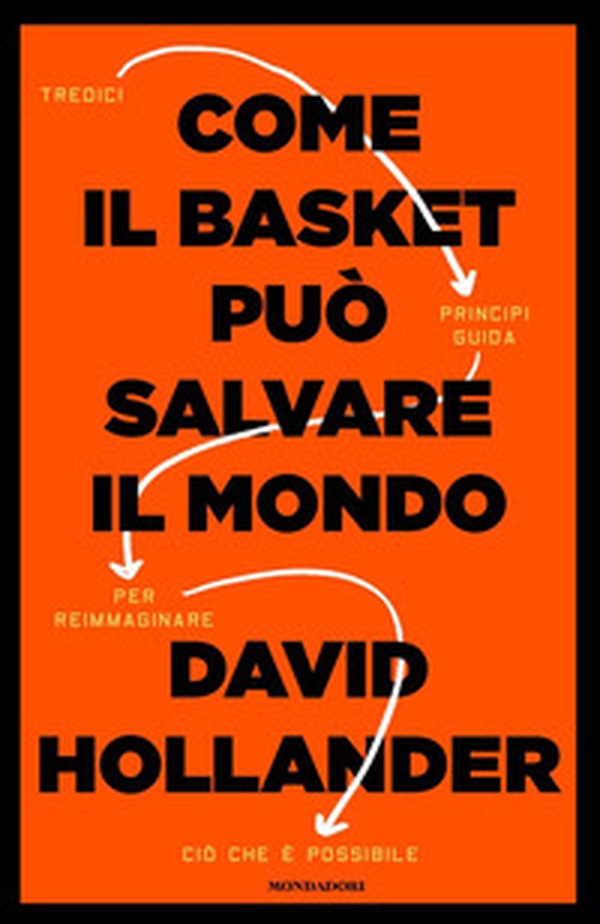
Nel quadro delle letture dell’anno, per quanto compiute finora, questa è stata la migliore. Una scoperta, si potrebbe dire, fatta sulla scorta dell’entusiasmo (ritrovato) per uno sport che sa dare grandissime soddisfazioni. Anche in quest’ultimo senso l’annata è stata più che mai proficua. E promette di continuare ad esserlo. Le NBA Finals hanno consacrato l’inarrestabile forza dei Denver Nuggets, vincitori dell’anello per la prima volta, e il ruolo di assoluto protagonista che da qualche tempo si è ritagliato Nikola Jokić (guardare per credere). I mondiali – che sono in corso tra Indonesia, Filippine e Giappone – forse non fanno presagire cose eccelse per la Nazionale italiana: ma il podcast allestito durante il ritiro da Gigi Datome e Niccolò Melli è assai divertente, ed è sempre bello soffrire partecipando agli alti e bassi del quintetto azzurro. Che per ora, comunque, ha saputo trasmettere emozioni inattese. Il fatto è – tornando al punto – che il libro di David Hollander non è necessariamente un testo per amanti della pallacanestro. È il laboratorio di una scuola di pensiero: un itinerario, scandito in 13 lezioni / principi, per sperimentare quanto la logica del playground possa fungere da stimolo per intuizioni e soluzioni utili ai fini del miglioramento della società. A suo modo, infatti, Come il basket può salvare il mondo è una proposta politica, ovvero, usando le parole assai esplicite dell’Introduzione, “una storia nuova, una nuova cornice in cui inquadrare il senso di quello che facciamo, un nuovo ismo”.
L’Autore gioca con alcune parole-chiave (collaborazione, equilibrio individuale e collettivo, equilibrio di forza e tecnica, non posizionalità, alchimia, inclusività, etc.) per scandire e illustrare una serie di insegnamenti. È il frutto che le origini, le evoluzioni, lo spirito, i protagonisti e alcune grandi culture del basket possono consegnare a chi volesse costruire, oggi, una leadership consapevole ed efficace. C’è un po’ di retorica, naturalmente, come è tipico di chi sia fortemente appassionato; e ci sono anche tutte le radicalità e ingenuità prospettiche – delle vere esagerazioni, talvolta – di una visione americana fino al midollo. Di un approccio che si esalta solo nell’essere larger than life. Ma non si può non restare catturati dal modo con cui Hollander dà corpo ai propri ragionamenti ricorrendo a episodi o vicende da assumere come metafore incisive ed ispiranti. In tanti casi chiama in causa le gesta, le qualità, il carattere e le imprese di eroi, vecchi o nuovi, della NBA (Wilt Chamberlain, Steve Nash, Larry Bird e Magic Johnson, Draymond Green…) o di alcune squadre (i Boston Celtics, i Philadelphia 76ers, I Golden State Warriors, gli Oklahoma City Thunder, i Toronto Raptors…). In altri casi, invece, trasla il succo, o il valore, che si può trarre da ogni singolo exemplum per provare l’universalità del linguaggio che va elaborando. Ad esempio, la parte dedicata all’alchimia umana (che si può riassumere con questa citazione: “Ogni persona e ogni istituzione deve impegnarsi a viso aperto con il mondo che cambia e mescolarsi coraggiosamente con esso, non per diventare migliori ma per diventare diversi”) funziona benissimo come una delle migliori introduzioni all’importanza dell’interdisciplinarità nella ricerca.
C’è un aspetto, però, più di tutti, che lega l’intero discorso di Hollander e che quasi al principio, in un paragrafo, è apertamente esplicitato. È il parallelo tra il passaggio critico dal XIX al XX Secolo e le lunghe e reiterate transizioni di cui è innervata la nostra epoca; tra una fase di intense trasformazioni economiche e di correlati conflitti sociali, con forte divaricazione di classe e di “ruoli”, e una fase in cui la combinazione di crisi ecologica e incombenti orizzonti di ulteriore rivoluzione tecnologica stanno generando dinamiche analoghe. In questo raffronto il basket, per Hollander, non può che rilanciarsi spontaneamente, perché inventato in un momento in cui vi era bisogno proprio di ciò che serve tuttora: un’occasione facilmente approcciabile per rieducarsi e avvicinarsi reciprocamente, e per scoprire uno scopo capace di stimolare empatia, idee nuove ed emancipazione. Non a caso, l’ultimo capitolo è intitolato alla trascendenza: perché “la fatica deve andare di pari passo con l’aspirazione”; e del resto “per segnare devi scendere lungo il campo ma poi devi anche salire!”. Ecco, Hollander, riannodandosi all’esperienza di James Naismith, il geniale creatore di questo sport, ci fa capire non tanto che alla base della rifondazione politica di cui il mondo ha bisogno ci dev’essere una radicale istanza etica, quanto che quest’ultima non può esistere se non per mezzo di infrastrutture concrete in cui metterla alla prova e assimilarla ex novo.
Recensioni (di M. Pettene; di U. Zapelloni)



 Originale e accattivante: sono questi i due pregi del romanzo di Ballestracci, che per qualche strana combinazione di intuizioni e di emozioni – non ultime quelle che suscita la foto in copertina, di
Originale e accattivante: sono questi i due pregi del romanzo di Ballestracci, che per qualche strana combinazione di intuizioni e di emozioni – non ultime quelle che suscita la foto in copertina, di 