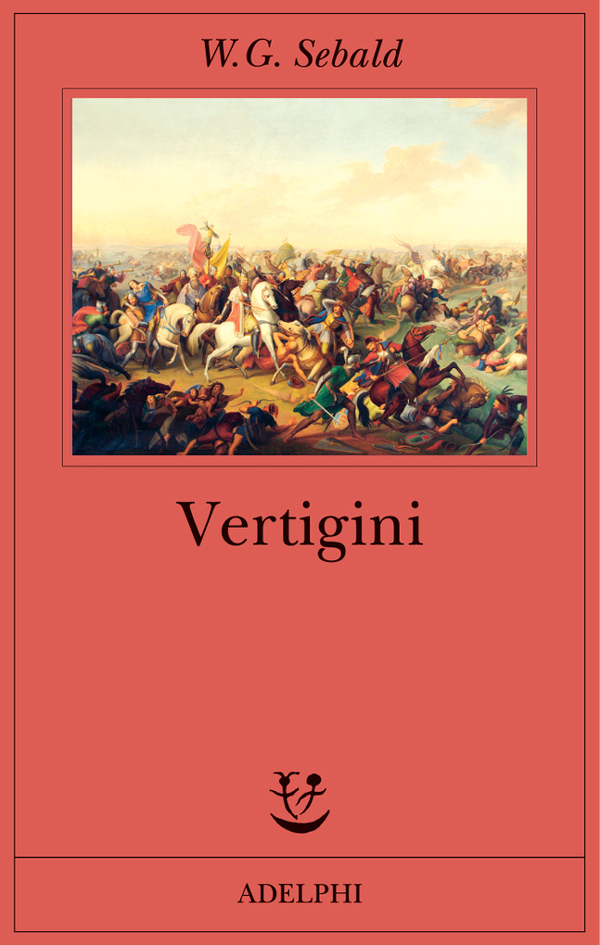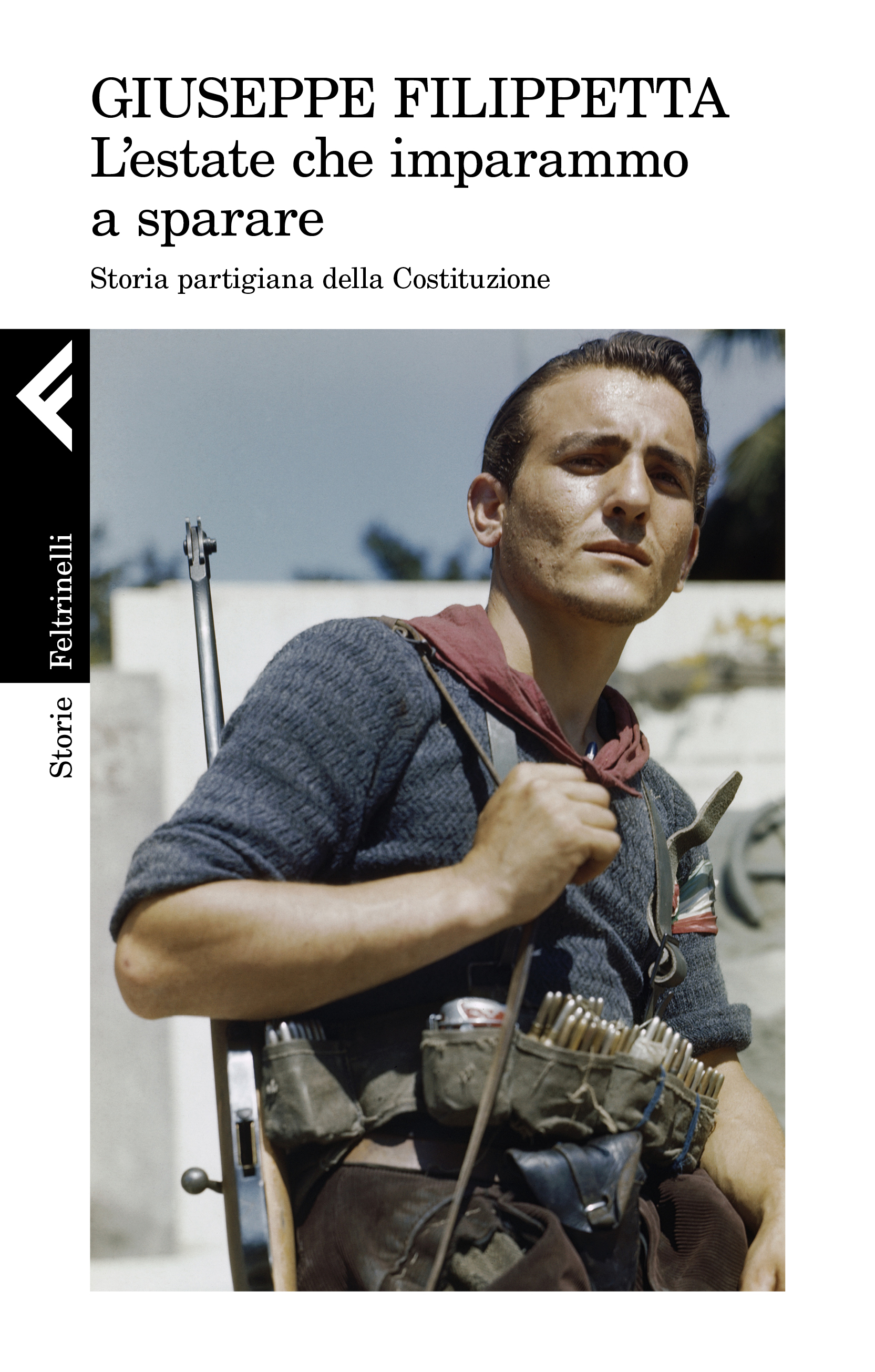In questo libro si racconta la vita irregolare e sfortunata di Dino Campana, l’autore dei Canti Orfici, nato nel 1885 a Marradi, sull’Appennino tosco-romagnolo, e morto nel 1932 a Scandicci, nell’ospedale psichiatrico di Villa di Castelpulci. Vassalli ha dedicato tantissimo tempo alla storia del poeta: è stato più volte nei suoi luoghi; ha cercato e studiato per anni, e meticolosamente, le pochissime carte che lo riguardano (soprattutto le “module” e i provvedimenti giurisdizionali con cui è stato spedito a più riprese in manicomio); ha scandagliato l’ambiente familiare e le relazioni difficilissime con la madre Fanny; ha letto, contestualizzato e confutato le testimonianze e i pregiudizi dei biografi, di chi lo aveva conosciuto, dei benpensanti di Marradi e dei compagni dell’università; ha ricostruito i tanti viaggi all’estero, i soggiorni fiorentini, i vagabondaggi, le poche amicizie, i rapporti conflittuali con i letterati e gli artisti emergenti (Papini, Soffici, Carrà); e naturalmente ha scavato nel rapporto passionale e totalizzante che Dino ha avuto con Rina Faccio (la famosa Sibilla Aleramo, femme fatale celeberrima per i suoi contemporanei). Questa frequentazione, per Vassalli, è stata costante. Ha funzionato come fonte di ispirazione, spingendolo a raccogliere e pubblicare, di Campana, poesie, lettere e prose.
La notte della cometa, peraltro, è testo che, sin dalla prima apparizione nel 1984, ha suscitato molte reazioni, spesso positive, talvolta negative. Lo rievoca lo stesso scrittore in Natale a Marradi, il pezzo pubblicato autonomamente nel 2008 e posto in appendice all’edizione einaudiana del 2017. Quale può essere stata, per i più critici, la colpa di Vassalli? Non certo quella di aver dato alla luce un ottimo libro, che con i suoi piccoli capitoli quasi si legge come un diario e tenta l’immedesimazione più puntuale con il percorso esistenziale del poeta e, direttamente, con le sue parole e con la loro intrinseca forza evocativa. Vassalli è davvero riuscito a isolare le tappe della ricerca di Campana, nella sua irresistibile tensione all’immersione nel paesaggio, e nelle emozioni e immagini più forti della vita; ne ha colto l’istintiva e pervicace volontà di rifondazione, personale come umana, nel senso più universale del termine. Dunque, secondo l’Autore – che è rimasto assai colpito dagli interventi talvolta pretestuosi dei detrattori – il suo approfondimento narrativo porterebbe una sola responsabilità, quella di aver cercato di sottrarre Campana alle leggende che lo hanno sempre voluto soprattutto e irrimediabilmente pazzo.
Oggi si può sicuramente affermare che quest’ultimo è il merito più grande del volume. Perché Vassalli, in effetti, ha seguito un’altra traccia: ha evidenziato l’ostilità costante della madre di Dino, la diversità avversata e ridicolizzata dai paesani, l’ambiguità dei riscontri clinici e la probabilissima morte per sifilide. Quello de La notte della cometa, dunque, non è il ritratto di un malato mentale: è la tragica parabola di un grande incompreso, di un uomo fondamentalmente solo, e discriminato pure da chi gli era più vicino, in un tempo in cui la stranezza veniva trattata sistematicamente come un problema di sicurezza pubblica e di onorabilità, e come la premessa della patologia più profonda e paurosa. Vassalli ci ha rammentato, ascoltando da vicino il grido espresso di Campana, che esiste un’enorme differenza tra chi è grande poeta, celebrato ufficialmente dagli allori, e chi, invece, non vive tutto intero nel suo presente, ma è “ombra di eternità”, “fuori del tempo e dei suoi traffici”. Più di ogni cosa, però, Vassalli ha dato voce pulsante all’Italia del primo Novecento, alla sua strutturale arretratezza, alla tortuosità che un talento eccentrico e autodidatta doveva fronteggiare anche solo per potersi palesare. La notte della cometa, in fondo, è uno straordinario pezzo di storia sociale. E pure per questa ragione è libro da leggere, meditare e rileggere ancora.