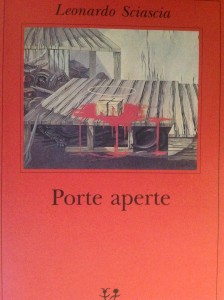 Palermo, 1937. La Corte d’assise è chiamata a giudicare “un uomo che aveva ucciso tre persone in un breve giro di ore”: nell’ordine, “la moglie dell’assassino; l’uomo che dell’assassino aveva preso il posto nell’ufficio da cui era stato licenziato; l’uomo che, al vertice di quell’ufficio, ne aveva deciso il licenziamento”. Quest’ultimo era un notissimo avvocato, presidente dell’Unione Provinciale Fascista Artisti e Professionisti, pezzo grosso del partito, dunque, ma anche influente amministratore delle cose pubbliche locali. I fatti, peraltro, sono chiari, e i legali dell’imputato non chiedono neanche la perizia psichiatrica. L’opinione pubblica, poi, sembra schierata a favore di un solo esito, da tutti percepito come giusto e inevitabile: la condanna a morte, reintrodotta dal Codice Rocco del 1930 anche per alcuni gravi reati comuni; per continuare, cioè, a dormire “con le porte aperte”, come vuole la “suprema metafora dell’ordine, della sicurezza, della fiducia”. Però, nonostante i messaggi allusivi e trasversali ricevuti in tal senso anche per bocca del procuratore generale, il giudice a latere nutre forti dubbi. La pena capitale non lo convince, e le perplessità aumentano anche per le sollecitazioni e le letture che egli finisce per condividere con uno dei giurati. Lo scrupolo vincerà la battaglia, ma non la guerra, che, alla fine, riporterà tutto – compreso il “piccolo giudice” – ad una sconsolante e umana proporzione.
Palermo, 1937. La Corte d’assise è chiamata a giudicare “un uomo che aveva ucciso tre persone in un breve giro di ore”: nell’ordine, “la moglie dell’assassino; l’uomo che dell’assassino aveva preso il posto nell’ufficio da cui era stato licenziato; l’uomo che, al vertice di quell’ufficio, ne aveva deciso il licenziamento”. Quest’ultimo era un notissimo avvocato, presidente dell’Unione Provinciale Fascista Artisti e Professionisti, pezzo grosso del partito, dunque, ma anche influente amministratore delle cose pubbliche locali. I fatti, peraltro, sono chiari, e i legali dell’imputato non chiedono neanche la perizia psichiatrica. L’opinione pubblica, poi, sembra schierata a favore di un solo esito, da tutti percepito come giusto e inevitabile: la condanna a morte, reintrodotta dal Codice Rocco del 1930 anche per alcuni gravi reati comuni; per continuare, cioè, a dormire “con le porte aperte”, come vuole la “suprema metafora dell’ordine, della sicurezza, della fiducia”. Però, nonostante i messaggi allusivi e trasversali ricevuti in tal senso anche per bocca del procuratore generale, il giudice a latere nutre forti dubbi. La pena capitale non lo convince, e le perplessità aumentano anche per le sollecitazioni e le letture che egli finisce per condividere con uno dei giurati. Lo scrupolo vincerà la battaglia, ma non la guerra, che, alla fine, riporterà tutto – compreso il “piccolo giudice” – ad una sconsolante e umana proporzione.
Il segreto di Sciascia, della sua grandezza, non è facilmente afferrabile. D’altra parte è un segreto, che tale deve restare, fascinoso. Si nasconde sempre nella lingua, nell’uso accorto dell’italiano scritto e cólto, alla maniera dei grandi siciliani del Novecento: Brancati, Consolo, Bufalino… La disciplina dello stile e della parola ne è il fortino, ma anche la chiave, complicatissima e allusiva, veicolare e pur sostanziale, in un’unica soluzione espressiva. Questa disciplina segue e corrisponde ad un rigore tutto interiore. La letteratura e la morale, così, dialogano in un contrappunto che non si può mai interrompere; soprattutto, in un flusso, cui la coscienza – individuale, sociale, civile e politica – deve alimentarsi, per affrontare le astuzie apparentemente invincibili del malaffare e del potere che gli si asservisce quasi inesorabilmente. Il problema ha una dimensione filosofica, totalizzante, non si risolve soltanto nella critica al sistema mafioso o al fascismo (al quale, in questo libro, Sciascia dedica alcuni passaggi memorabili: v. specialmente alle pp. 71-73). E non si rivolge neppure alla sola pena di morte, la cui barbarie, tornata anche di recente all’attenzione delle cronache, viene denunciata con rara e sensibile acutezza europea, ben al di là di quanto ci è stato consegnato in tempi recenti dai più illuminati interpreti d’oltreoceano. Quel problema – che trova un suo naturale spazio d’elezione nel foro interno di ciascuno – ha anche un protagonista e un luogo istituzionali, che vengono introdotti subito anche dalla citazione che avvia Porte aperte, presa di peso dai famosi Soliloqui di Salvatore Satta: “il processo si pone con una sua propria autonomia di fronte alla legge e al comando, un’autonomia nella quale e per la quale il comando, come atto arbitrario di imperio, si dissolve, e imponendosi tanto al comandato quanto a colui che ha formulato il comando, trova, al di fuori di ogni contenuto rivoluzionario, il suo ‘momento eterno’”. Viene coinvolto, in tal modo, il giudice, con il suo ruolo, il suo carattere (in tutto e per tutto) decisivo, e quindi con la sua esemplarità, vera ragione dell’interesse ricorrente, per Sciascia, nei confronti della funzione giurisdizionale e dei i suoi abissi, come già dimostrato nella bellissima introduzione alla manzoniana Storia della colonna infame.
 Dal romanzo passo al film, pluripremiato, che ne aveva tratto Gianni Amelio, con un maturo Gian Maria Volonté (in grande spolvero) nei panni del giudice dubbioso. La curiosità è soddisfatta, perché si tratta di un’ottima prova: nella fotografia, nelle luci, nella scelta di un generale clima di disfacimento che forse ben si addice all’esigenza – che sicuramente sentivano il regista e gli sceneggiatori – di ricostruire un’ambientazione storica e sociale adeguata, ma anche di renderla immagine di un Paese ripetutamente sotto scacco (ancora non resisto alla tentazione di paragonare le dimensioni dell’ufficio dell’avvocato ucciso a quelle dello studio dell’imprenditore Nottola, ne Le mani sulla città di Francesco Rosi…). Nel lavoro di Amelio, però, la grandezza di Sciascia quasi scompare, perché il suo segreto è scopertamente sciolto in direzioni ben precise, di critica culturale e politica, al di qua, per così dire, del profilo esistenziale che l’opera letteraria voleva mettere al centro della scena. In quella cinematografica, infatti, le parti si invertono: non sono le cose e le persone a cooperare a favore dello sviluppo del tema; è il tema ad adattarsi alle esigenze di certi contesti e di certe figure, allo scopo, dominante, di dire molto sulla situazione e sul clima di un determinato periodo o di un determinato modello sociale, e per dire (anche) dell’altro (ma) soltanto in chiave di resistente posizione intellettuale. Il che, per intendersi, non è di poco momento, visto che, forse, la strada indicata da Sciascia è ancora troppo complessa.
Dal romanzo passo al film, pluripremiato, che ne aveva tratto Gianni Amelio, con un maturo Gian Maria Volonté (in grande spolvero) nei panni del giudice dubbioso. La curiosità è soddisfatta, perché si tratta di un’ottima prova: nella fotografia, nelle luci, nella scelta di un generale clima di disfacimento che forse ben si addice all’esigenza – che sicuramente sentivano il regista e gli sceneggiatori – di ricostruire un’ambientazione storica e sociale adeguata, ma anche di renderla immagine di un Paese ripetutamente sotto scacco (ancora non resisto alla tentazione di paragonare le dimensioni dell’ufficio dell’avvocato ucciso a quelle dello studio dell’imprenditore Nottola, ne Le mani sulla città di Francesco Rosi…). Nel lavoro di Amelio, però, la grandezza di Sciascia quasi scompare, perché il suo segreto è scopertamente sciolto in direzioni ben precise, di critica culturale e politica, al di qua, per così dire, del profilo esistenziale che l’opera letteraria voleva mettere al centro della scena. In quella cinematografica, infatti, le parti si invertono: non sono le cose e le persone a cooperare a favore dello sviluppo del tema; è il tema ad adattarsi alle esigenze di certi contesti e di certe figure, allo scopo, dominante, di dire molto sulla situazione e sul clima di un determinato periodo o di un determinato modello sociale, e per dire (anche) dell’altro (ma) soltanto in chiave di resistente posizione intellettuale. Il che, per intendersi, non è di poco momento, visto che, forse, la strada indicata da Sciascia è ancora troppo complessa.
La morte come pena in Leonardo Sciascia (un convegno, da Radio Radicale)
Porte aperte, dal romanzo di Sciascia al film di Gianni Amelio (di Giuseppe Panella)

