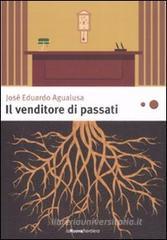Che dire di Giorgio Vigolo? Il primo impatto, più di trent’anni fa, non era stato proprio positivo. Le sue traduzioni di Hölderlin mi erano parse difficili, forse un po’ artificiose e quasi démodé, tanto che da allora gli ho sempre preferito Enzo Mandruzzato. Ma di fronte a quelle pagine, l’attrito, fonte come sempre di una ostinata curiosità, mi ha condotto subito alla magnifica edizione mondadoriana dei sonetti del Belli. È lì che ho cominciato a conoscere Vigolo veramente – così colto, così sofisticato – scoprendo anche che è stato egli stesso un raffinatissimo poeta (a proposito: lo scorso anno Le Lettere ha compilato una suggestiva selezione di alcuni dei suoi pezzi migliori). Mai, però, avevo ancora letto i racconti de Le notti romane. Li ho recuperati, casualmente, nell’edizione originaria Bompiani del 1960, sulla cui copertina cartonata campeggia (azzeccatissima) la riproduzione di un quadro di Eugène Berman, Il grande palazzo d’angolo. L’opera è stata riedita nel 2015 da EdiLet.
Si tratta di testi sospesi tra il ricordo fantastico e deformato (Il guardacaccia, Il Plutone casareccio, Il mistico luccio, Il pavimento a figurine), la rievocazione onirica di epoche e riti del passato (Le notti romane, La cena degli spiriti), il richiamo ispirante di spazi e atmosfere di una città che è presente quanto remota (Avventura a Campo dei fiori, La bella mano), e l’introspezione autoanalitica (Il palazzo di campagna, Un invito a pranzo, Il nome del luogo). Alcune trame e atmosfere sono degne del migliore Edgar Allan Poe. Ma il titolo del volume riecheggia un illustrissimo, italianissimo precedente. E la Roma che vi fa da sfondo, in effetti, è città passatada tempo, se non da secoli. Meglio, è fuori dal tempo e basta, visto che è questo che postula l’ostinata e inattuale visione dell’Autore. Che, tuttavia, parte sempre da un tuffo personale e profondo in un dettaglio o in un’immagine, alla ricerca delle radici dei luoghi e della storia, tra le leggende e le voci che hanno incorporato e che possono far provvidamente riemergere, solo al volerli cercare. O, piuttosto, al volervisi abbandonare, come accade nel sonno e nel sogno, anche quando avviene ad occhi aperti, esplorando vie, piazze, mercati, edifici e squarci di cielo.
La sensibilità di Vigolo, eremita di Roma, è tutta compendiabile in questa attitudine costantemente contemplante: “Allora, rallento il passo e mi metto a scrutare, con attenzione estrema, facciate, porte e vetrine; questo mi procura, sulle prime, momenti di vera delizia e il movimento interno, ingenuo, d’una speranza che ondeggi dentro di me e mi sollevi e mi porti sú, nell’aria magica e rubata di quella irripetibile avventura. Poi il ricadere è amaro, in fondo ai duri letti di strade della città, di nuovo svanita al vero, tornata al falso di tutti i giorni che sembra si possa toccare e invece non esiste affatto” (da Autobiografia immaginaria, p. 64). È esattamente così. Per questo scrittore – il cui stile denso ed elegante si è forgiato nella lingua erudita della prima metà del Novecento – il presente quotidiano è ciò che di più distante vi può essere. La realtà, infatti, con la verità che porta con sé, si nasconde agli occhi dei più, perché ha fondamenta misteriose, che solo l’invenzione letteraria può toccare.
Recensioni (di M. Onofrio; di A. Ronci)
Alcune poesie di Vigolo, su YouTube